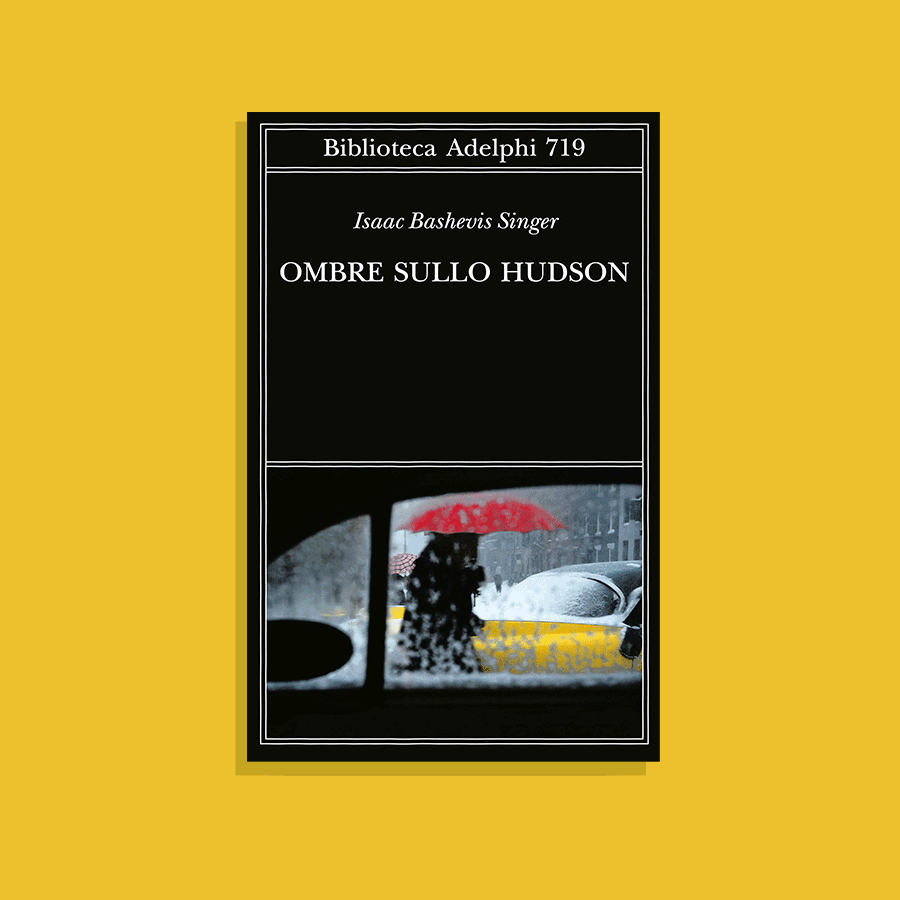
Nei romanzi di Isaac Bashevis Singer c’è sempre un antefatto: l’olocausto degli ebrei. Le storie che Singer racconta sono quello che viene dopo, il secondo tempo di una tragedia che via via prende le forme e i colori della commedia, talvolta della farsa. Pubblicato a puntate su “The Jewish Daily Forward” e poi in volume nel 1957 in lingua yiddish, “Shadows on Hudson” – in italiano “Ombre sullo Hudson”, con quella strana preposizione articolata che non diventa tronca – è forse la migliore opera lasciataci da questo premio Nobel mezzo polacco e mezzo newyorkese, che con il fratello Israel, Bernard Malamud, Saul Bellow e Philip Roth, forma la spina dorsale della grande narrativa ebraica americana. Cosa vuol dire essere ebrei nel Nocevento secolarizzato degli Stati Uniti d’America è l’interrogativo che accompagna ogni personaggio di Singer, tutti infelici, ma anche i suoi lettori. “La religione è fallita, tutte le religioni lo sono. Dio non si è rivelato a nessuno, né ha mai detto cosa vuole…” L’amara conclusione del dottor Solomon Margolin – a cento pagine dalla fine – il più disilluso dei protagonisti e controvoce di una coscienza laica, dà il senso e la misura di cosa ci apprestiamo a leggere in questo libro, lungo, a tratti faticoso, noioso, ma denso di spunti di altissima letteratura e di archetipi che ritroveremo in altri autori più giovani, quelli appena citati. Sì, perché quando arrivi a Isaac Bashevis Singer dopo aver letto tutto o quasi tutto di Roth, Bellow e Malamud, ti sembra di risalire un fiume partendo dal suo estuario. “Ombre sullo Hudson” racconta di un gruppo di ebrei polacchi e tedeschi approdati a New York negli anni Quaranta dello scorso secolo, dopo essere sfuggiti alla furia nazista. Boris Makaver, il più anziano e ortodosso di tutti, è un ricco uomo d’affari dell’Upper West Side, vedovo, con una figlia, Anna, che, nonostante la giovane età, ha già alle spalle due matrimoni finiti. Anna ora flirta con Hertz Grein, un broker di Wall Street, anche lui sposato con figli, donnaiolo sì ma con poca convinzione. Hertz è il primo attore del romanzo. Sua moglie, Leah lo ama con devozione, lui la ricambia tradendola prima con Esther, poi con Anna, poi con entrambe nello stesso tempo. Hertz crede nel Dio di Abramo, ma tradisce anche lui: l’infinita crisi di coscienza di Grein occupa due terzi del libro “Credeva in Dio, ma la fede non basatava. Gli mancavano i fondamenti…Non era in grado di vivere con Dio, ma non poteva neppure immaginare una vita senza di Lui.” Grein è quello che diventerà Henry Zuckerman ne “La controvita” di Philip Roth, e Seymour Levov nell’altro capolavoro di Roth: “Pastorale americana” – il dialogo tra padre e figlia, Anita, improvvisamente adulta e amante di un comunista ribelle, rende bene l’idea del conflitto feroce che si consuma nel romanzo dello scrittore di Newark, anche lui di origine polacca come Singer: ecco gli archetipi di cui vi parlavo. Nel cast di Singer non mancano altre figure grottesche e stravaganti, disorientate dall’edonismo americano, dal frastuono e dalla solitudine che li spinge a rimuginare, ritornare, riannodare i fili di un passato che non sarà mai lo stesso. Cosa attende Boris, Anna, i suoi ex mariti? Cosa ne sarà, soprattutto, di Hertz Grein? “Non sono diventato osservante. Ben lungi. Ma senza Dio ci si annoia. La fede è l’unica cosa che ci salva dalla follia.”
Angelo Cennamo
