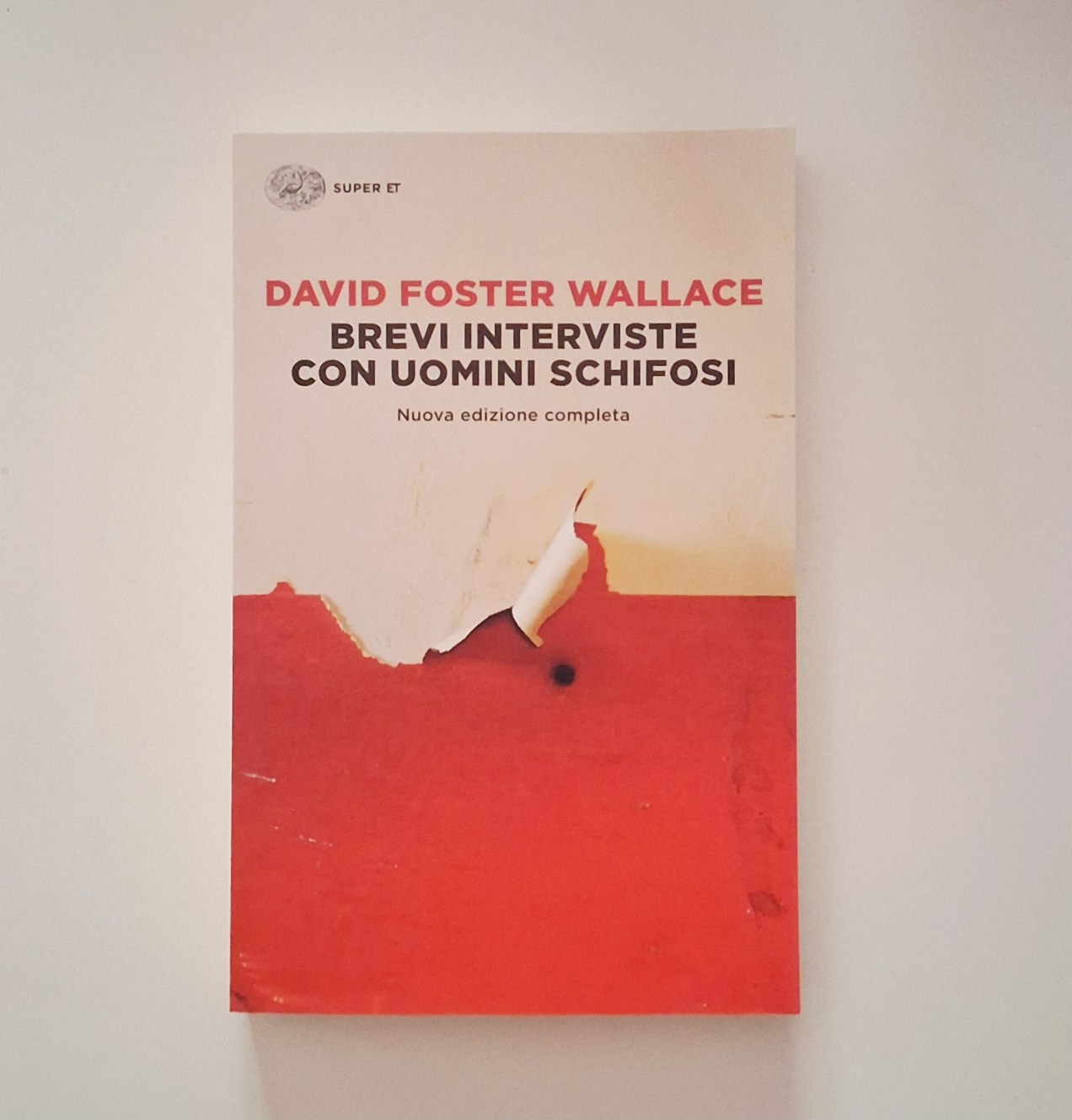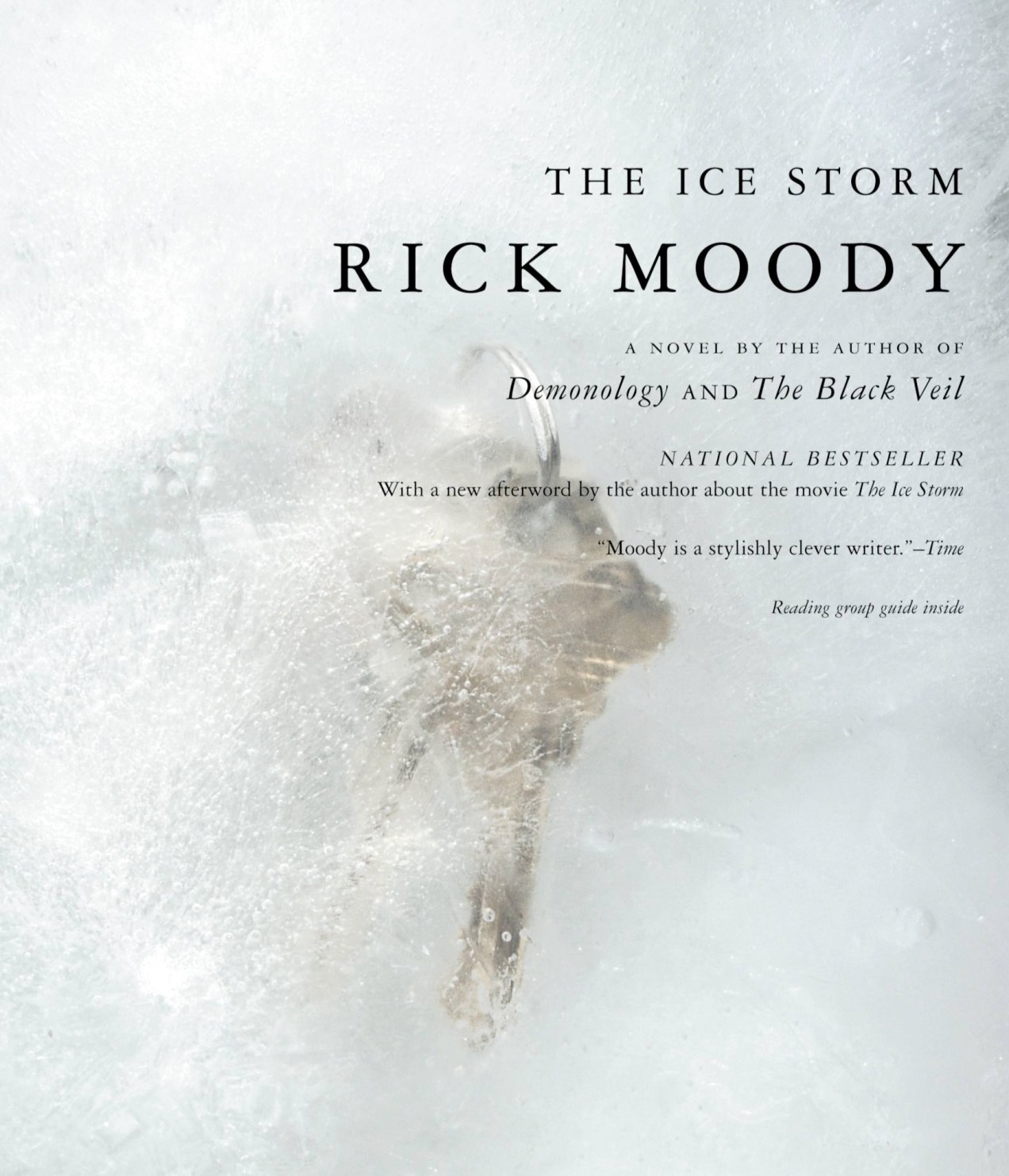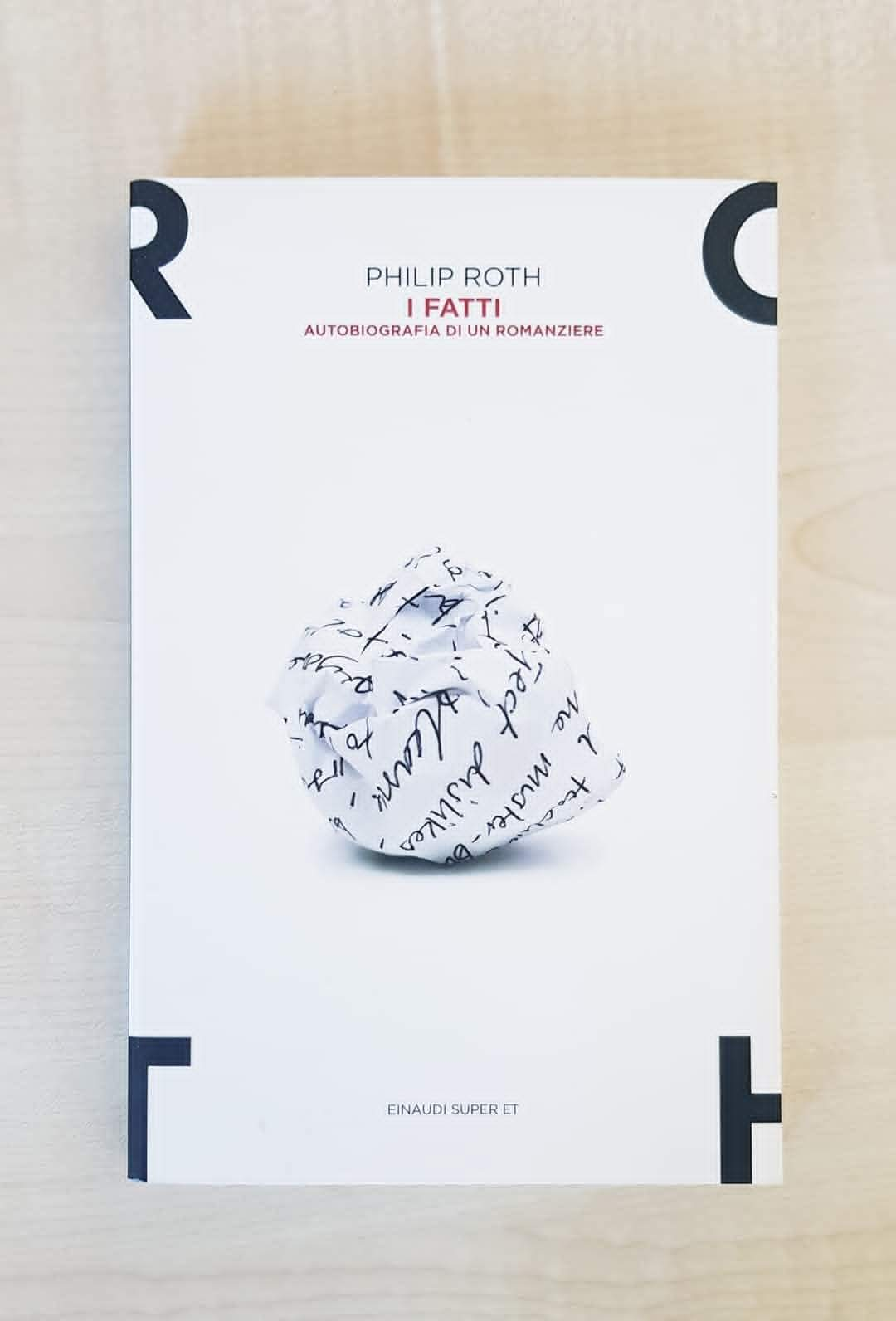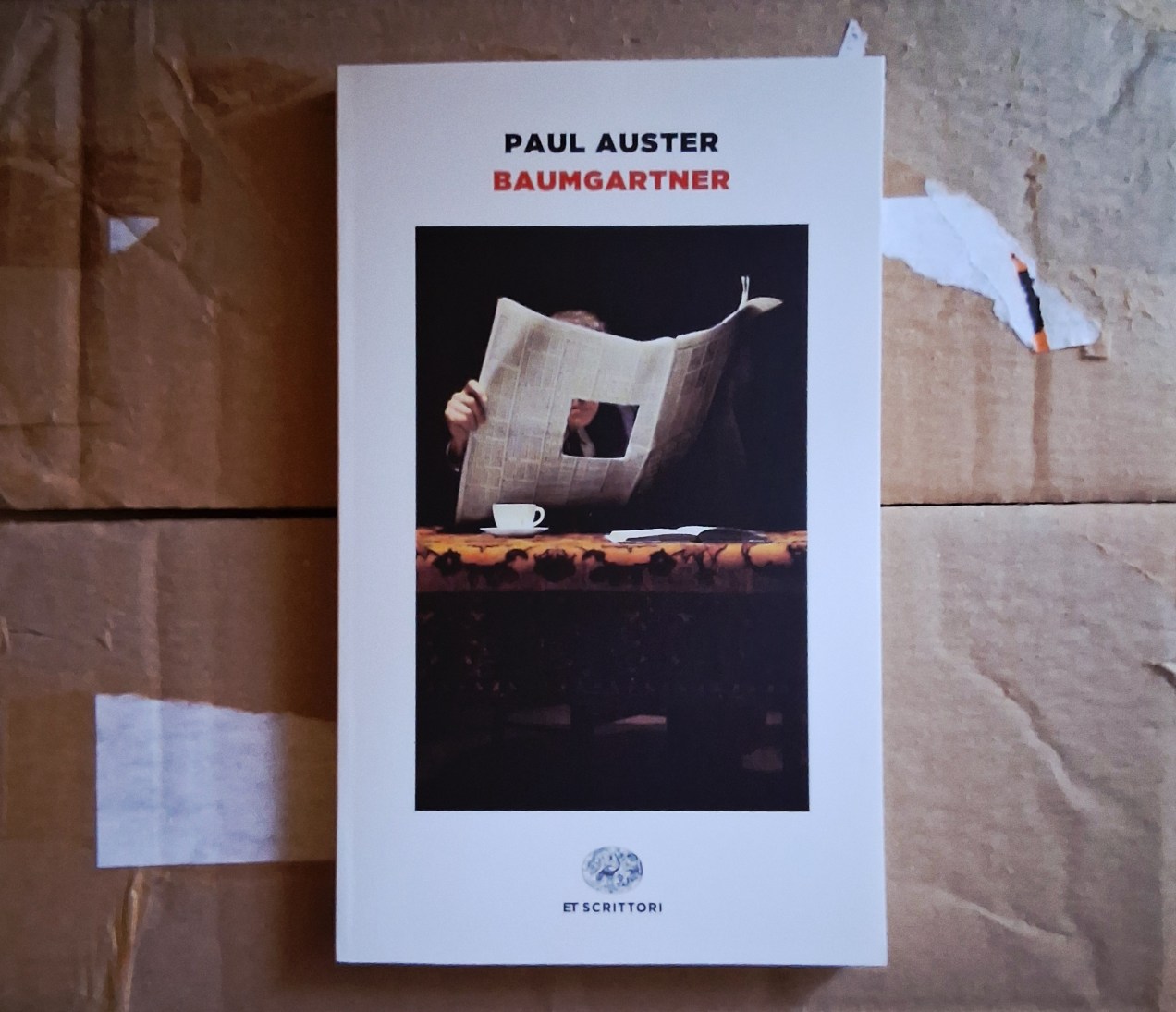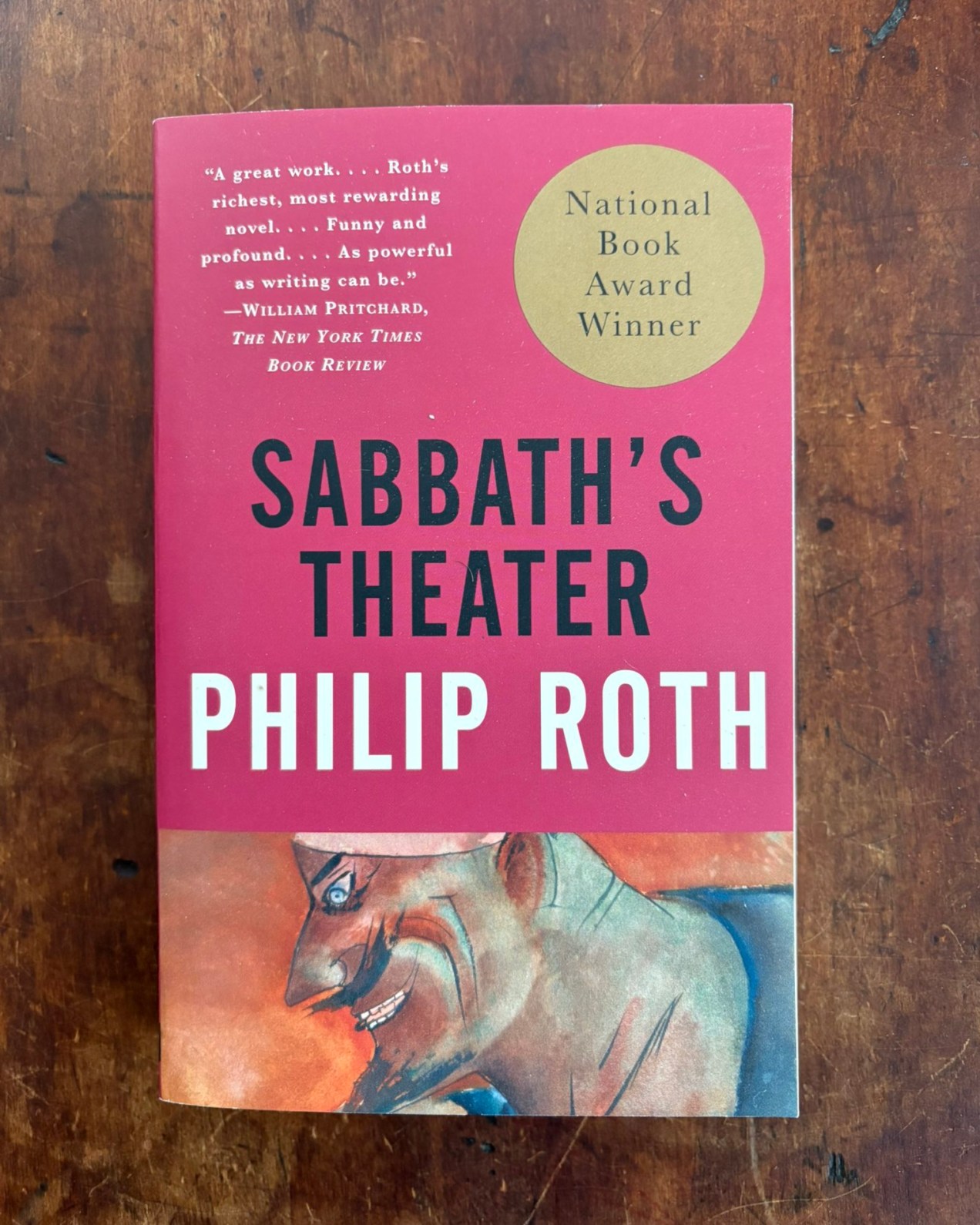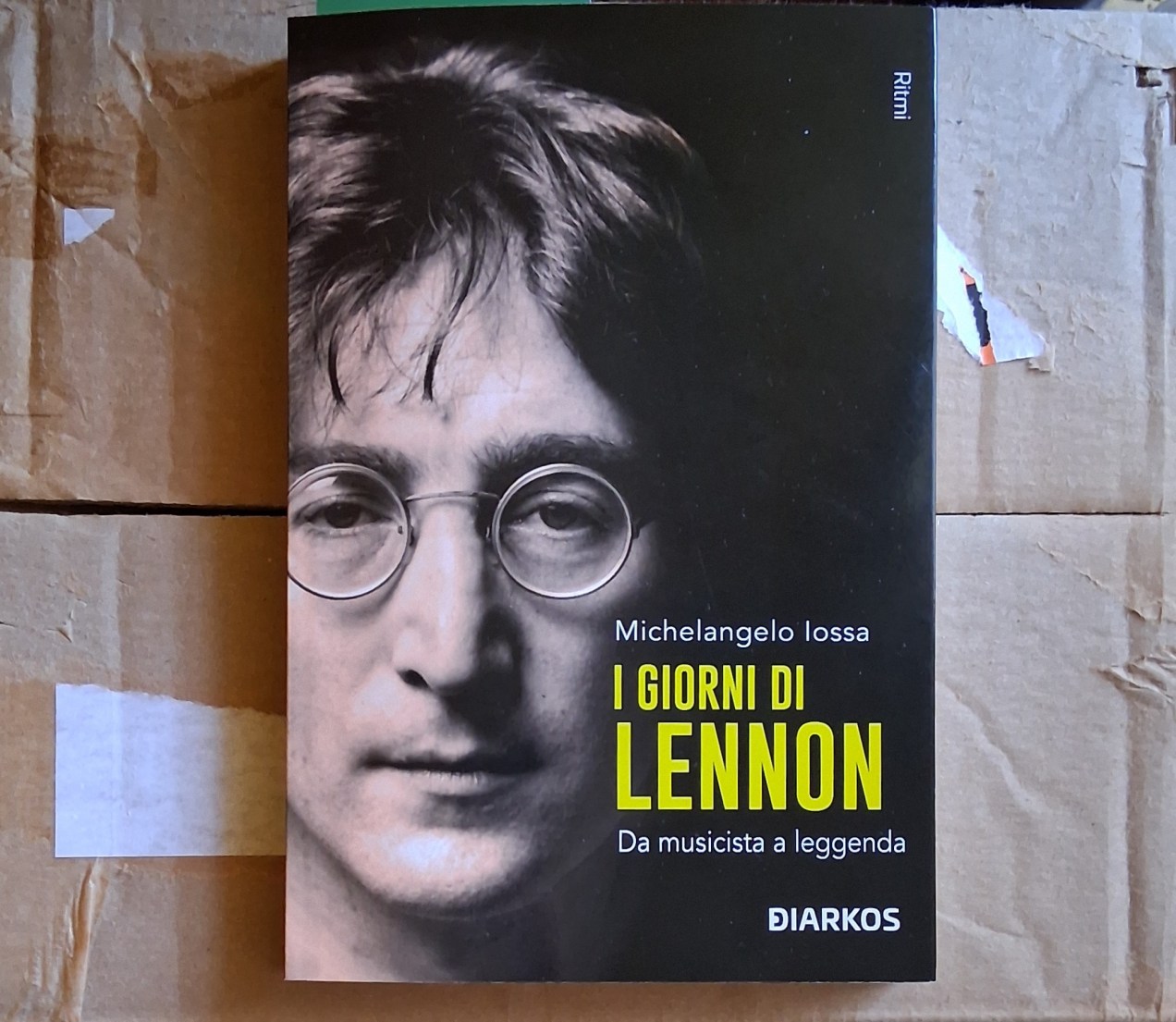C’è una vecchia parabola, a metà tra calcolo delle probabilità e vertigine filosofica: un numero infinito di scimmie, davanti a un numero infinito di tastiere, finirebbe prima o poi per scrivere Shakespeare. Con David Foster Wallace si ha talvolta l’impressione di assistere a quell’istante improbabile in cui il rumore diventa forma. Non è il caos che, per caso, si trasforma in ordine; è piuttosto un eccesso di coscienza che cerca una struttura capace di sostenerlo. La scrittura procede per accelerazioni improvvise, deviazioni, accumuli; poi, all’improvviso, si concentra in una frase netta, necessaria. Non è disordine, ma una complessità disciplinata. Con Infinite Jest, Wallace aveva dimostrato di poter governare quella pressione su scala monumentale. Il romanzo costruisce un sistema autosufficiente, un’America appena spostata in avanti nel tempo, dove intrattenimento, dipendenza, politica e malinconia culturale si intrecciano in un equilibrio instabile ma rigoroso. È un testo che ingloba linguaggi, saperi e gerghi diversi e li organizza in una struttura che, pur labirintica, non è mai casuale. L’eccesso diventa metodo. Tre anni dopo, con Brevi interviste con uomini schifosi, l’energia si concentra in una forma diversa. Non più la costruzione di un continente narrativo ma un lavoro di dissezione. La raccolta rinuncia alla panoramica per concentrarsi sulla voce; abbandona la coralità per isolare monologhi. Il testo che dà il titolo al volume non è un racconto convenzionale, ma un dispositivo radicale: risposte senza domande. Le domande dell’intervistatore sono omesse; restano uomini che parlano a lungo, soprattutto per giustificarsi. Ed è nel tentativo di giustificazione che si rivelano. L’assenza dell’intervistatore non è un espediente neutro ma una scelta precisa. Senza contraddittorio, la parola si espone e ogni spiegazione diventa potenzialmente un’autodenuncia. I personaggi ricorrono a retoriche sofisticate, colte o apparentemente brillanti, ma i loro discorsi ruotano attorno allo stesso obiettivo: preservare un’immagine accettabile di sé. Il sesso, nei monologhi, non è un’esperienza condivisa ma uno spazio di controllo. Le relazioni diventano problemi da risolvere, strategie da ottimizzare, rischi da gestire. L’altro non è interlocutore, ma una variabile. In questo senso la raccolta può essere letta come una critica implicita a una parte della letteratura americana del Novecento, in cui il desiderio maschile veniva elevato a materia epica o a confessione lirica. Wallace non elimina l’autoanalisi: la porta al suo estremo. Mostra come l’introspezione, quando non è accompagnata da responsabilità, possa trasformarsi in una sofisticata e complicata accettazione di sé. Gli “uomini schifosi” non sono figure eccezionali, sono uomini comuni dotati di strumenti linguistici efficaci e di una coscienza capace di argomentare tutto, tranne il proprio vuoto. Ridurre il libro a un catalogo di patologie, però, sarebbe limitante. In controluce emerge una domanda più ampia: è ancora possibile una relazione autentica in una cultura che ha fatto dell’esibizione una norma? Il brevissimo testo d’apertura, Una storia ridotta all’osso della vita postindustriale, formula la questione in modo esemplare. Due persone si mostrano l’una all’altra, mettono in scena una versione di sé, poi si ritirano nella propria solitudine. La scena è minima, ma suggerisce un’idea più vasta: la vita postindustriale come successione di performance. All’interno della raccolta, alcuni racconti interrompono la struttura monologica per introdurre registri diversi. Ne La persona depressa, Wallace esplora con lucidità e ironia lo stato mentale di chi è intrappolato nelle proprie ossessioni. In Per sempre lassù, un ragazzo, nel giorno del suo tredicesimo compleanno, affronta l’angoscia di salire sul trampolino più alto della piscina: Wallace rallenta il tempo, descrive la scaletta che vibra, il sole, l’odore di cloro, trasformando l’attesa in un momento decisivo. Qui non c’è retorica di autoassoluzione né spettacolarizzazione: c’è vulnerabilitàe, esperienza diretta.
Pubblicata nel 1999, dopo La scopa del sistema e La ragazza dai capelli strani, la raccolta conferma la coerenza del progetto di Wallace. Al centro resta una questione morale: come parlare senza usare il linguaggio come schermo? Come guardare senza ridurre l’esperienza a superficie? Brevi interviste con uomini schifosi non offre risposte definitive. Mette in scena il fallimento, ma lo fa con una precisione che impedisce il compiacimento. Wallace non denuncia dall’esterno: costruisce meccanismi narrativi che costringono il lettore a sostare nell’imbarazzo, a riconoscere meccanismi familiari, a interrogare la propria retorica quotidiana. Se Infinite Jest costruiva un mondo, questa raccolta lo analizza al microscopio. E in questa analisi emerge una convinzione esigente: la forma non serve a decorare il caos, ma a renderlo comprensibile anche quando ciò che si comprende non è rassicurante.
Angelo Cennamo