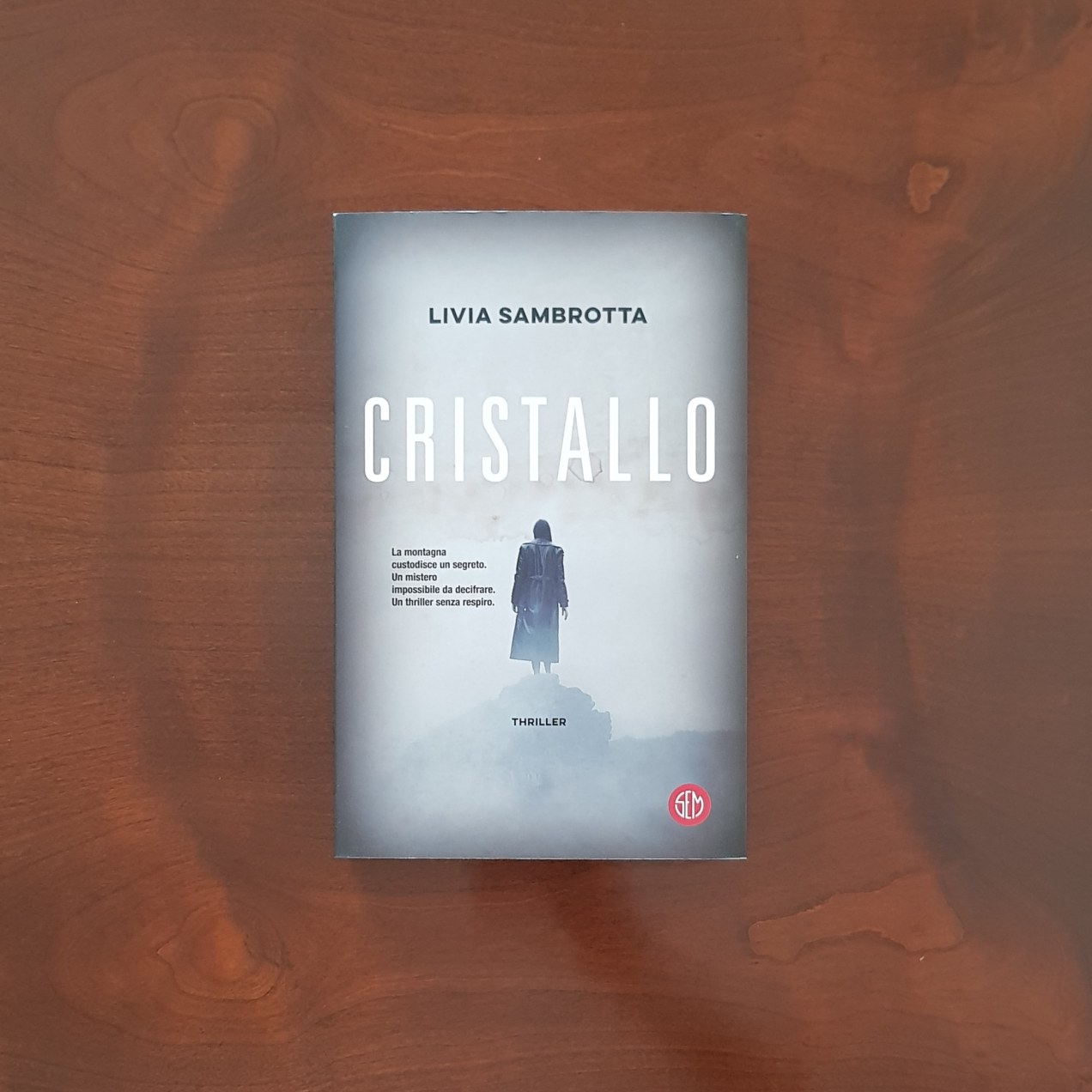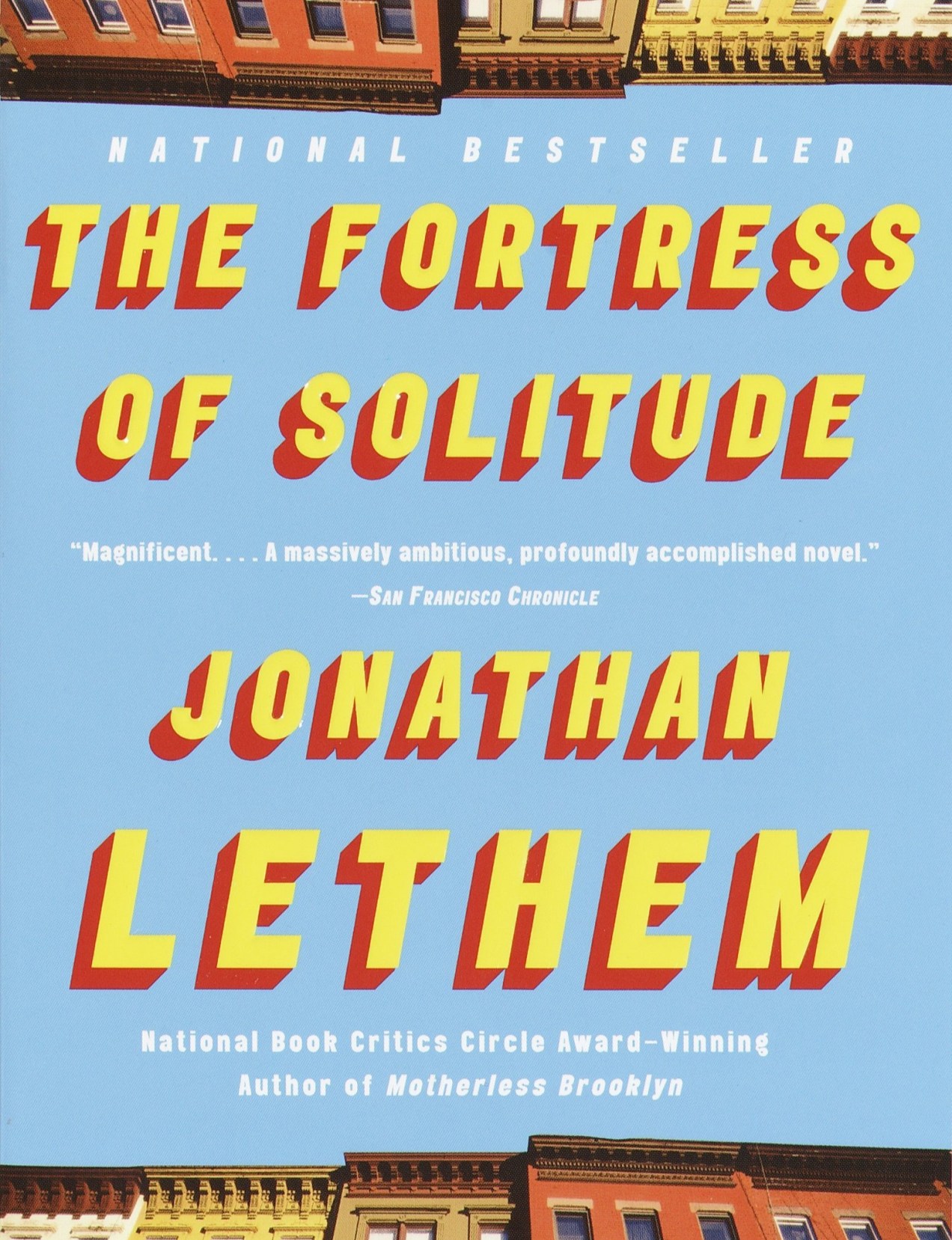Romanzo del 1969 – l’anno di Lamento di Portnoy di Philip Roth e Bullet Park di John Cheever – dalla forte impronta autobiografica, ma quale opera di Richard Yates non è un travestimento della vera vita di Yates. Bob Prentice, il giovane protagonista del libro, è una vecchia conoscenza dei lettori dello scrittore di Yonkers, nasce infatti sette anni prima con il racconto che chiude la raccolta Undici Solitudini, in Italia edito da minimum fax come tutti i libri di Yates. In “Costruttori” Bob è un ghostwriter che sogna di fare lo scrittore (per diversi anni anche Yates si è guadagnato da vivere scrivendo per altri, Bob Kennedy per esempio; e come nella nuova storia ha combattuto la seconda guerra mondiale in Europa ammalandosi di tubercolosi), con una madre che si dedica all’arte senza successo e che affoga l’insoddisfazione nell’alcol. Uno dei tratti ricorrenti nelle storie tristi e disturbanti di Yates è proprio l’alcolismo nel quale precipitano quasi tutti i protagonisti: alcol, farmaci, fumo, depressione.
Sotto una buona stella racconta di una madre (Alice) e del suo unico figlio (Bob), rimasti soli dopo il divorzio di lei e costretti a cambiare molte case e a farsi aiutare dai parenti per tirare avanti. La storia è divisa in due, con parti alternate: in una Bob lo vediamo al fronte, nell’altra è ancora bambino con sua madre. Una storia di povertà e di solitudine, tipico di Yates. Bob è un soldato scoordinato, impacciato, occhialuto, dall’aspetto quasi effemminato. Intrattiene una relazione epistolare molto colta e impegnativa con il suo amico Berlingame, che gli scrive lettere lunghissime e piene di riferimenti filosofici. Mentre Bob combatte la guerra in Europa, Alice ne combatte un’altra in America contro l’indifferenza dei tanti che non credono nel suo talento e di mariti di altre donne che la seducono per poi abbandonarla, come Sterling Nelson, che a un certo punto parte per l’Inghilterra dicendo di dover sistemare delle questioni familiari, ma non fa più ritorno. Alice è un’illusa con delle assurde manie di grandezza. Nelle ultime pagine, dopo essere stata costretta a farsi ospitare dalla sorella e dal cognato, senza un centesimo in tasca molla tutti e prende una suite in uno degli alberghi più lussuosi della città. I personaggi di Yates sono schiacciati dalla loro insolenza e da una smodata ambizione. Rincorrono sogni troppo grandi e vanno a sbattere contro l’infelicità. Il rapporto morboso tra Alice e Bob, con la madre che proietta sul figlio ansie e aspettative è una delle tracce del romanzo. Yates sa dare voce alle donne, i suoi personaggi femminili sono quelli più riusciti, in Revolutionary Road come in Easter Parade, e anche in questo romanzo: quelle dedicate ad Alice sono le parti migliori.
Angelo Cennamo