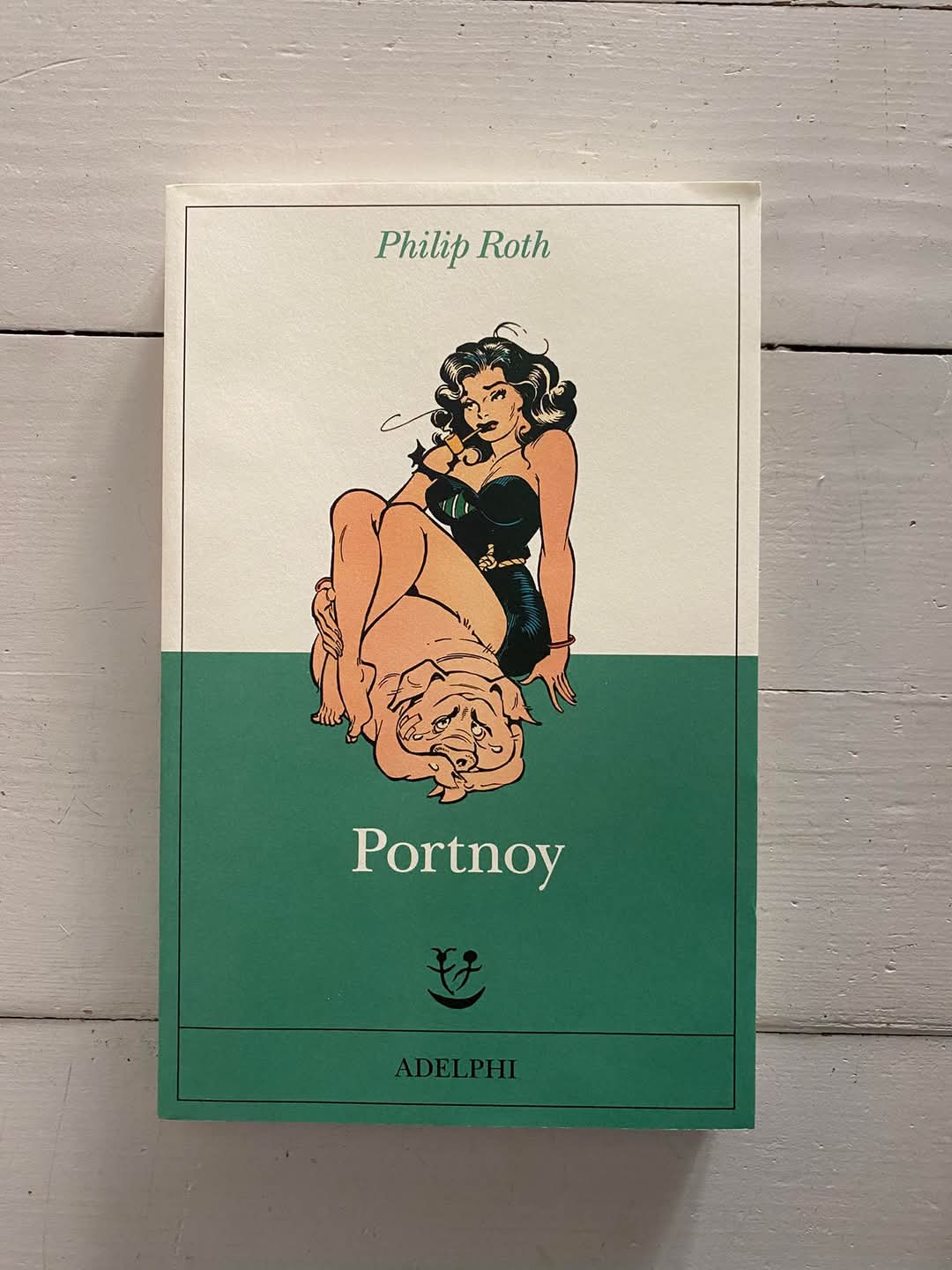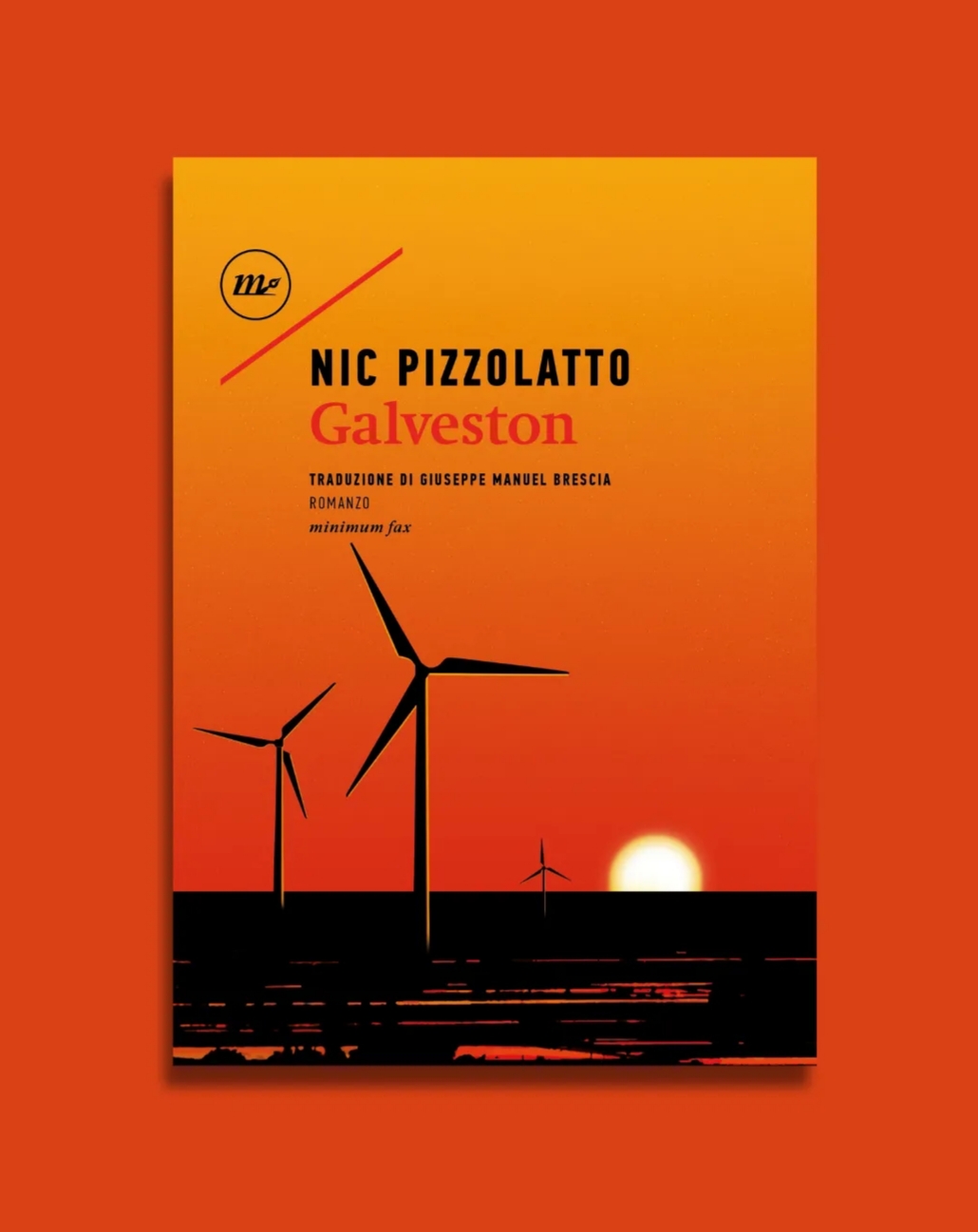American Rapture di CJ Leede – in Italia Estasi Americana con l’editore Mercurio e la traduzione di Gaja Cenciarelli – è un’opera disturbante, iperbolica, che si colloca al crocevia tra l’horror corporeo e il romanzo di formazione, e che si offre come riflessione profonda sull’identità, la fede, il desiderio e la violenza sistemica dell’educazione religiosa in America, in particolare nel Midwest rurale. Ambientato in una provincia americana dominata dal cattolicesimo più rigido e da un’etica puritana che sopravvive nei dettagli quotidiani, il romanzo segue la sedicenne Sophie Allen, cresciuta in una famiglia iper-religiosa e repressiva del Wisconsin. La sua vita è definita da un codice morale ossessivo, dove il corpo è visto come sede del peccato, la sessualità femminile come minaccia
“La bellezza è pericolosa. È una tentazione e un peccato, bisogna nasconderla, fingere che non esista, per sicurezza, per decenza, per la grazia di Dio. La bellezza delle donne attira l’oscurità. È l’oscurità”.
Il romanzo si apre su un’America colpita da un virus chiamato Sylvia, che provoca negli infetti un’esplosione di desiderio erotico incontrollabile, con derive omicide. Ma questa pandemia, più che una minaccia esterna, diventa allegoria del desiderio represso, della carnalità bandita da un’educazione violenta e colpevolizzante, e della furia che esplode quando il corpo, per troppo tempo negato, si riprende i suoi diritti. L’educazione ricevuta da Sophie non è solo religiosa: è una pedagogia del controllo e della paura, radicata in una visione patriarcale e binaria di una borghesia bigotta. Leede coglie con precisione il peso di una certa cultura del Midwest, dove la religione si intreccia a un senso di ordine, di pulizia morale e di rigida separazione tra il giusto e il peccato, e dove ogni deviazione – sessuale, identitaria, persino affettiva – è motivo di condanna e di rifiuto. Questo emerge con crudezza nel rapporto tra Sophie e suo fratello gemello Noah, espulso dalla famiglia e dall’intera comunità perché gay. La loro relazione, seppur interrotta, resta il cuore segreto del romanzo: Noah rappresenta l’assenza, ma anche la possibilità di un mondo altro, dove la libertà non è necessariamente dissoluzione, e dove l’amore non è peccato ma resistenza.
Dopo che i genitori vengono infettati e la casa si trasforma in un inferno domestico, Sophie fugge: inizia così un viaggio tra città deserte, rifugi improvvisati e comunità violente, durante il quale la ragazza incontra figure che mettono in discussione tutto ciò che le è stato insegnato. Maro, Cleo, Ben: ognuno di questi personaggi rappresenta un modo diverso di affrontare l’alterità, il trauma e la sopravvivenza. In questo itinerario, che è insieme geografico e psichico, Sophie scopre che il desiderio non è malattia ma linguaggio, che il corpo è memoria e arma, e che la religione può essere una forma di violenza quanto una maschera per il potere. Il virus, così, non è solo una minaccia biologica, ma il detonatore simbolico di un’esplosione identitaria: Sylvia agisce come uno specchio oscuro che riflette ciò che la società ha nascosto sotto il tappeto per decenni (sesso, rabbia, ribellione, vergogna). Dopo Maeve, il romanzo di esordio, CJ Leede si conferma una delle voci più interessanti ed estreme dell’horror contemporaneo. “L’horror – scrive Leede nella postfazione del romanzo – guarda negli occhi l’oscurità. Danza con l’assenza, la perdita”. Estasi Americana è un manuale di sopravvivenza alla morte delle persone e degli animali cari. Ogni frase di Leede sembra affondare nella carne viva dei suoi personaggi, mettendo a nudo paure ancestrali e desideri inesprimibili. Leede alterna la crudezza della narrazione horror – corpi che mutano, violenze apocalittiche, visioni da incubo – a passaggi intensamente introspettivi, dove il dolore e la spiritualità si fondono, suggerendo una forma di redenzione possibile solo nel caos. In questo equilibrio tra ferocia e grazia, Leede richiama due nomi cruciali della narrativa americana, appartenenti a generazioni diverse: Stephen King e Tiffany McDaniel. Da King, Leede eredita la capacità di trasformare l’orrore in specchio sociale. Come il maestro del Maine, Leede non racconta solo mostri o epidemie: racconta l’America, quella più marginale e in crisi. Alla maniera di McDaniel, Leede esplora il trauma, il significato della fede, e dell’isolamento. Da questo punto di vista, Estasi Americana è molto più di un romanzo horror: è un testo che si muove tra diversi generi e sensibilità attraverso un linguaggio feroce e brioso, che alterna immagini cupe, visioni mistiche e squarci di profonda umanità. La narrazione in prima persona filtra l’intera storia attraverso la coscienza di Sophie, rendendo tangibile il suo smarrimento, la fame di amore, il bisogno di comprendere e ricostruire se stessa. In un’America devastata non solo dalla pandemia ma dal fondamentalismo, dal sessismo e dalla solitudine, Estasi Americana non offre salvezza, ma suggerisce che nella consapevolezza del proprio corpo, nella forza dei legami autentici e nella distruzione dei dogmi, si può trovare una nuova forma di verità. È un romanzo che lacera e illumina, un grido di libertà sepolto sotto secoli di colpa e di repressione.
Angelo Cennamo