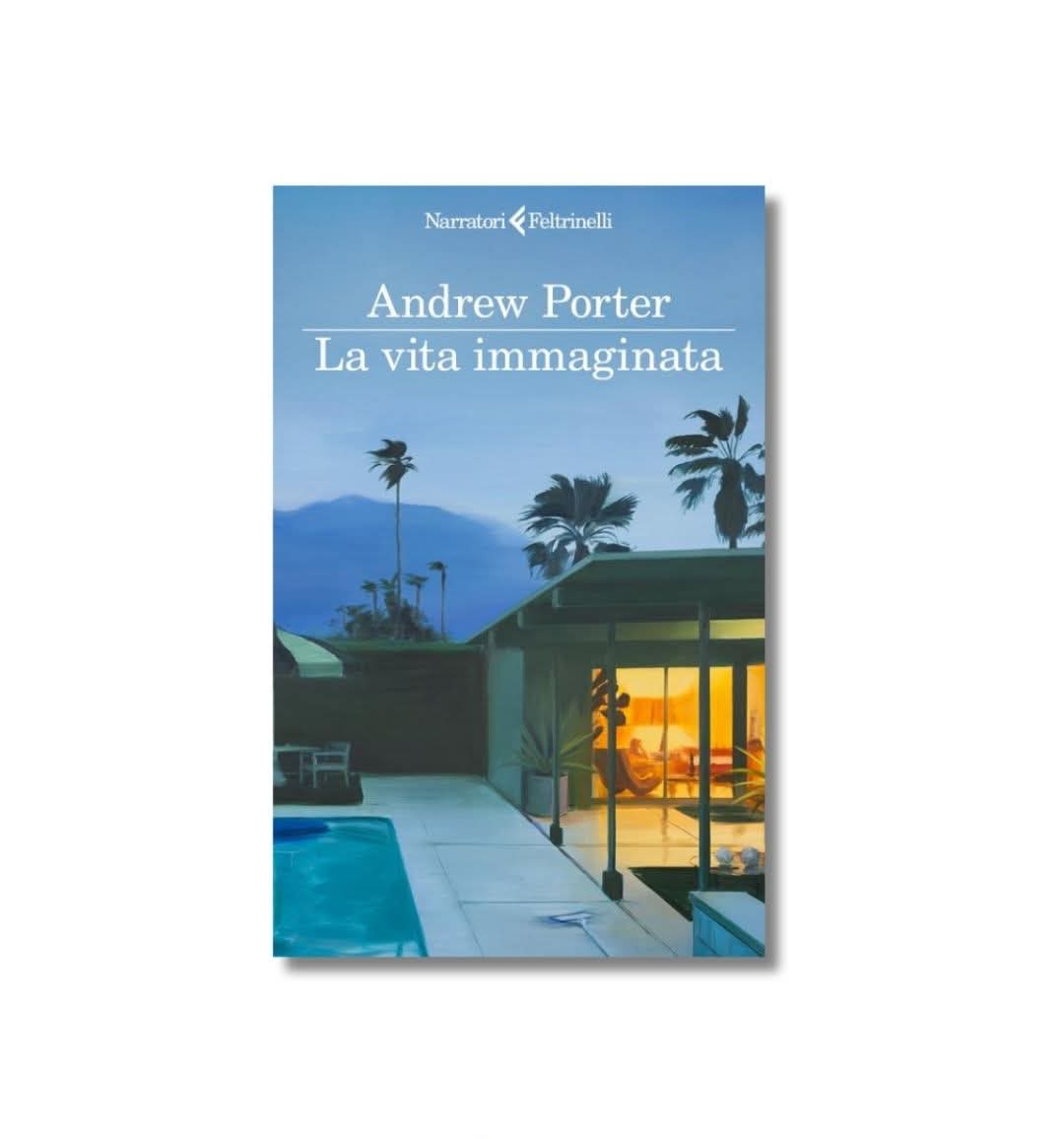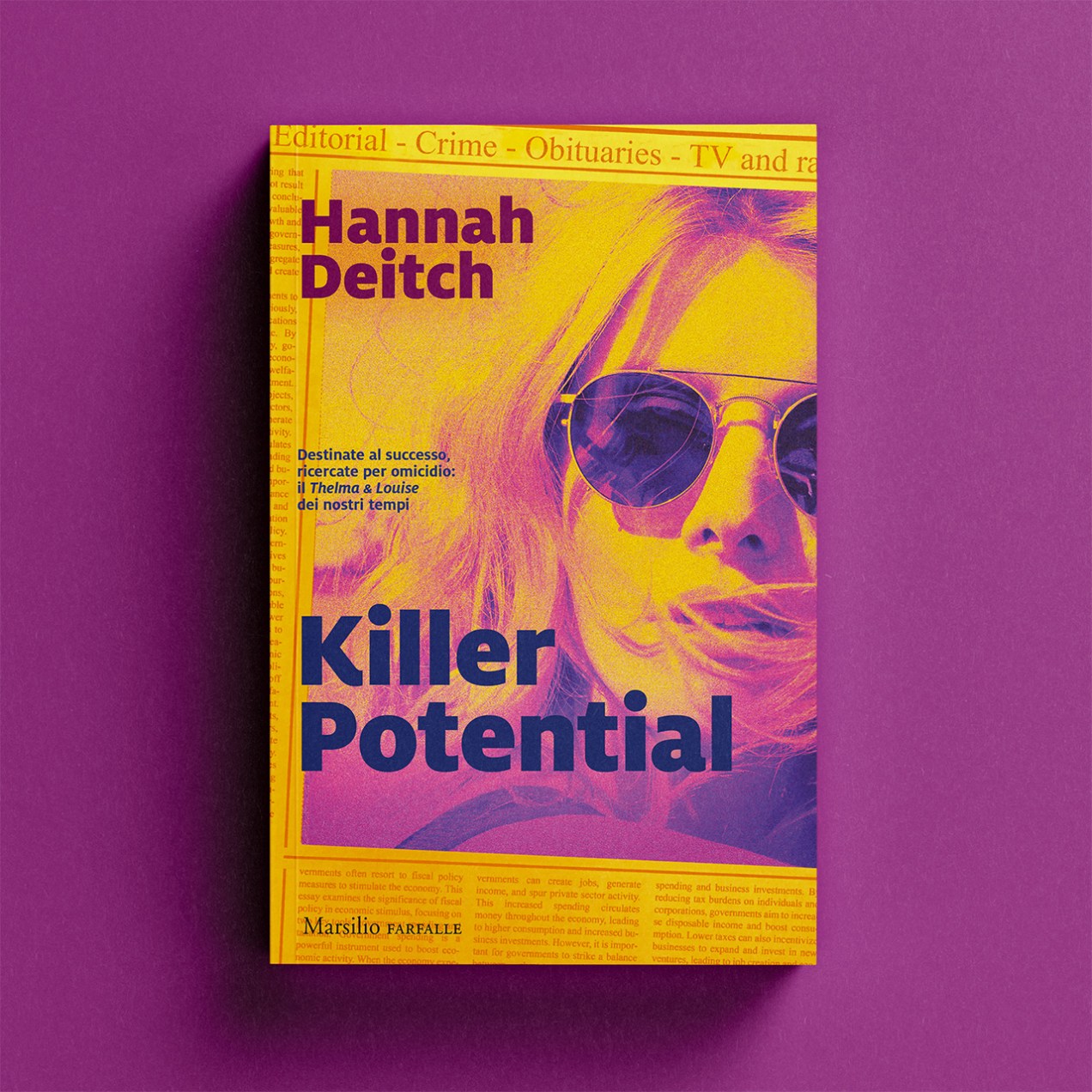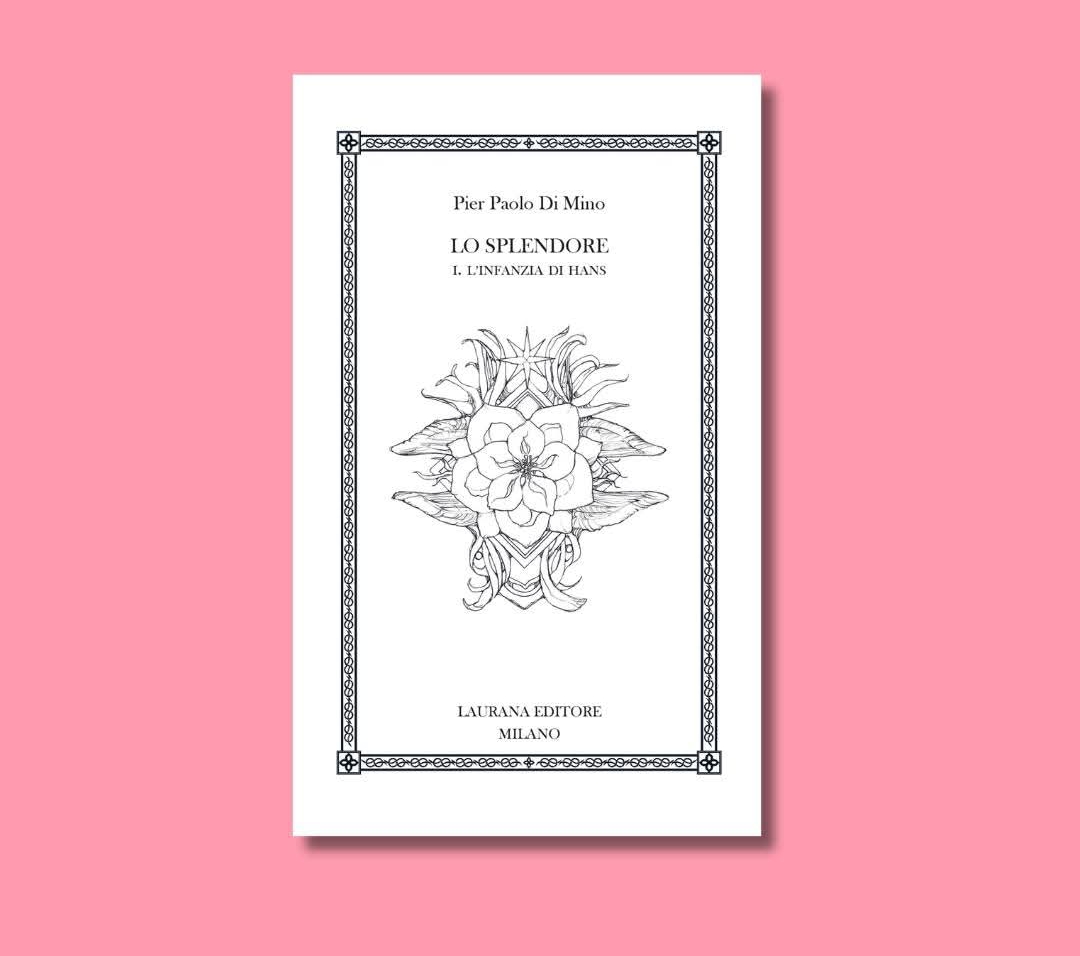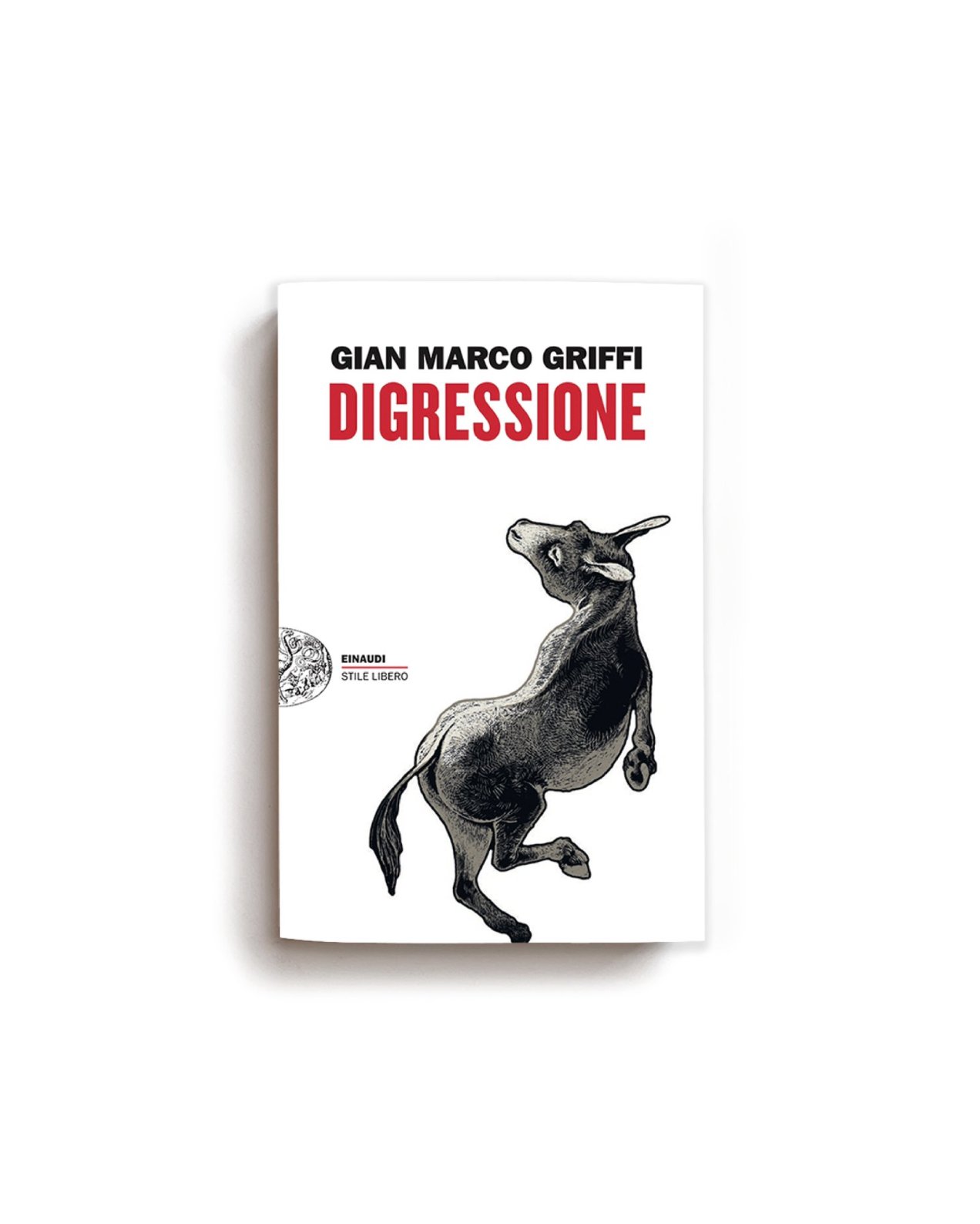Steven Mills è un uomo alla deriva. Professore universitario in piena crisi personale, ha visto sgretolarsi ogni certezza: la moglie lo ha lasciato, il rapporto con il figlio si è dissolto, e il lavoro al Writing Center dell’Università di San Francisco è ormai solo un ricordo. Ma la frattura più profonda nella vita di Steven risale a molto prima ed è legata alla scomparsa improvvisa di suo padre, avvenuta nel 1984, quando Steven era ancora un ragazzino. È questa assenza antica e incancellabile a spingerlo oggi lungo la costa della California, in un viaggio che è al tempo stesso ricerca e resa dei conti. Steven vuole scoprire chi fosse davvero quell’uomo che un giorno è sparito misteriosamente, senza lasciare traccia, lasciandosi alle spalle una famiglia disorientata e un figlio colmo di domande. L’indagine personale si intreccia così con i fili sfilacciati della propria identità, con l’infanzia assolata a Fullerton, gli amici, i dischi, i film in tv. Ne nasce un romanzo di formazione al contrario, dove il passato non guida, ma confonde, e dove ogni ricordo è una porta che si apre su un altro enigma.
Il racconto prende avvio da un’estate del 1983, nella cornice dorata e malinconica di una festa borghese. Una piscina, i genitori che ridono, fumano erba con gli amici, e un vecchio proiettore che trasmette film in bianco e nero sotto le stelle. La California di quegli anni si rivela in tutta la sua sensualità sfavillante, ma anche in controluce: dietro l’euforia sale la tensione. La festa degenera, l’alcol scorre, accade qualcosa che il giovane Steven non riesce del tutto a comprendere. Quella sera segna una cesura, un punto di rottura. Da lì, suo padre, brillante docente di Letteratura Inglese al St. Agnes College, comincia a perdere lentamente tutto: prestigio, lucidità, credibilità. Gli anni seguenti sono un lento smottamento. Emergono voci su comportamenti inappropriati, su scandali mai chiariti, su una vita forse doppia. La figura paterna, un tempo solare e carismatica, si trasforma: diventa silenziosa, diffidente, ossessionata dalla sicurezza e dal sospetto. Il padre di Steven passa ore rinchiuso nel capanno in fondo al giardino, spesso in compagnia dell’enigmatico collega Deryck Evanson, figura centrale e ambigua nei ricordi di Steven. Annotazioni segrete, nomi scritti su taccuini nascosti: il padre si chiude in un mondo parallelo, dove paranoia e disgregazione mentale si confondono. Molti anni dopo, Steven cerca di ricomporre questo mosaico frantumato. Intervista amici di famiglia, ex studenti, colleghi: ognuno restituisce un frammento, un’impressione, una verità parziale. C’è chi lo ricorda come un mentore generoso, chi come un uomo instabile, chi come un idealista sopraffatto. Nessuna versione coincide con l’altra, e la figura del padre si rivela sfuggente, piena di contraddizioni, irrisolta. Questa indagine però non riguarda solo il padre ma anche sé stesso. Steven non cerca una verità assoluta, ma un modo per fare pace con ciò che è stato. Nel processo riemergono memorie sopite, come l’amicizia intensa con Chau, compagno di adolescenza, di esplorazioni sessuali, di notti irrequiete e confusione identitaria.
Con La vita immaginata, pubblicato in Italia da Feltrinelli con la traduzione di Ada Arduini, Andrew Porter, autore della Pennsylvania con dei trascorsi all’Iowa Writers’s Workshop, costruisce un romanzo intimo e struggente, che indaga le pieghe della memoria e il bisogno di comprendere chi siamo attraverso chi ci ha generati. Non è solo una storia familiare, ma una riflessione profonda sull’identità, sul peso delle aspettative, e su quella distanza incolmabile tra ciò che è stato e ciò che avremmo voluto fosse. La California degli anni ’80: libera, briosa, eppure macchiata dalla disillusione, è uno scenario quasi ellisiano, lo specchio di una generazione smarrita. Porter si muove nel solco della grande narrativa americana del disincanto, evocando atmosfere suburbane e tensioni domestiche alla maniera di John Cheever e Richard Yates, e interrogandosi sul significato di certe assenze, sul tempo che non rimargina le ferite, sul fragile confine tra ammettere e accettare.
Angelo Cennamo