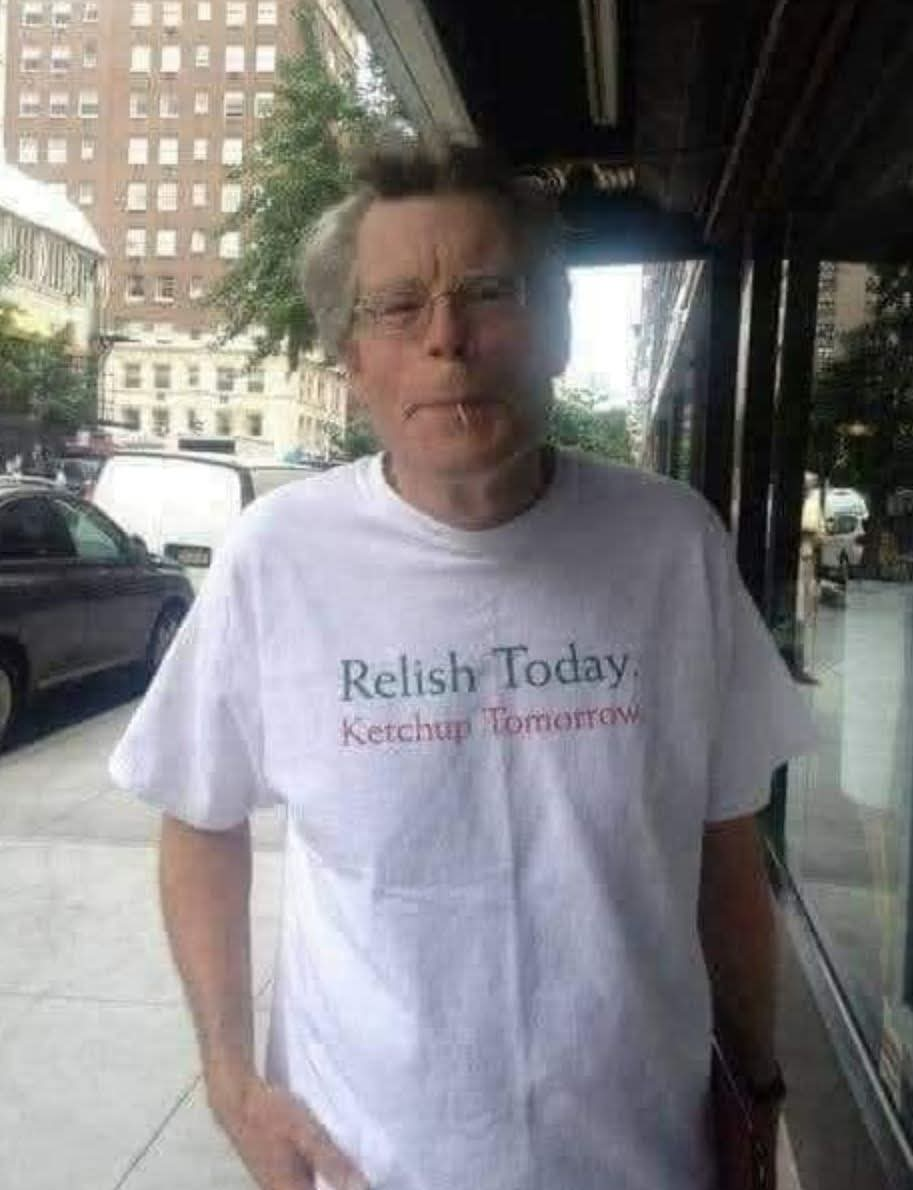Quando The Graduate esce negli Stati Uniti nel 1963, Charles Webb è poco più che ventenne. Scrive il romanzo ai tavolini di un bar, forse traendo ispirazione da esperienze personali, immaginando la storia di un giovane sospeso tra il privilegio e l’inquietudine. Il successo, inizialmente moderato, esploderà solo qualche anno più tardi, grazie all’indimenticabile trasposizione cinematografica del 1967: Il laureato, con un giovanissimo Dustin Hoffman e la colonna sonora di Simon & Garfunkel, trasformerà un romanzo di nicchia in un fenomeno culturale, arricchendo il suo autore e consegnandolo alla storia.
The Graduate – tradotto in Italia come Il laureato (Paolo Cioni per Mattioli 1885) – fotografa un’America borghese, solare e apparentemente serena, ancora inconsapevole delle fratture sociali e politiche che di lì a poco sfoceranno nel ribellismo del ’68. È l’America de Il nuotatore di John Cheever: elegante, ottimista, immersa nella luce artificiale dei sobborghi, tra piscine, cocktail e sorrisi impeccabili. In questo scenario patinato si muove Benjamin Braddock, giovane fresco di laurea, erede di una ricchezza e di un futuro già scritti per lui. Ma dietro la facciata del successo, Ben è smarrito. Sente un vuoto profondo, un’inquietudine che lo spinge a rifiutare i valori della famiglia, l’istruzione che avrebbe dovuto garantirgli il riscatto sociale, perfino l’affetto dei genitori. È la crisi di un’intera generazione che si affaccia all’età adulta scoprendo l’inganno del sogno americano. Lo scontro generazionale, nel romanzo di Webb, prende la forma del desiderio e della seduzione. Mrs. Robinson – resa immortale sullo schermo da Anne Bancroft – è la moglie del socio del padre di Ben: una quarantenne disillusa, cinica, alcolizzata, che trova nel giovane laureato un diversivo alla propria infelicità. La loro relazione, torbida e ossessiva, diventa il simbolo del conflitto tra conformismo e libertà, tra l’ipocrisia del mondo adulto e la ricerca di autenticità di una generazione nascente. Elaine, la figlia di Mrs. Robinson, rappresenta per Ben l’unica via di fuga: l’amore come salvezza, ma anche come condanna, perché il prezzo di quella ribellione sentimentale sarà altissimo. Romanzo essenziale e teso, Il laureato è costruito quasi interamente sui dialoghi: brevi, taglienti, scanditi da un ritmo che anticipa la scrittura cinematografica. Webb dipinge personaggi memorabili con poche, incisive pennellate, restituendo un’umanità fragile, contraddittoria, in bilico tra desiderio e repulsione. La trama, lineare e potente, si fa allegoria di un disagio più ampio: quello di un’America che non sa più riconoscersi nei propri miti. Eppure, paradossalmente, la straordinaria potenza del film di Mike Nichols ha finito per oscurare la voce originale del romanzo. Per molti, Il laureato è Dustin Hoffman dietro il vetro di un acquario, è la chitarra malinconica di Mrs. Robinson. Ma dietro quell’immagine ormai iconica resta un piccolo grande libro del Novecento: lucido, ironico e profondamente inquieto, come il suo protagonista.
Angelo Cennamo