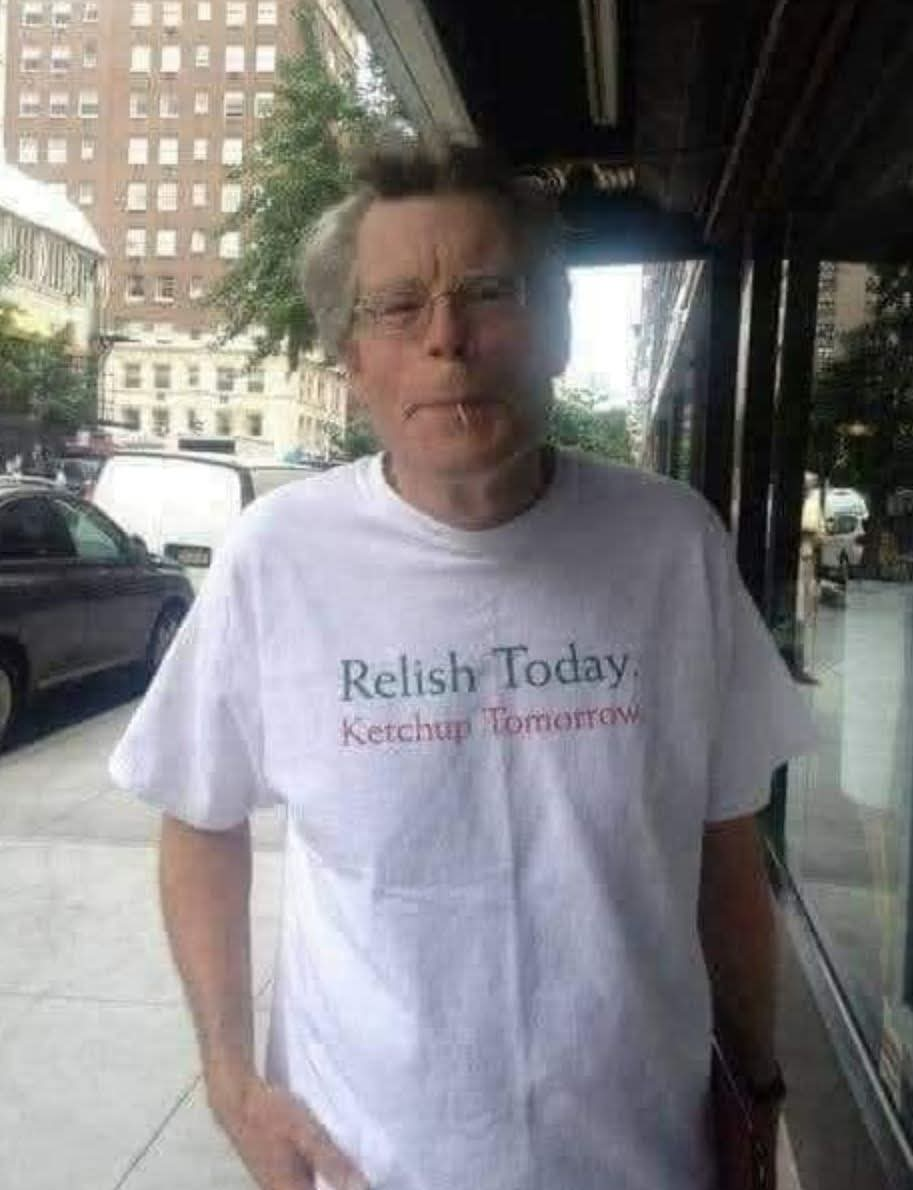E se il Nobel per la letteratura lo vincesse Stephen King? Vi pare possibile? Nessun romanzo di King ha vinto il Pulitzer o il National Book Award, i due premi americani più prestigiosi. Figurarsi l’ipotesi del Nobel. Come mai? L’esclusione di King da questi circuiti nasce da un antico riflesso condizionato dell’establishment culturale: l’idea che esista una gerarchia tra i generi narrativi, e che la cosiddetta “letteratura alta” debba restare immune dall’immaginario popolare. Il caso King è emblematico. King ha costruito un corpus narrativo di dimensioni impressionanti, coerente nella sua visione e stratificato nella sua lettura del mondo. Eppure, non sono pochi coloro che continuano a collocarlo ai margini del canone contemporaneo, come se la sua popolarità, la sua falsa identità Horror, perché è falsa, invalidasse in partenza qualsiasi valutazione estetica. È un cortocircuito critico che si regge su una dicotomia ormai esausta: quella tra letteratura “di intrattenimento” e letteratura “seria”. Ma l’opera di King non si lascia contenere in questi recinti. Sotto la superficie di mostri, possessioni e universi paralleli, pulsa un’indagine lucida e spietata della cultura americana. King ha raccontato forse meglio di chiunque altro l’infanzia come luogo di trauma, la famiglia come teatro di violenza sotterranea, la provincia come scenario di rimozioni collettive. Ha dato forma narrativa a ciò che l’America preferisce non vedere: la persistenza del male nel quotidiano, la fragilità delle istituzioni, la paura come strumento di controllo. It, Shining, Pet Sematary, 11/22/63, The Stand: sono titoli che hanno segnato l’immaginario popolare, certo, ma sono anche romanzi che parlano di colpa, tempo, fallimento, morte, potere. King non è uno scrittore Horror, semmai piega l’horror a una funzione simbolica, mettendolo al servizio della memoria collettiva. L’elemento disturbante non è mai fine a sé stesso, ma veicolo di una riflessione che attraversa l’intera sua opera. Ed è anche questa la sua forza, quella cioè di lavorare dentro il genere, non nonostante il genere. King non si limita a sfruttarne le convenzioni, ma le sovverte, le espande, le carica di una densità emotiva e tematica che ne trasfigura i confini. L’orrore, in King, è sempre un sintomo: di un disagio sociale, di un passato non elaborato, di un’identità fratturata. Dal punto di vista stilistico, la scrittura di King sfugge alle lusinghe della prosa letteraria cosiddetta alta per essere concreta, ritmica, sorvegliata, costruita non per esibire la propria intelligenza ma per entrare in risonanza con l’esperienza del lettore. Questa apparente semplicità è stata a lungo fraintesa come mancanza di ambizione. Ma King è un autore profondamente ambizioso. Non solo nella vastità della sua produzione, ma nella tensione etica che la percorre. Dalle distopie come The Stand o The Dome alle narrazioni più sottilmente politiche, la sua opera ha sempre intercettato i punti ciechi della società americana: le derive autoritarie, la precarietà della memoria storica, la trasformazione della paura in linguaggio pubblico. Lo ha fatto senza proclami, senza ideologia, ma con una chiarezza morale che oggi appare sempre più rara. Che King non sia stato finora legittimato dalle grandi istituzioni letterarie è dunque sintomo di un problema più ampio. Non riguarda solo lui, ma il modo in cui continuiamo a definire, o a restringere, il concetto stesso di letteratura. La sua esclusione non è un semplice errore di valutazione: è l’effetto di un dispositivo culturale che associa la popolarità alla banalità, la leggibilità alla superficialità, il genere al consumo. Un dispositivo che continua a difendere la torre d’avorio mentre il mondo letterario si muove altrove. Se gli accademici di Svezia ambiscono ancora a riconoscere non solo l’innovazione formale o l’impegno politico, ma anche la capacità di raccontare l’umano nella sua interezza, allora l’opera di King merita di essere riconsiderata.
Angelo Cennamo