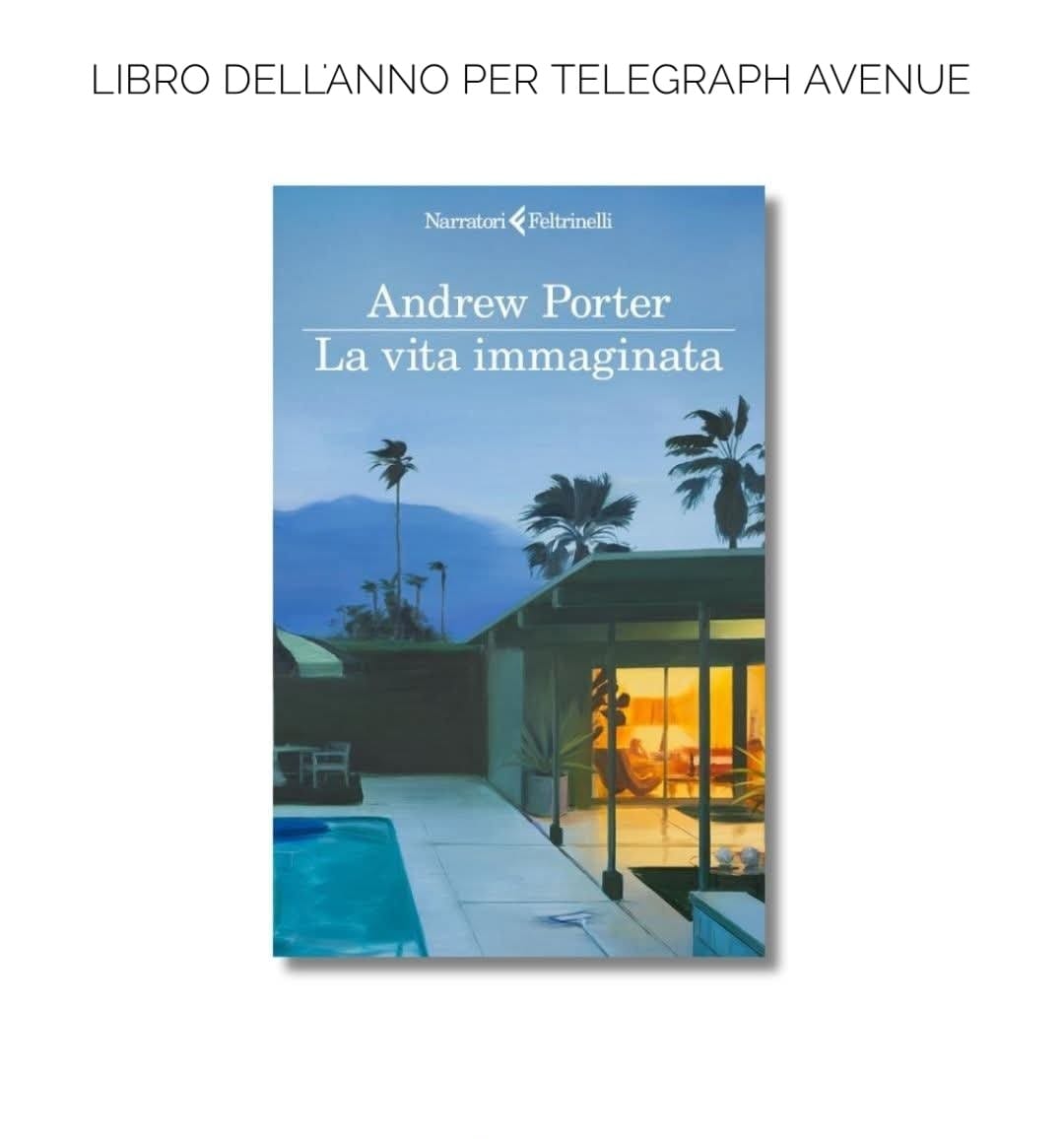«In America nessuno ha scelto un luogo piuttosto d’un altro: ci si capita per caso e subito lo si fa proprio». In questa frase, che ha la limpidezza di un aforisma e la densità di una teoria antropologica, Italo Calvino coglie una delle verità fondative del mito americano: l’idea di un’appartenenza non ereditata, ma improvvisata; non radicata nella storia, bensì nel movimento. Venticinque anni prima delle Lezioni americane – il libro-testamento preparato per il ciclo di sei conferenze che avrebbe dovuto tenere a Harvard nel 1985-86, e che la morte gli impedì di pronunciare – Calvino compì il suo primo e unico lungo viaggio negli Stati Uniti. Era il 1959, l’America era nel pieno della sua espansione economica e simbolica, e l’Europa guardava ancora agli States con una miscela di fascinazione, sospetto e invidia. «Partendo per gli Stati Uniti, e anche durante il viaggio, spergiuravo che non avrei scritto un libro sull’America (ce n’è già tanti!). Invece ora ho cambiato idea. I libri di viaggio sono un modo utile, modesto eppure completo di fare letteratura.» È una dichiarazione di poetica, oltre che di modestia. Calvino sa che il viaggio non è mai innocente: è sempre uno specchio, un confronto, un esercizio di stile e di pensiero. Quel libro, in realtà, non vide la luce mentre l’autore era in vita. Rileggendo le bozze, Calvino giudicò il materiale raccolto «troppo modesto» per diventare vera letteratura e «non abbastanza originale» per essere un reportage giornalistico. Un giudizio severissimo, quasi crudele, che oggi suona paradossale: ciò che Calvino scartò per eccesso di scrupolo è infinitamente più lucido, onesto e profondo di molta produzione che oggi viene celebrata come “letteratura di viaggio”. La sua era un’etica dello sguardo, prima ancora che della scrittura. Per sei mesi, tra il 1959 e il 1960, Calvino attraversò gli Stati Uniti in lungo e in largo: New York, Chicago, la California, il Sud, il Midwest, il deserto del New Mexico. Incontrò uomini d’affari, politici, scrittori, accademici, ma soprattutto osservò la gente comune: chi lavorava, chi viaggiava, chi sopravviveva. Non cercava l’eccezionale, ma il significativo. New York, su tutte. «Perché io New York la amo.» E non la ama come si ama un monumento o un’idea, ma come si ama un organismo vivente. Per Calvino New York è prima di tutto un ritmo: «una città elettrica, impregnata di elettricità». Non è solo una metafora: è un’esperienza fisica, nervosa, quasi biologica. Gli spazi smisurati, i grattacieli – inevitabili – ma anche le automobili «tutte lunghe, lunghissime, talora assurdamente lunghe e larghe», diventano segni di una civiltà che ha fatto dell’eccesso una forma di linguaggio. Eppure Calvino non è spaesato. Non è il marziano a Roma di Flaiano, né l’intellettuale europeo che guarda dall’alto in basso. È un uomo giovane, curioso, disciplinato nello sguardo. Osserva senza giudicare, registra senza caricaturizzare. Vede il sogno americano e ne percepisce subito anche il rovescio: il pragmatismo feroce, l’ossessione per il successo, la ricchezza ostentata e le diseguaglianze sociali, spesso brutali. Quando descrive coloro che vivono nei camper, spostandosi di stagione in stagione alla ricerca di lavori temporanei, sembra anticipare di decenni Nomadland: un’America mobile, precaria, invisibile. Chicago segna un passaggio ulteriore: «Comincio a capirla, Chicago. Forse comincia a farmi paura. Insomma, comincia a piacermi.» È una città che non seduce, ma convince. «La vera città americana: produttiva, materiale, brutale, tough». Qui l’America si mostra senza maschere: fabbriche, acciaio, lavoro, tensioni razziali. Calvino registra tutto con precisione, usando il linguaggio del suo tempo (oggi oggetto di imbarazzi e revisioni) ma senza mai indulgere nel pregiudizio. Nota, quasi en passant, che lì sarebbe nato il primo presidente nero degli Stati Uniti: una frase che oggi verrebbe letta attraverso il filtro della cancel culture, ma che allora era semplice cronaca, e soprattutto testimonianza di un’America in trasformazione. La West Coast è un altro mondo. Il Pacifico non ha la familiarità del Mediterraneo: è un mare inquieto, estraneo. Los Angeles appare più come una somma disordinata di quartieri che come una vera città. «Capisco che dovrei scrivere qualcosa su Hollywood, ma non ho nulla da raccontare.» È una rinuncia significativa: Calvino rifiuta il mito prefabbricato, ciò che si scrive perché “si deve” scrivere. Molto più lo attraggono l’altra America: quella povera, marginale, quasi coloniale. Il New Mexico, i deserti, le riserve indiane; il profondo Sud, dalla Georgia all’Alabama, dove «le case dei negri sono tuguri di legno» e la speranza di riscatto ha un solo nome: Martin Luther King. È un’America in stato di vigilia, sospesa sull’orlo della storia: Kennedy, i diritti civili, la corsa alla luna. Tutto deve ancora accadere, ma tutto è già nell’aria.
Il reportage di Calvino – pubblicato solo molti anni dopo, postumo, con il titolo Un ottimista in America – è preciso, colto, affettuoso. Non c’è l’enfasi allucinata di On the Road, né l’autocompiacimento dell’intellettuale in trasferta. È un viaggio lucido e generoso, in cui l’America diventa un laboratorio del futuro e, insieme, uno specchio deformante dell’Europa. Calvino ha amato l’America senza idealizzarla. Noi amiamo Calvino per questo: per la sua intelligenza senza arroganza, per la sua curiosità disciplinata, per la capacità di vedere il mondo come un sistema di segni da decifrare, non da giudicare. Romanziere, intellettuale, viaggiatore: uno scrittore che sapeva che anche la modestia, quando è autentica, può essere una forma altissima di grandezza.
Angelo Cennamo