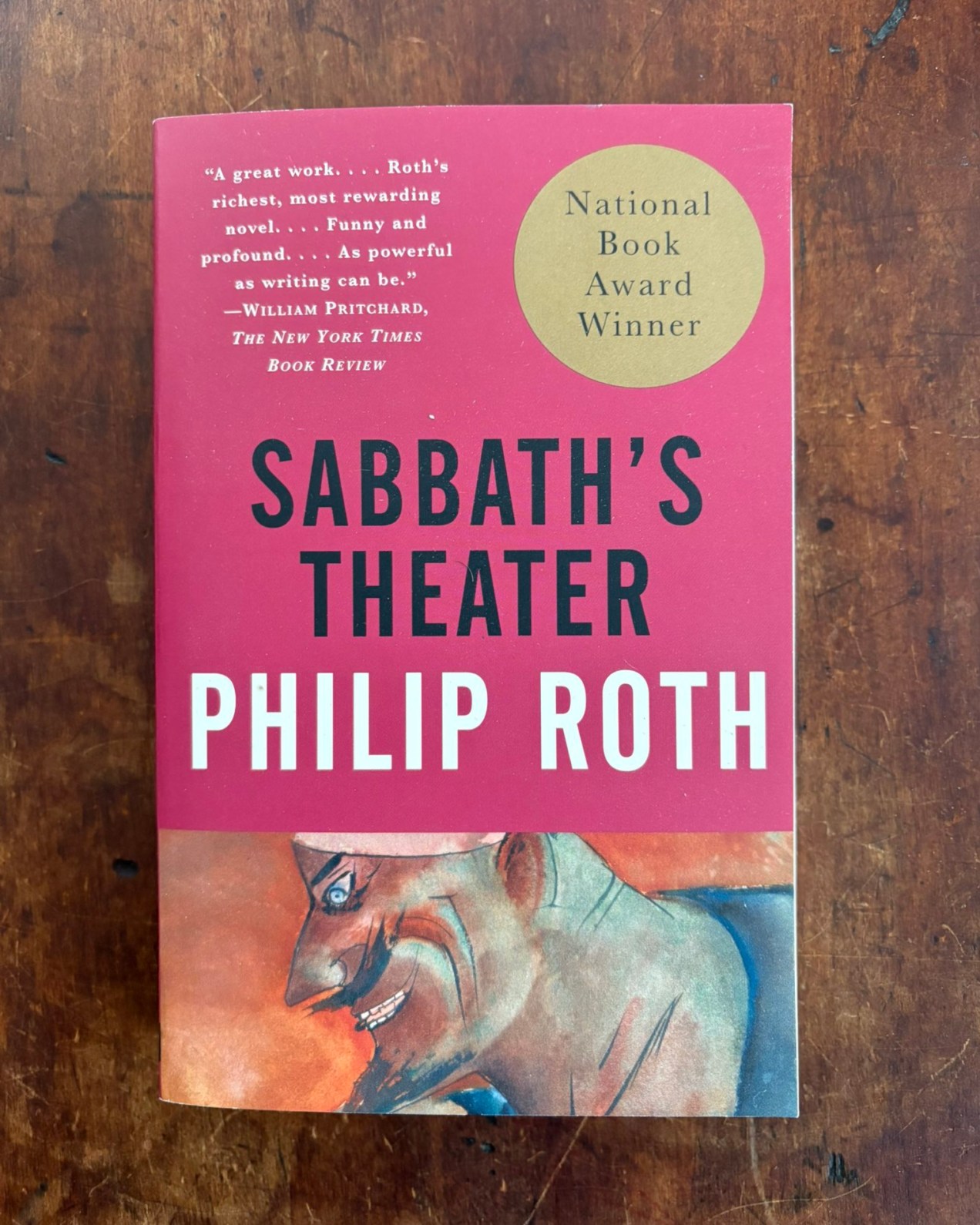Nel 1995, con Sabbath’s Theater ormai riconosciuto come uno dei suoi vertici assoluti, Philip Roth raggiunge una maturità artistica che coincide con una radicalizzazione estrema dei suoi temi centrali: il corpo, il desiderio, la colpa, la morte, l’oltraggio alle convenzioni morali e letterarie. Il teatro di Sabbath non è soltanto un romanzo scandaloso o provocatorio: è un’opera terminale, nel senso più pieno del termine, un libro che sembra scritto da un autore deciso a portare la propria poetica fino al punto di rottura, senza più concessioni né attenuanti. Roth, che già aveva indagato il sesso come motore narrativo e come scandalo culturale in Lamento di Portnoy, qui abbandona ogni ironia giovanile e ogni compiacimento satirico per consegnarci una tragedia farsesca, una commedia oscena che ha il respiro di una meditazione sulla fine.
Mickey Sabbath, sessantaquattrenne ex burattinaio, è una delle creature più mostruose e insieme più profondamente umane della letteratura americana del secondo Novecento. Roth lo costruisce come un residuo, un sopravvissuto, un uomo che vive circondato dai fantasmi: il fratello minore morto in guerra, la madre, la prima moglie scomparsa senza lasciare traccia, e soprattutto Drenka, l’amante adulterina con cui per tredici anni ha consumato una sessualità senza limiti, feroce, liberatoria e autodistruttiva. Con Drenka il sesso non è mai consolazione o intimità, ma un evento tellurico, una scossa che attraversa il corpo e la coscienza, come suggerisce una delle immagini più belle e sensuali del romanzo: l’amplesso come un sasso gettato nello stagno, capace di mettere in vibrazione l’intero mondo. Sabbath è grottesco, ripugnante, moralmente indifendibile. È bugiardo, manipolatore, parassita, sessualmente predatorio; vive a spese della moglie, frequenta bordelli, coltiva fantasie che sfiorano l’abisso dell’abiezione. Roth non cerca mai di renderlo simpatico, né di offrirgli una redenzione. Al contrario, insiste sulla sua irriducibilità, sulla sua incapacità di adattarsi a qualsiasi forma di normalità. In questa radicale esposizione dell’osceno, il romanzo produce un effetto paradossale: Sabbath diventa il luogo in cui Roth concentra tutta la propria compassione per i falliti, per coloro che non hanno trovato posto nel grande racconto americano del successo, dell’autorealizzazione, della rispettabilità. Questo lo avvicina ad altri personaggi rothiani affini per funzione e intensità, come David Kepesh o Nathan Zuckerman nelle sue incarnazioni più tarde, in particolare ne La lezione di anatomia. Ma mentre Kepesh e Zuckerman sono ancora intellettuali capaci di riflettere sul proprio desiderio, di costruire teorie, alibi, cornici interpretative, Sabbath è nudo, privo di qualsiasi apparato giustificativo. Come lui stesso ammette davanti all’amico Norman, non possiede neppure una teoria: è un cumulo di macerie che scivola lungo i marciapiedi della vita senza nulla che possa interferire con una “interpretazione obiettiva della merda”. In questa frase c’è tutta la differenza tra Sabbath e gli altri protagonisti rothiani: qui il pensiero è arrivato troppo tardi, quando il corpo ha già vinto e perso tutto. Il confronto con L’animale morente è particolarmente illuminante. Anche lì troviamo un uomo anziano, ossessionato dal sesso, incapace di accettare il declino fisico e la prossimità della morte. Ma David Kepesh conserva una patina di eleganza, una lucidità quasi clinica nel descrivere il proprio narcisismo erotico. Sabbath, invece, è già oltre: non analizza più, non sublima, non estetizza. Vive il sesso come una forma di insubordinazione permanente contro l’ordine del mondo, contro la moralità borghese, contro l’idea stessa di una vita sensata. È il sesso come bestemmia, come atto di guerra contro la morte, pur sapendo che la guerra è persa in partenza. In questo senso, Il teatro di Sabbath è forse il romanzo più nichilista di Roth, quello in cui la disobbedienza non è più una scelta ma una condanna. Sabbath non vive “dando le spalle alla morte”, come fanno gli altri; la guarda in faccia, la provoca, la corteggia, tenta persino di organizzare la propria fine. La celebre scena del cimitero, in cui immagina il proprio epitaffio come una lista di crimini morali e sessuali, è insieme esilarante e straziante: il riso che Roth suscita è sempre intriso di disperazione, come se la comicità fosse l’ultima risorsa rimasta contro l’annientamento. Ma anche il suicidio fallisce. Anche la morte, per Sabbath, si rifiuta di arrivare quando chiamata. Il fallimento diventa totale, cosmico, definitivo. È proprio qui che il confronto con John Updike, amico e collega di Roth, si fa inevitabile e rivelatore. Entrambi hanno scritto ossessivamente di sesso, desiderio, adulterio, tradimento; entrambi hanno fatto del corpo un campo di battaglia morale ed esistenziale. Ma il loro sguardo è radicalmente diverso. Updike, anche nei romanzi più espliciti della saga di Rabbit o in Coppie, mantiene una visione sacramentale del sesso: l’atto erotico è spesso immerso in una luce quasi religiosa, una rivelazione della grazia, una promessa di trascendenza. Il desiderio, per Updike, è colpa ma anche bellezza, nostalgia di un ordine perduto, rimpianto metafisico. Roth, al contrario, spoglia il sesso di ogni aura. In Sabbath’s Theater non c’è alcuna trascendenza, nessuna nostalgia dell’Eden. Il sesso è materia, impulso, violenza, comicità, degradazione; è ciò che resta quando tutte le illusioni sono crollate. Dove Updike cerca ancora un senso, Roth accetta l’insensatezza. Dove Updike guarda il corpo con malinconica venerazione, Roth lo guarda con ferocia, con ironia, con una pietà che nasce proprio dall’assenza di illusioni. Sabbath non cerca redenzione, non chiede perdono, non spera in una seconda possibilità: pretende solo di continuare a desiderare, anche quando il desiderio non conduce più da nessuna parte. Per questo Il teatro di Sabbath può essere considerato il romanzo più “rothiano” di Roth: perché contiene, senza filtri e senza compromessi, tutta la sua visione del mondo. Una visione in cui l’identità è instabile, il corpo è un tiranno, la moralità è una costruzione fragile, e la letteratura diventa l’unico luogo in cui l’abiezione può essere guardata senza ipocrisia. Roth non assolve Sabbath ma lo accompagna fino all’ultimo, con una compassione dura, inflessibile, profondamente umana. E in questo accompagnamento c’è forse la sua più alta forma di etica: non salvare i personaggi, ma non abbandonarli mai.
Angelo Cennamo