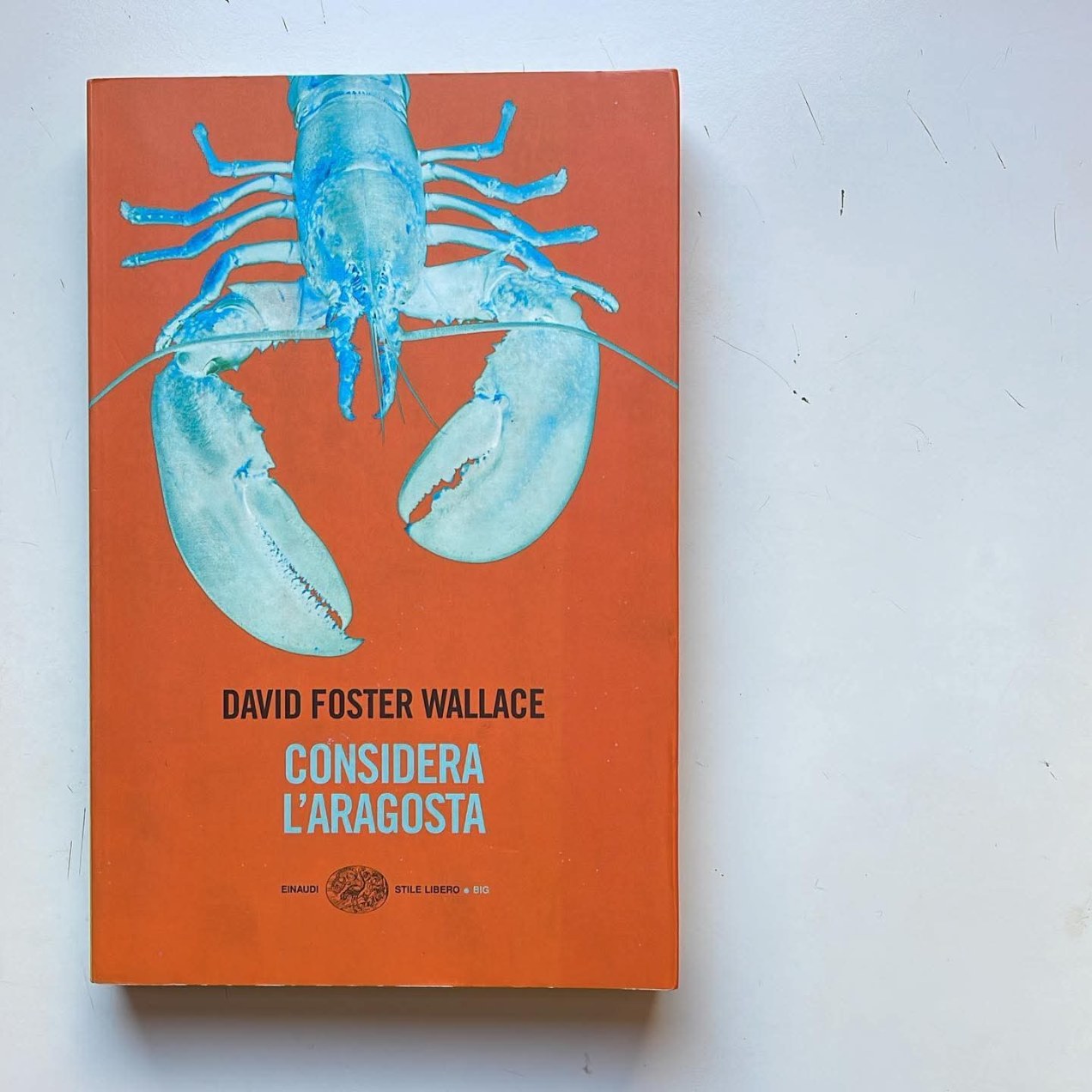Luca Ricci occupa un luogo singolare nella narrativa italiana degli ultimi anni. Da autore di racconti per vocazione e per temperamento, ha trovato nella forma del romanzo non una forzatura, ma un’estensione naturale del proprio sguardo. La scrittura di Ricci nasce breve, ellittica, aforistica; procede per sottrazione, per tagli netti, per frasi che sembrano voler eliminare ogni residuo di superfluo. Eppure questa prosa, apparentemente minima, possiede una densità di pensiero e una precisione ritmica tali da reggere strutture più ampie senza perdere la giusta tensione. Nei romanzi, Ricci non rinnega le proprie origini: i paragrafi restano compatti, le scene rapide, i dialoghi affilati come bisturi. Ma a differenza di altri suoi colleghi “brevi” che faticano a sostenere la lunga distanza, lui riesce a costruire architetture complesse, coerenti, in cui l’intreccio non è mai fine a se stesso ma funzionale all’emersione di un’ossessione centrale. Questa ossessione riguarda la crisi del desiderio, del legame amoroso, della scrittura e, più in generale, di un intero ecosistema culturale che sembra vivere in uno stato di permanente esaurimento nervoso. Nei romanzi di Ricci non c’è mai il dramma come evento esplosivo: tutto accade per logoramento, per attrito, per consumo progressivo. L’amore, la vocazione letteraria, l’amicizia, persino l’ambizione, non finiscono: si sfilacciano. È in questo lento processo di erosione che Ricci individua il vero nucleo tragico della contemporaneità.
La quadrilogia delle stagioni (Gli autunnali, Gli estivi, Gli invernali, I primaverili) rappresenta il punto più alto e più coerente di questa ricerca. Non si tratta di una saga in senso tradizionale: i personaggi cambiano, le storie sono autoconclusive, non c’è continuità narrativa diretta. Ciononostante il mondo è sempre lo stesso, immediatamente riconoscibile: una Roma mentale prima ancora che geografica, fatta di terrazze, redazioni, case borghesi stanche, librerie precarie, ristoranti dove si consumano conversazioni più che pasti. È un ambiente abitato da scrittori in crisi, editori stremati, amanti esausti, desideri deviati o sublimati. Ricci lavora per variazioni, come un musicista jazz che torna ossessivamente su un tema per esplorarne tutte le dissonanze possibili. Il tema è il disamore, inteso non come evento traumatico, ma come processo: la fine dell’amore non come esplosione, bensì come prosciugamento, come scivolamento in una zona grigia dove il sesso diventa abitudine, il dialogo si trasforma in silenzio e la presenza dell’altro si fa ingombro.
Gli autunnali resta il romanzo fondativo di questo ciclo e, con ogni probabilità, il libro più riuscito di Ricci. Ambientato in una Roma di fine estate, obliqua, stanca, attraversata da un senso di sospensione e di resa, racconta il ritorno in città di uno scrittore di mezza età che ha smarrito insieme l’ispirazione e il desiderio per la moglie. Qui Ricci compie un’operazione rara e radicale: sottrae ogni residuo di lirismo alla fine di un amore e ne mostra l’aspetto opaco, meccanico, quasi burocratico. Il disamore non è un trauma, ma una pratica quotidiana fatta di piccoli automatismi, di gesti svuotati, di convivenze senza attrito e senza calore. L’ossessione del disamore, come suggerisce il romanzo, è più feroce di quella dell’amore proprio perché non promette nulla: non redenzione, non catarsi, non rinascita. L’irruzione dell’immagine di Jeanne Hébuterne – prima come fotografia, poi come corpo “riconosciuto” nella figura di Gemma – non riattiva una vera possibilità di salvezza, ma produce un desiderio torbido, malinconico, destinato a replicare gli stessi fallimenti. Anche l’ossessione, in Ricci, è stanca; anche il desiderio alternativo è già logoro prima ancora di consumarsi. Attorno a questa vicenda privata si dispiega una riflessione più ampia e corrosiva sulla scrittura, sull’editoria, sul ruolo dello scrittore ridotto a recensore di se stesso e degli altri, intrappolato in un sistema autoreferenziale e asfittico. I dialoghi con Alberto Gittani, figura memorabile di scrittore fallito e cinico, costituiscono il cuore teorico del romanzo: conversazioni che sono insieme confessioni e autopsie della letteratura contemporanea, analisi spietate di un ambiente che ha perso ogni tensione ideale.
Con Gli estivi Ricci sposta l’asse narrativo, ma non cambia direzione. L’estate, invece di essere la stagione della pienezza, diventa quella dell’illusione. Il colpo di fulmine per un’adolescente si configura come un amore puramente immaginato, platonico, fatto di sguardi, attese, fantasie, che si ripete negli anni senza mai concretizzarsi. Qui il desiderio non si consuma perché non arriva mai a toccare il corpo; proprio per questo, però, diventa ancora più ossessivo e rivelatore. Il protagonista ricorda il Dorigo di Buzzati: sospeso tra il terrore di invecchiare e l’incapacità di abitare una normalità adulta, prigioniero di un’attesa che non conduce a nulla. Accanto a lui emerge la figura di Lello Annibali, editore e vicino di casa, misantropo e viveur goffo, personaggio tragicomico che incarna una certa idea di editoria di qualità in via di estinzione. Come Gittani, Annibali è una “spalla” che diventa coscienza, una voce laterale che può permettersi la verità proprio perché ha già perso tutto. Anche qui la critica al sistema culturale non è mai separata dal racconto sentimentale: il fallimento dell’amore e quello della letteratura procedono in parallelo, come se fossero due manifestazioni dello stesso esaurimento.
Gli invernali rappresenta una svolta strutturale. Romanzo corale, ambientato nell’arco di ventiquattr’ore, costruito quasi interamente su dialoghi, è una commedia nerissima che mette in scena otto personaggi legati da relazioni adulterine, ricatti morali, compromessi editoriali. Il sarcasmo di Ricci raggiunge qui la sua massima efficacia: aforismi alla Flaiano, tempi comici alla Woody Allen, un pessimismo brillante che non risparmia nessuno. L’editoria appare come un mondo al collasso, regolato da scambi di favori, seduzioni tardive, opportunismi mascherati da scelte estetiche. La neve che non arriva mai, attesa su una terrazza romana, diventa la metafora perfetta di una catarsi continuamente rinviata: tutto resta sospeso, congelato, come in un inverno che non promette alcuna primavera. Ed è proprio la primavera a chiudere il cerchio. I primaverili non è un romanzo della rinascita, semmai della rinuncia. Il protagonista, uno scrittore single e profondamente disilluso, scopre che la felicità non solo è effimera, ma addirittura pericolosa: una pienezza che toglie slancio, che anestetizza, che rende impossibile la scrittura. Il blocco creativo viene tradotto in immagini grottesche e memorabili, come la sedia sgangherata comprata e ricomprata all’infinito, metafora perfetta dell’ostinazione sterile. La relazione con Simonetta, libraia precaria che sogna un amore metafisico, si fonda su un rifiuto programmatico del contatto fisico: un paradosso sentimentale che diventa il cuore filosofico del romanzo. La primavera, invece di aprire, trattiene; invece di promettere, sottrae. Il ritorno di Alberto Gittani suggella il senso complessivo della quadrilogia: è lo scrittore fallito a possedere la lucidità più radicale, a comprendere che la letteratura e la vita obbediscono alla stessa legge spietata.
Nel loro insieme, i romanzi compongono una commedia umana crepuscolare, profondamente romana e profondamente italiana, che dialoga con Moravia, Buzzati e Flaiano, ma anche con un disincanto europeo alla Houellebecq. Ricci scrive di ciò che conosce e lo fa senza indulgenza, ma con un’ironia sobria, mai compiaciuta. La sua forza sta nella capacità di tenere insieme il privato e il collettivo, il fallimento sentimentale e quello culturale, mostrando come siano due facce della stessa crisi. Con la sua quadrilogia, Ricci ha costruito un affresco coerente e impietoso del nostro tempo, dimostrando che il vero centro della letteratura contemporanea non è più l’epica dell’inizio, ma la cronaca minuziosa e dolorosa di ciò che lentamente finisce.
Angelo Cennamo