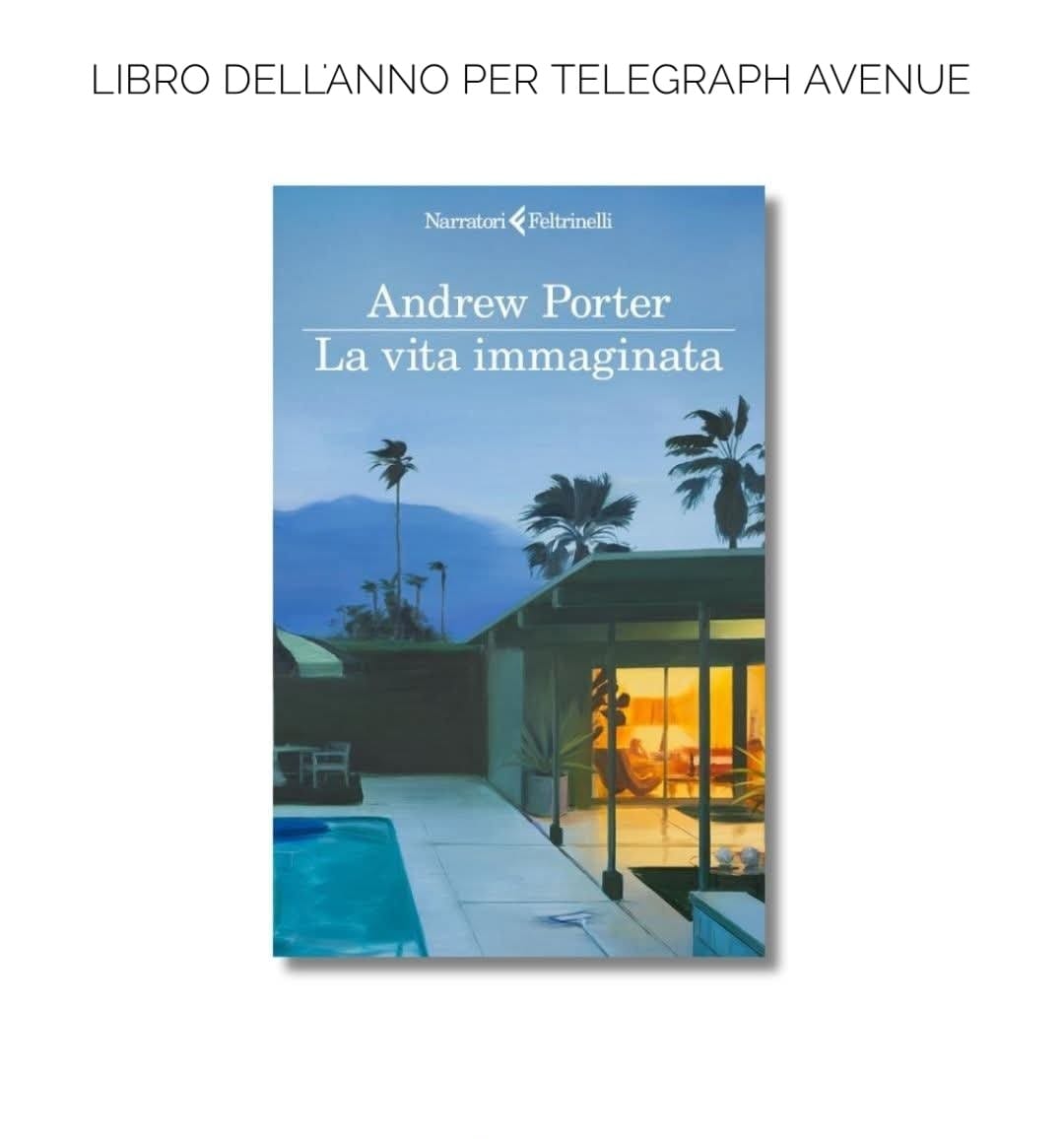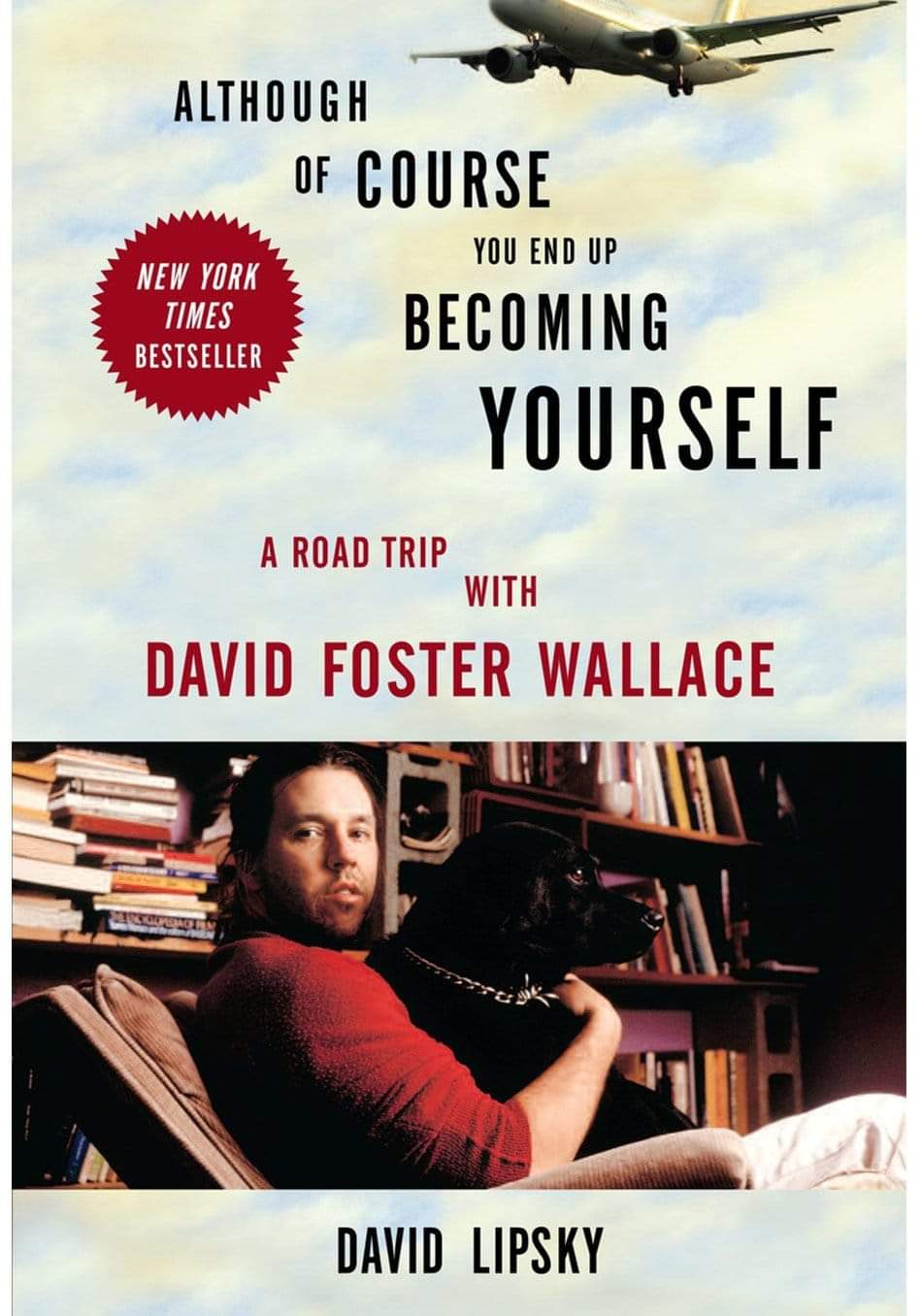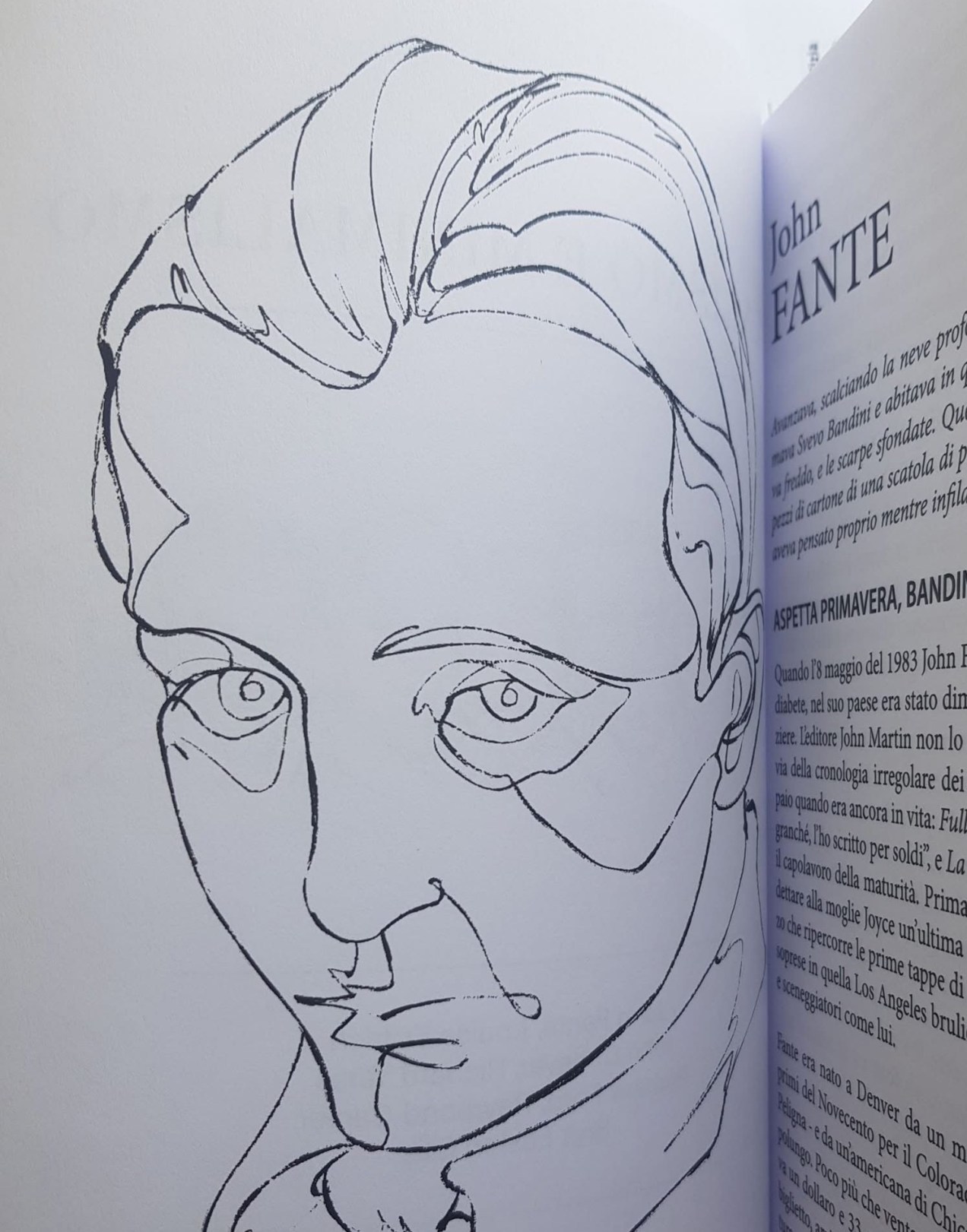“Nella mezza età c’è mistero, c’è mistificazione. Il massimo che riesca a cogliere di questo periodo è una specie di solitudine”. Da questa soglia di inquietudine, che apre Una specie di solitudine, emerge un John Cheever complicato: un uomo attraversato da contraddizioni profonde, sospeso fra l’ideale tutto americano della vita familiare e il tormento delle pulsioni più private; fra l’aspirazione alla bellezza formale e la brutalità della dipendenza dall’alcol. Nei diari (pubblicati in Italia da Feltrinelli con la traduzione di Adelaide Cioni) non si compone una biografia lineare ma un tessuto minuto di impressioni, confessioni, osservazioni quotidiane: un flusso di coscienza che supera per intensità e precisione persino la compattezza dei suoi romanzi e la raffinatezza dei racconti che lo hanno reso celebre sulle pagine del New Yorker. L’immagine pubblica dello scrittore rispettabile si dissolve rivelando un uomo fragile, inquieto, segnato da una sessualità oscillante, attratto dal femminile e insieme paralizzato dal timore di riconoscere la propria omosessualità. Nel rapporto con la moglie Mary e con i figli convivono affetto autentico, gelosie sotterranee e tensioni acuite dalla sua bisessualità e dalla consuetudine all’infedeltà: un nodo emotivo che Cheever analizza con un’onestà che non risparmia nulla, nemmeno il proprio ridicolo o la propria crudeltà involontaria. Il tema della solitudine attraversa ogni stagione della sua vita: l’adolescente malinconico che osserva la vita altrui dalle finestre illuminate diventa il simbolo della sua stessa esistenza, sempre un passo indietro rispetto alla felicità, sempre a metà strada tra la luce e una forma insondabile di estraneità. La scrittura, in questo contesto, è al tempo stesso rifugio e strumento di indagine: Cheever riflette ossessivamente sulla musicalità della frase, sul rischio della banalità, sulla necessità di una precisione che a volte sfiora la poesia. Registra con disciplina quasi crudele i propri progressi, come l’impegno di scrivere un racconto alla settimana, e le inevitabili ricadute nella disperazione creativa. L’autoritratto è arricchito dal dialogo implicito con i suoi contemporanei. Se verso Saul Bellow prova una fastidiosa rivalità, l’ammirazione per Nabokov è punteggiata da una sorta di timore reverenziale, mentre in Updike riconosce un erede e un rivale, capace di tradurre in racconto la vita dei sobborghi con una lucidità che lui sente vicina alla propria. Al centro dei diari rimane tuttavia la lotta contro l’alcol, narrata senza compiacimenti ma con una sincerità che non concede scappatoie: la bottiglia come analgesico quotidiano, la lenta disintegrazione psicologica, le ricadute, i tentativi di salvezza negli Alcolisti Anonimi e nelle cliniche di disintossicazione. In queste pagine si percepisce la misura del tempo che sfugge, l’urgenza di recuperare una vita possibile, la paura di distruggere ciò che ama. Natura, religione, casa, desiderio: sono i grandi poli tematici della sua scrittura. La luce, i cieli invernali, la fisicità del corpo immerso nei paesaggi diventano immagini di purificazione ma anche specchi del senso di colpa. La spiritualità di Cheever non cerca dogmi né assoluzioni; è piuttosto un’adesione alla bellezza del mondo, alla liturgia come gesto di appartenenza, una forma di consolazione terrena che contrasta con la tormentata ricerca di coerenza interiore. Così la casa, il giardino, le luci serali, assumono una funzione di rituale: emblemi della stabilità cui aspira e che, paradossalmente, la sua stessa natura gli impedisce di raggiungere pienamente.
Con il passare degli anni, Cheever accetta la propria bisessualità, smette di bere, ritrova una parziale serenità, ma la solitudine non lo abbandona. La sua visione del mondo resta tenera e dolorosa: Cheever sente la fragilità dei legami, la preziosità di ogni gesto quotidiano, anche il più semplice, come accarezzare un figlio o osservare un animale domestico mentre dorme. Questa duplicità (l’uomo e lo scrittore, il desiderio e il rimorso, la disciplina formale e lo smarrimento esistenziale) costituisce la forza stessa del libro. Più che il racconto di una vita tormentata, Una specie di solitudine è un’opera letteraria di ampio respiro che conferma una verità tipica di molti grandi artisti, quella secondo cui il successo della forma supera spesso la conquista della felicità. Ma nel caso di Cheever questo sorpasso avviene con una grazia e una lucidità tali da rendere la lettura dei suoi diari un’esperienza di rara intensità e bellezza da illuminare non solo la sua vita ma anche la nostra.
Angelo Cennamo