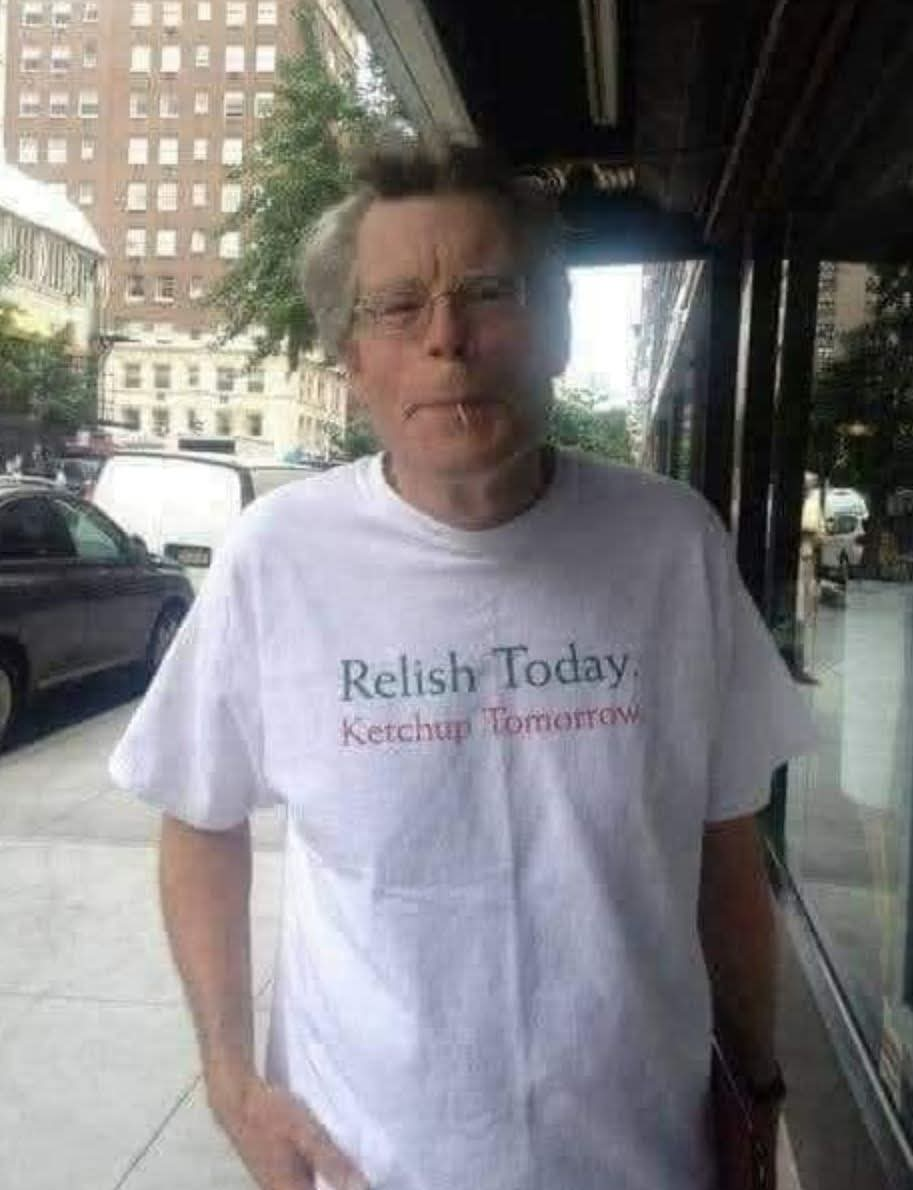Romanzi che raccontano una storia, romanzi che costruiscono un mondo; JR di William Gaddis appartiene a questa seconda categoria, ma con una radicalità tale da rendere difficile distinguere dove finisca la rappresentazione e inizi la satira. “Se siete fortunati vi stancherete di questo libro… lo definirete inutilmente complicato, ostinatamente ottuso, prolisso, assurdamente concepito” scrive Mark Danielwski nell’incipit del suo Casa di foglie. Potreste pensare la stessa cosa leggendo JR: approcciare questo mattone di circa mille pagine è come scalare l’Everest con una t-shirt e le scarpe da tennis. Ma sorvoliamo per un attimo sulla provocazione di Daniewski e proviamo piuttosto a comprendere le ragioni per le quali romanzi ostici come JR – tornato disponibile con l’editore Il Saggiatore, la traduzione di Vincenzo Mantovani e una impeccabile postfazione di Tommaso Pincio – continuino ad avere un forte appeal su un certo lettorato: nerd, nostalgici, malati o rabdomanti di buonissima letteratura. Vent’anni dopo il monumentale The Recognitions (1975), Gaddis costruisce qui un laboratorio linguistico dove la falsificazione non è più tema ma condizione strutturale: un universo narrativo in cui linguaggio ed economia coincidono, e dove il valore è prodotto dal rumore stesso delle transazioni. Ambientato tra scuole, uffici e sale riunioni, JR si sviluppa quasi interamente in forma dialogica, senza cornici descrittive o punti di vista ordinatori; la pagina diventa una superficie acustica attraversata da un flusso continuo di voci che si interrompono, si sovrappongono, si confondono, restituendo la vertigine di un mondo che parla troppo per dire davvero qualcosa. In questo paesaggio sonoro (da attraversare come quando si origlia da dietro una porta, suggerisce Pincio) il protagonista JR Vansant, un undicenne che mette in piedi un impero finanziario dal telefono pubblico della scuola, emerge come la incarnazione infantile del capitalismo contemporaneo: un genio inconsapevole che, giocando, riproduce perfettamente la logica impersonale dei mercati. La sua innocenza è solo un’altra forma di irresponsabilità sistemica; la sua astuzia, un riflesso automatico del linguaggio economico che lo circonda. Attraverso la sua figura Gaddis mostra la deriva di una cultura in cui l’atto di parlare è già un atto di scambio e dove la parola – talvolta balbettata, confusa – diventa moneta svalutata. In JR, il linguaggio non media più la realtà ma la sostituisce. La lettura diventa quindi un’esperienza di disorientamento produttivo, l’immersione totale in un mondo che ha perso ogni distanza critica da se stesso. Se Joyce o Faulkner usavano la densità linguistica per esplorare la coscienza individuale, Mr. Difficult mostra una realtà in cui la coscienza è interamente colonizzata dal linguaggio collettivo, dal gergo aziendale, dai cliché amministrativi e dai dispositivi comunicativi che scandiscono la vita sociale. È in questa prospettiva che JR si inserisce nel contesto del postmodernismo americano, ma con un rigore e una severità che lo distinguono dai suoi contemporanei. Rispetto al cosmico barocchismo di Pynchon o alla malinconica eleganza di DeLillo, Gaddis si muove in un territorio più asciutto, meno visionario ma più concreto, dove il caos non è una vertigine metafisica ma una condizione amministrativa. Se in Gravity’s Rainbow, uscito l’anno prima, l’universo implode sotto il peso delle informazioni, in JR si dissolve sotto il peso delle parole e di un affarismo impalpabile. Là dove Pynchon costruisce sistemi paranoici che alludono al trascendente, Gaddis insiste sulla sordità del quotidiano, sull’incapacità di qualsiasi discorso di generare significato e valore che non sia il valore del denaro. Perché è di questo che stiamo parlando: JR è un meraviglioso romanzo sul denaro (vincitore del National Book Award lo stesso anno in cui Saul Bellow si aggiudica il Nobel e il Pulitzer per Il dono di Humboldt); il piu bello, forse, alla pari con Money di Martin Amis. Accanto al bambino-tycoon, figura del capitalismo ludico e autistico, Gaddis colloca Edward Bast, musicista fallito e alter ego dell’artista moderno, incapace di comporre un’opera coerente in un mondo dove la coerenza è diventata impraticabile. Di personaggi come Bast ne troverete tanti: il libro è pieno di artisti falliti, con opere incompiute nei cassetti. Gaddis è tra questi. Se The Recognitions lamentava la perdita dell’autenticità nell’arte, JR rappresenta la fase successiva: l’impossibilità stessa dell’autenticità, la dissoluzione dell’artista in un linguaggio ormai privato di silenzio. In questo senso il romanzo, che alla sua uscita apparve eccessivo e inaccessibile, si rivela oggi di una lucidità profetica: il sistema di voci che Gaddis mette in scena anticipa la frammentazione digitale, l’infosfera delle notifiche e dei flussi ininterrotti di comunicazione. La sua struttura non è solo sperimentale, ma diagnostica: JR è il primo grande romanzo dell’automazione linguistica, un mondo che funziona da sé, privo di intenzione eppure perfettamente operativo, in cui l’unico ordine possibile è quello del rumore stesso, e la verità, se c’è, nasce dal suo accumulo. Rileggere oggi JR significa riconoscere nella sua cacofonia la genealogia della nostra: un capitalismo linguistico in cui parlare equivale a produrre valore e in cui la comunicazione è diventata la più pervasiva delle merci. Con una lucidità che non indulge al compiacimento intellettuale, Gaddis trasforma il disordine del linguaggio in una forma di conoscenza, consegnando alla letteratura americana uno dei suoi esperimenti più radicali e tuttavia più fedeli alla realtà.
Angelo Cennamo