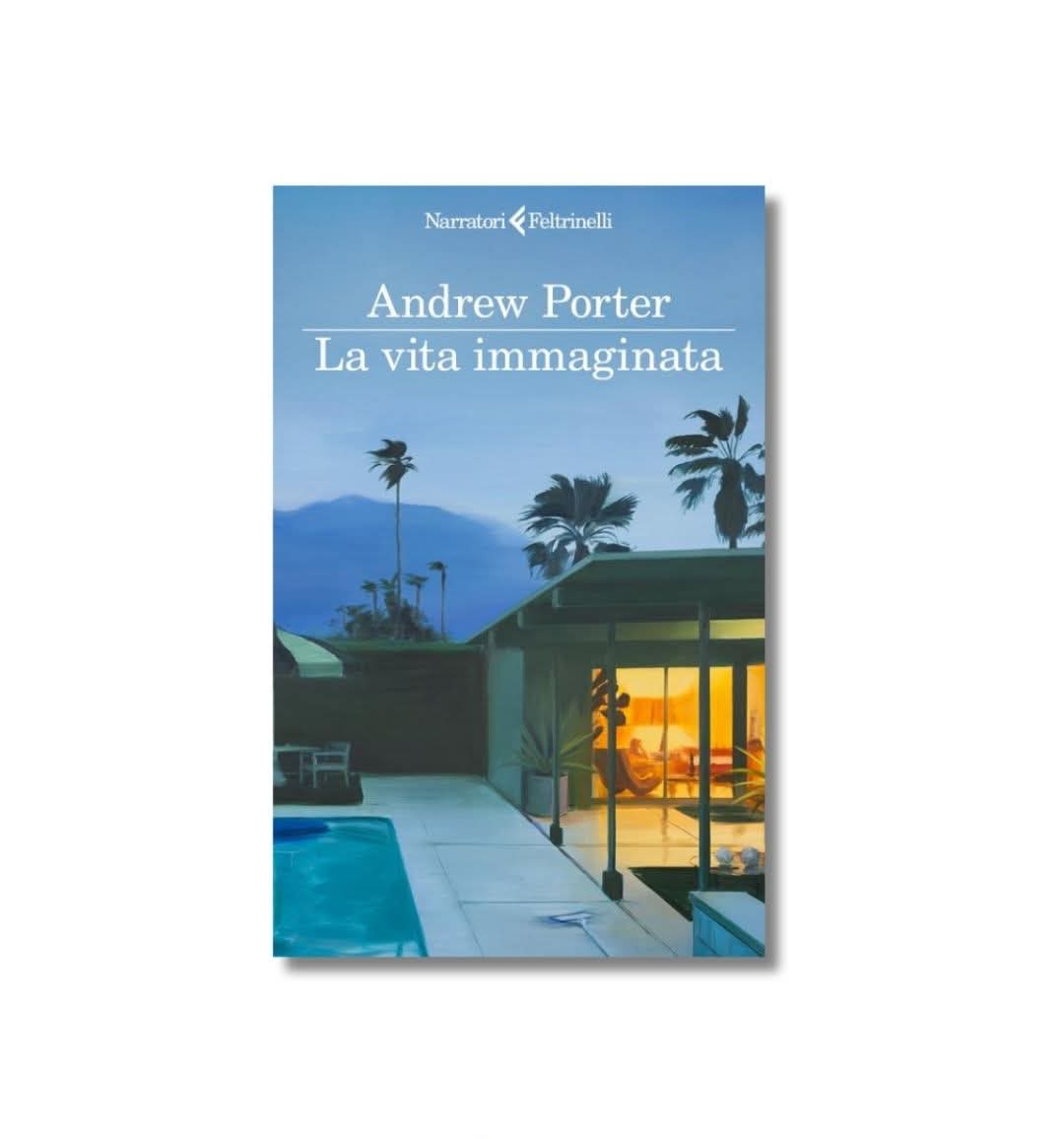Una storia crudele che affonda nelle pieghe oscure della famiglia americana e nelle crepe della sua apparente normalità. Ambientato nella cittadina di Elmira, nello stato di New York, a partire dal 1951, La radice del male (NNEditore, traduzione di Michele Martino) prende il via con un incontro tanto enigmatico quanto sinistro: una tredicenne, Myra Lee Larkin, viene avvicinata da un ragazzo che si presenta come Mickey Mantle, stella dei Yankees. La stessa sera, i vicini di casa di Myra vengono brutalmente assassinati e i sospetti si concentrano su un giovane dall’identikit simile a quello del suo nuovo amico. È solo l’inizio di una lunga e complicata saga familiare a metà strada tra l’universo noir di Joyce Carol Oates e Le correzioni di Jonathan Franzen: frammentata, cupa e priva di consolazione. Rapp costruisce il ritratto dei Larkin – Ava e Donald, genitori di quattro figlie e un figlio – come di una famiglia in progressivo sgretolamento, dove il male non è un’eccezione ma una componente intrinseca. L’anima inquieta della vicenda è Alec, il figlio problematico e instabile che incarna la violenza latente di un intero sistema, familiare e sociale. Attraverso salti temporali volutamente disordinati, Rapp ci guida in una narrazione che segue i Larkin in diversi momenti della loro esistenza, lasciando emergere dolore, fallimenti, sensi di colpa. La struttura narrativa franta del romanzo non è un semplice espediente stilistico: riflette l’identità fluida dei protagonisti, il loro smarrimento e l’impossibilità di sanare ferite profonde. Ne viene fuori una complessa mappatura del trauma, che Rapp propone, come dicevo, sia come realtà individuale che collettiva. Nella sua visione cupa ma potente, Rapp dà forma a un orrore multiforme che non è solo metafora ma riferimento storico preciso, concreto. La figura reale di John Wayne Gacy, noto serial killer statunitense, emerge nel racconto come simbolo della barbarie assoluta, dimostrando come la ferocia possa assumere tratti riconoscibili, tangibili. Due punti di forza del romanzo. Il primo. A dispetto della densità della follia e dei fallimenti che attraversano la storia, essa non cade mai nella spettacolarizzazione o nella gratuità di certi sentimenti. Il secondo. Lo stile viscerale e tagliente di Rapp restituisce un contesto vivido, in cui la tensione narrativa, oltre che al servizio dell’intrattenimento, diventa strumento di indagine sul potere di contaminazione del male, e sulla (remota) possibilità di opporvisi. Tra i personaggi spiccano le sorelle Larkin, ciascuna alle prese con un destino diverso ma segnato dalla stessa matrice di disagio. Fiona, la ribelle, cerca rifugio nella controcultura degli anni Settanta e in una comune femminile; Lexy e Myra, invece, costruiscono vite ordinarie, legate al culto per la letteratura e la famiglia tradizionale. Le loro passioni / ossessioni letterarie, da Camus a Salinger (a proposito: il romanzo si apre con Myra che legge Il giovane Holden), diventano chiavi di lettura per interpretare anche i fatti: la domanda su Meursault ne Lo straniero (“perché infierire dopo il primo colpo?”) echeggia nella vicenda di Alec e nella sua deriva. Al contrario di quelle femminili, le figure maschili appaiono invece quasi tutte toccate da un destino rovinoso. Donald, il padre, è un reduce di guerra incapace di provare e trasmettere empatia; Alec, la personificazione di un male originato dall’abuso e l’abbandono. Anche Danny, marito di Myra, e il figlio Ronan sembrano destinati a soccombere a una forza oscura e inarrestabile. Rapp suggerisce che la violenza non è un accidente isolato ma una pulsione inscritta nella società stessa, in quel sogno americano che si sfalda sotto il peso delle aspettative, degli smacchi taciuti, del bigottismo che esclude e punisce. Eppure, nonostante la cupezza, il romanzo non è privo di aperture, di piccolissimi lampi di grazia che lasciano intravedere uno spiraglio, l’opportunità di trasformare il dolore in una possibile risalita.
Angelo Cennamo