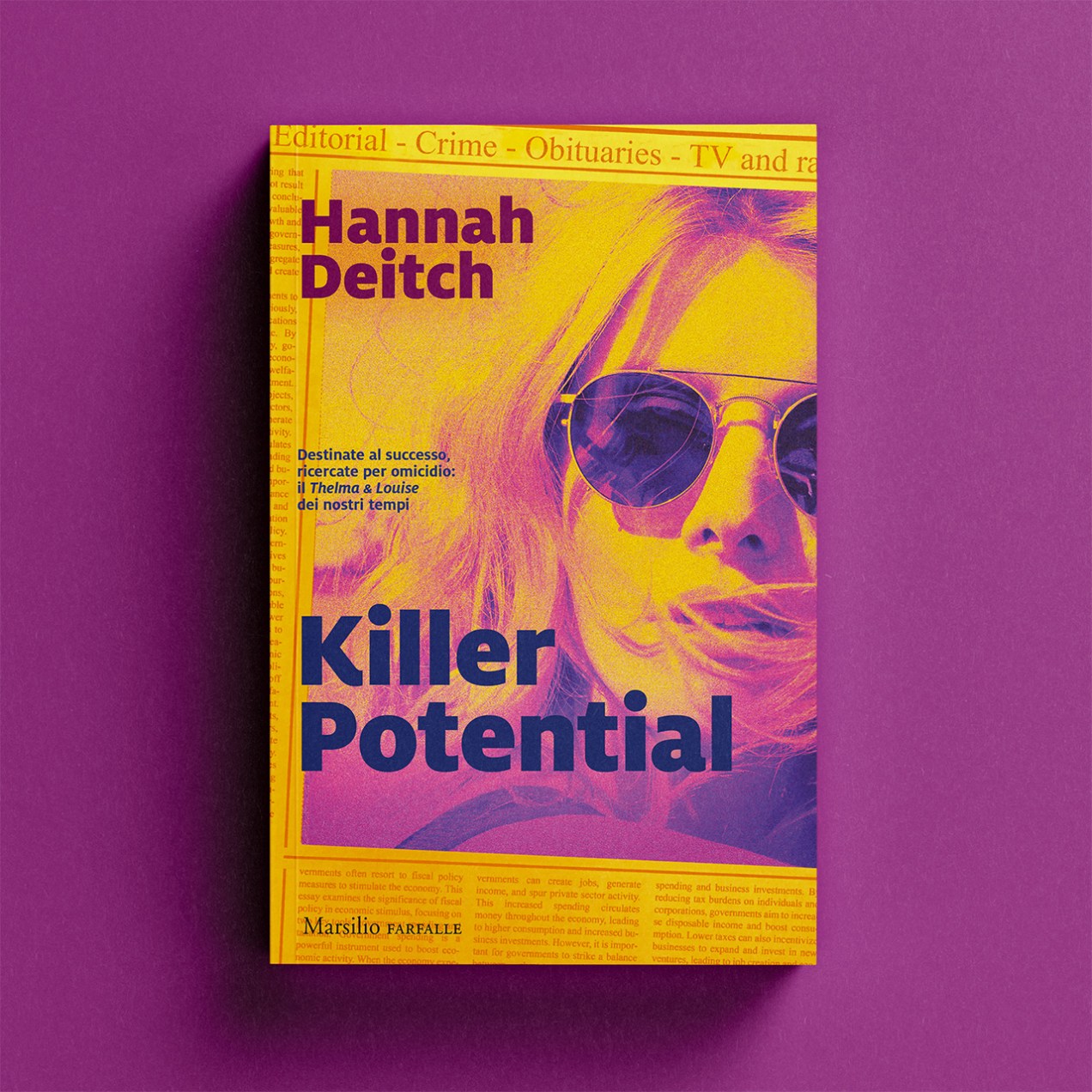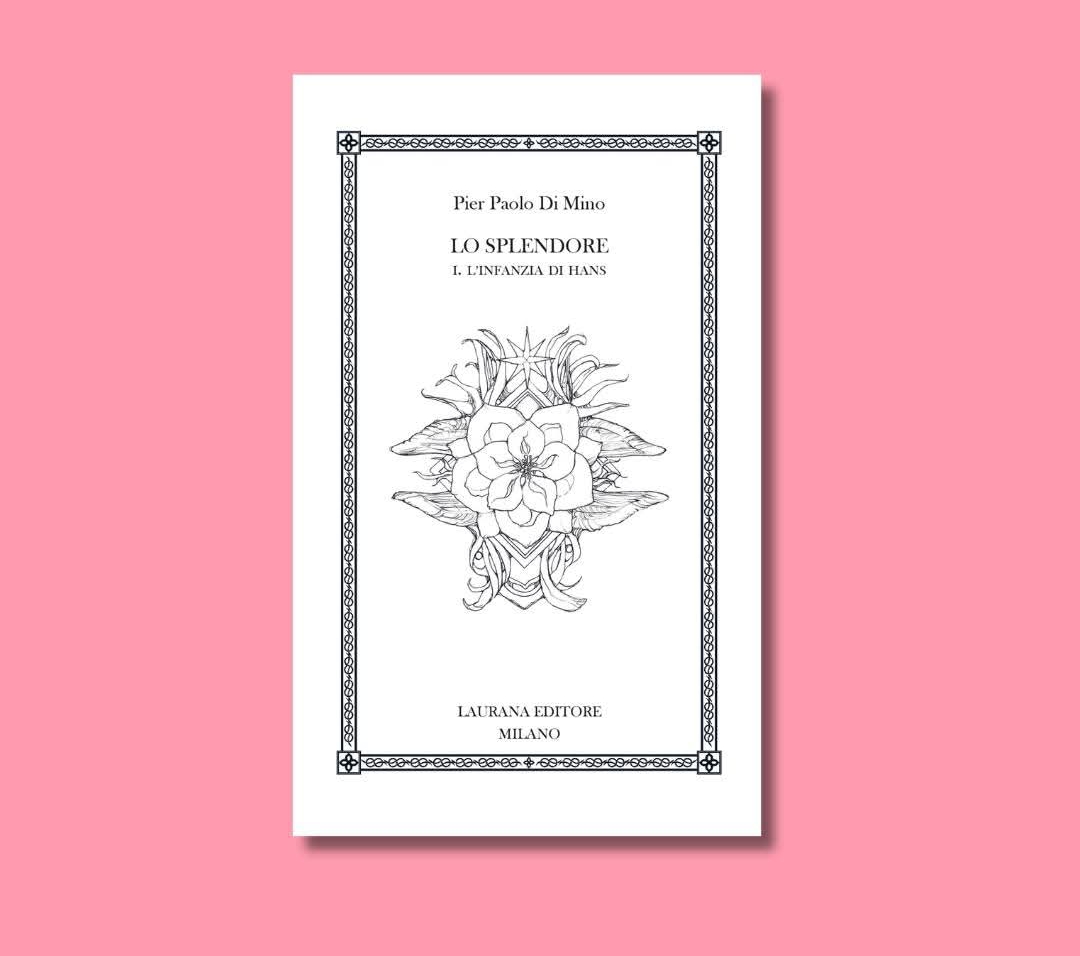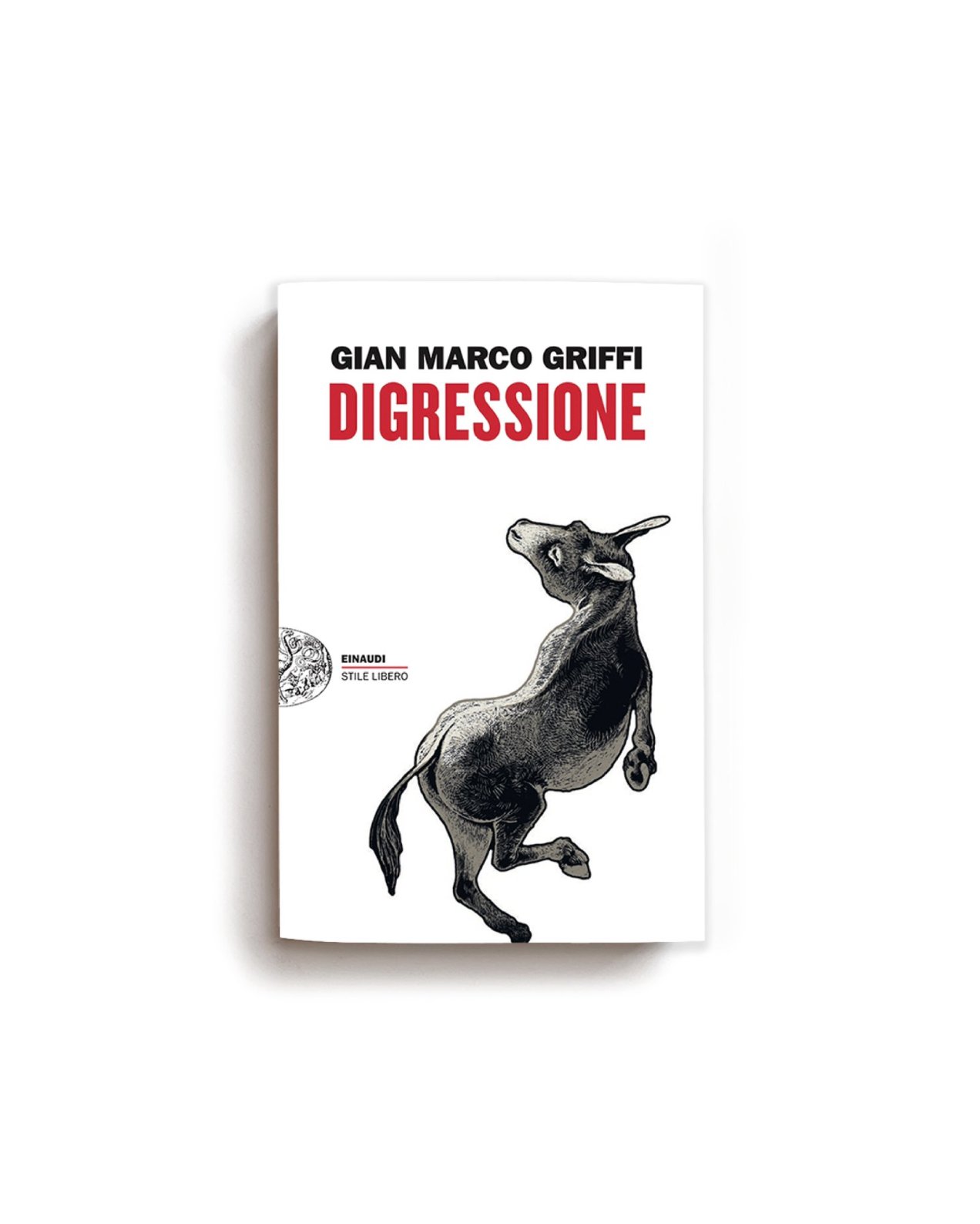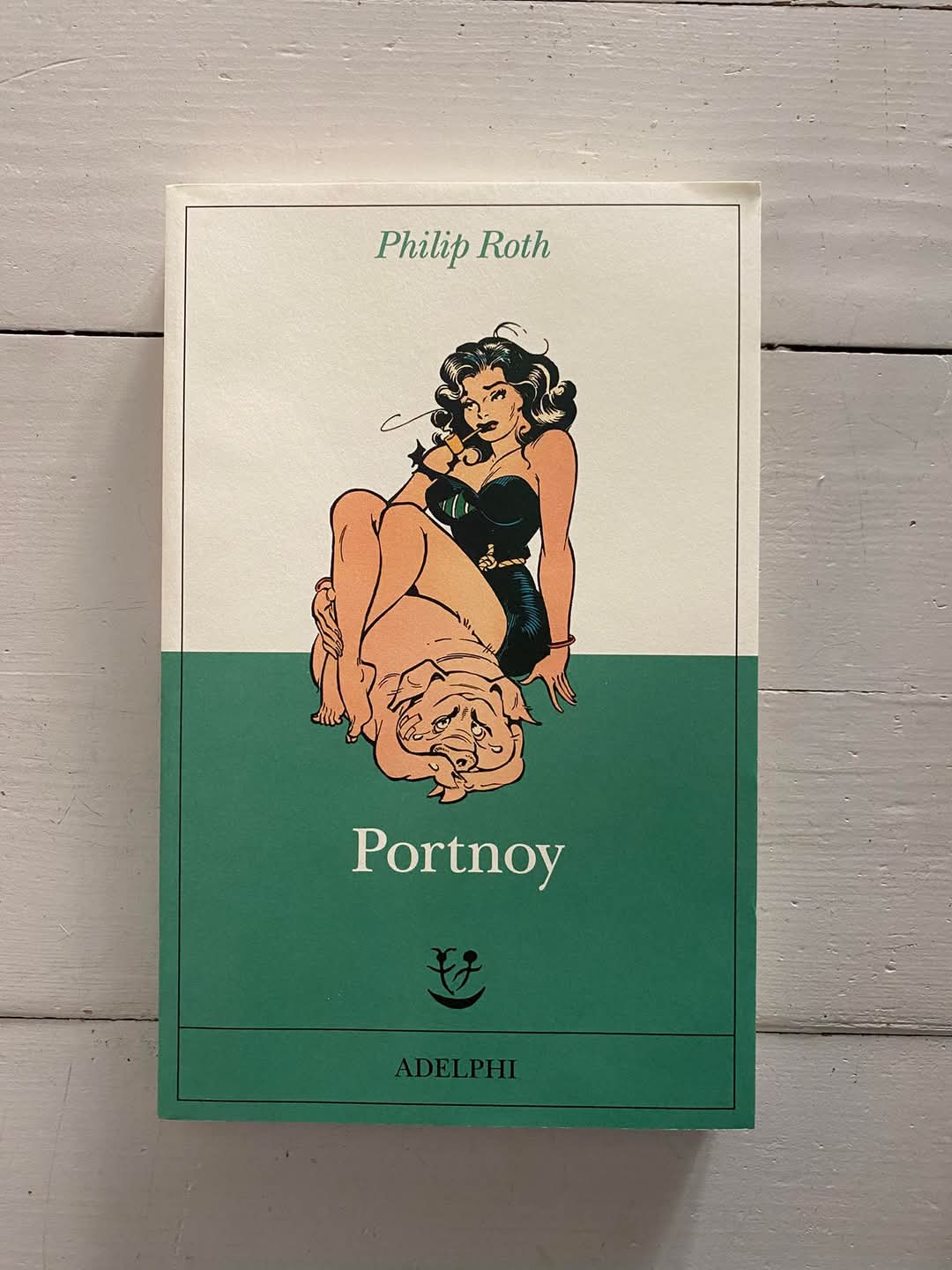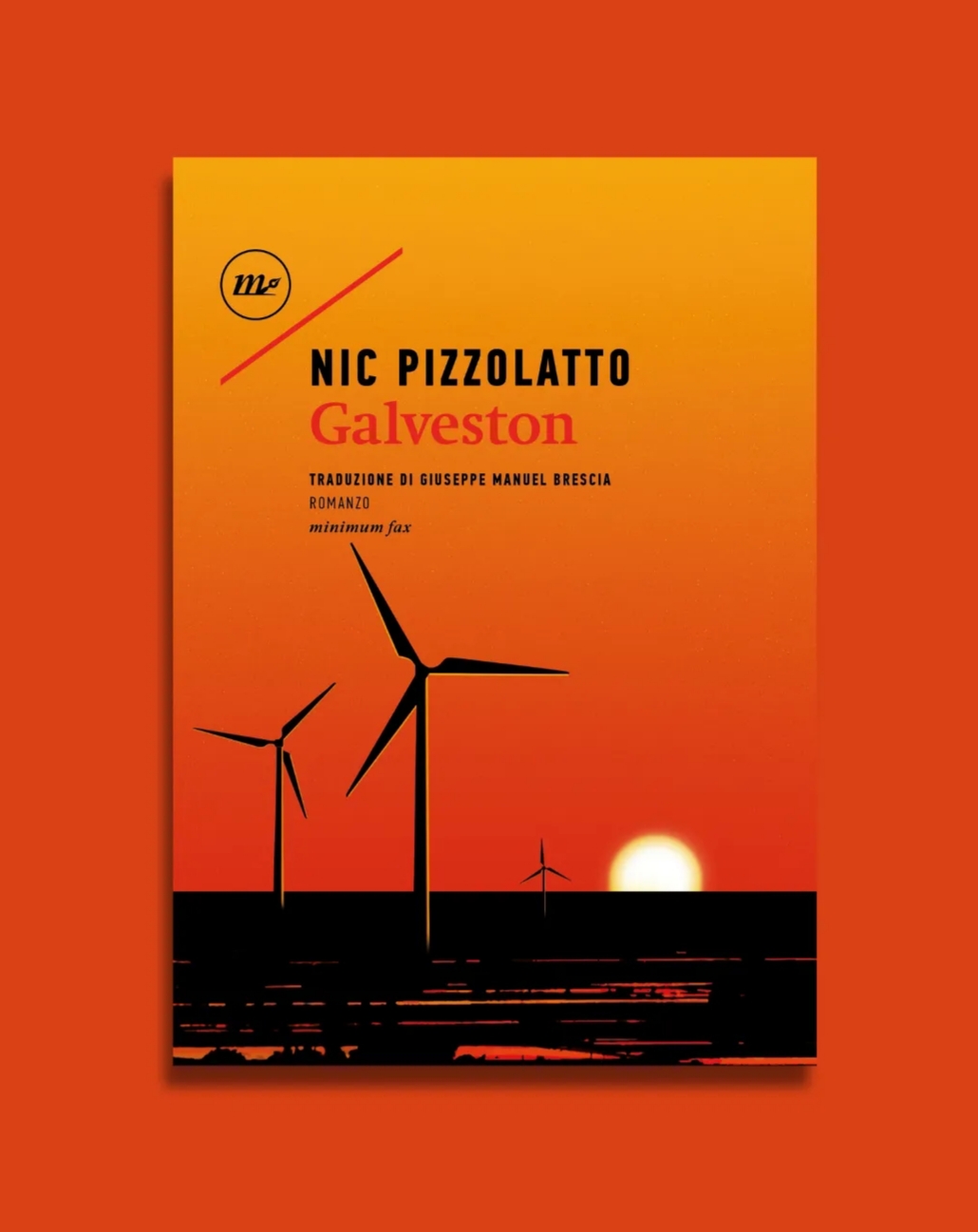Pubblicato la prima volta nel 1919, Winesburg, Ohio è tra le vette più alte della letteratura americana del primo Novecento. Molti ne parlano come di una raccolta di racconti, in realtà si configura come un romanzo corale, un’opera unitaria in cui ogni storia è un frammento, un gesto isolato ma indispensabile, all’interno del grande affresco dell’isolamento umano. Il giovane giornalista George Willard è il filo conduttore attraverso cui l’autore, Sherwood Anderson, ricostruisce l’universo soffocato e pieno di tensioni latenti di una piccola cittadina dell’Ohio. L’interesse centrale dell’opera non è tanto lo sviluppo della trama o la dinamica degli eventi quanto la rivelazione progressiva dell’interiorità dei personaggi. Anderson esplora la psicologia di persone comuni, segnate da desideri repressi, fallimenti, piccole tragedie emotive. In questo senso, si può dire che Winesburg, Ohio rappresenti uno dei primi esempi compiuti di una narrativa americana modernista, capace cioè di spostare l’attenzione dal mondo esterno alla dimensione introspettiva, dall’azione al pensiero, dall’epico al quotidiano. Uno degli strumenti più significativi attraverso cui Anderson porta avanti questo processo è il concetto di “grotesque”, introdotto nel racconto d’apertura Il libro delle caricature, e cioè l’idea che ciascun individuo, nel tentativo di afferrare una verità assoluta e farne il senso della propria esistenza, finisca per deformarla, riducendola a una fissazione che lo isola dal mondo. Questo concetto è la chiave interpretativa dell’intera opera: ogni personaggio è, a suo modo, un “grottesco”, una figura che ha smarrito l’armonia tra interiorità e realtà, soffocata sotto il peso di un’idea parziale divenuta totalizzante. Ad esempio, Wing Biddlebaum in Mani, la cui passata vita da insegnante è stata distrutta da accuse ambigue legate all’uso espressivo delle mani, vive in una condizione di costante tensione e di repressione, simbolo di una società che punisce l’alterità e non ammette ambiguità. Critici come Irving Howe e Malcolm Cowley hanno sottolineato il ruolo pionieristico di Anderson nel dare voce agli “inarticolati”, a quegli esseri marginali che la letteratura americana precedente aveva ignorato. Anderson scrive di ciò che resta ai bordi della grande narrazione americana: l’ansia silenziosa, la frustrazione erotica, l’incomunicabilità domestica, la sconfitta del desiderio. In questo senso, Winesburg, Ohio rappresenta una risposta, quasi in forma di anti-romanzo, al mito jeffersoniano dell’America rurale come luogo di innocenza morale e integrità comunitaria. Qui, invece, la provincia è l’arena della repressione, della nevrosi e della disillusione. La scrittura di Anderson riflette questa tensione tra desiderio di espressione e impossibilità di comunicazione. Il suo è uno stile volutamente frammentario, ellittico, fatto di frasi brevi, spezzate, eppure dense di lirismo e di profondità simbolica. Non a caso, autori come William Faulkner, Ernest Hemingway e persino Thomas Wolfe hanno riconosciuto un debito nei confronti di Anderson. Faulkner ha visto in lui un maestro nell’arte di raccontare i piccoli drammi interiori, mentre Hemingway, pur criticandolo in alcuni passaggi, ne ha assorbito la lezione stilistica e l’attenzione alla parola scarna ma densa di significato. Dicevo all’inizio del ruolo di interconnessione interpretato da George Willard. George funge da catalizzatore delle confessioni degli altri personaggi e che, alla fine, decide di lasciare Winesburg per cercare se stesso altrove. George è sia parte del mondo che racconta, sia osservatore distaccato, in una posizione che anticipa quella del narratore moderno e che riflette, in chiave simbolica, il passaggio all’età adulta, la ricerca di un’autenticità lontano dalle costrizioni della comunità. Il suo viaggio finale, narrato nel racconto conclusivo Partenza, non è solo un atto fisico, ma un vero rito di passaggio: l’abbandono di un mondo chiuso e opprimente per inseguire la possibilità di una vita vissuta, e non solo pensata. La struttura dell’opera, ripubblicata da Feltrinelli con la traduzione di Enrico Postiglione e un saggio di Amos Oz, è composta da ventidue racconti con temi ricorrenti, variazioni e ritorni. Ogni personaggio, ogni vicenda è una nota isolata che, nel suo insieme, compone una sinfonia malinconica sulla condizione umana. Anderson rinuncia alla logica lineare e causale del romanzo tradizionale per adottare una struttura a costellazione, in cui il significato emerge dalla somma delle voci, dei silenzi, dei desideri inascoltati. La bellezza e la rilevanza di Winesburg, Ohio oggi risiede anche nella sua attualità. In un’epoca in cui la crisi dell’identità, la solitudine e l’alienazione sembrano essere esperienze comuni in contesti urbani e digitali, l’opera di Anderson ci parla ancora con straordinaria acutezza. La provincia americana diventa quasi un archetipo della condizione contemporanea: non più luogo reale, ma spazio interiore in cui convivono aspirazioni e limiti, sogni e paure, desiderio di relazione e condanna all’incomunicabilità.
Angelo Cennamo