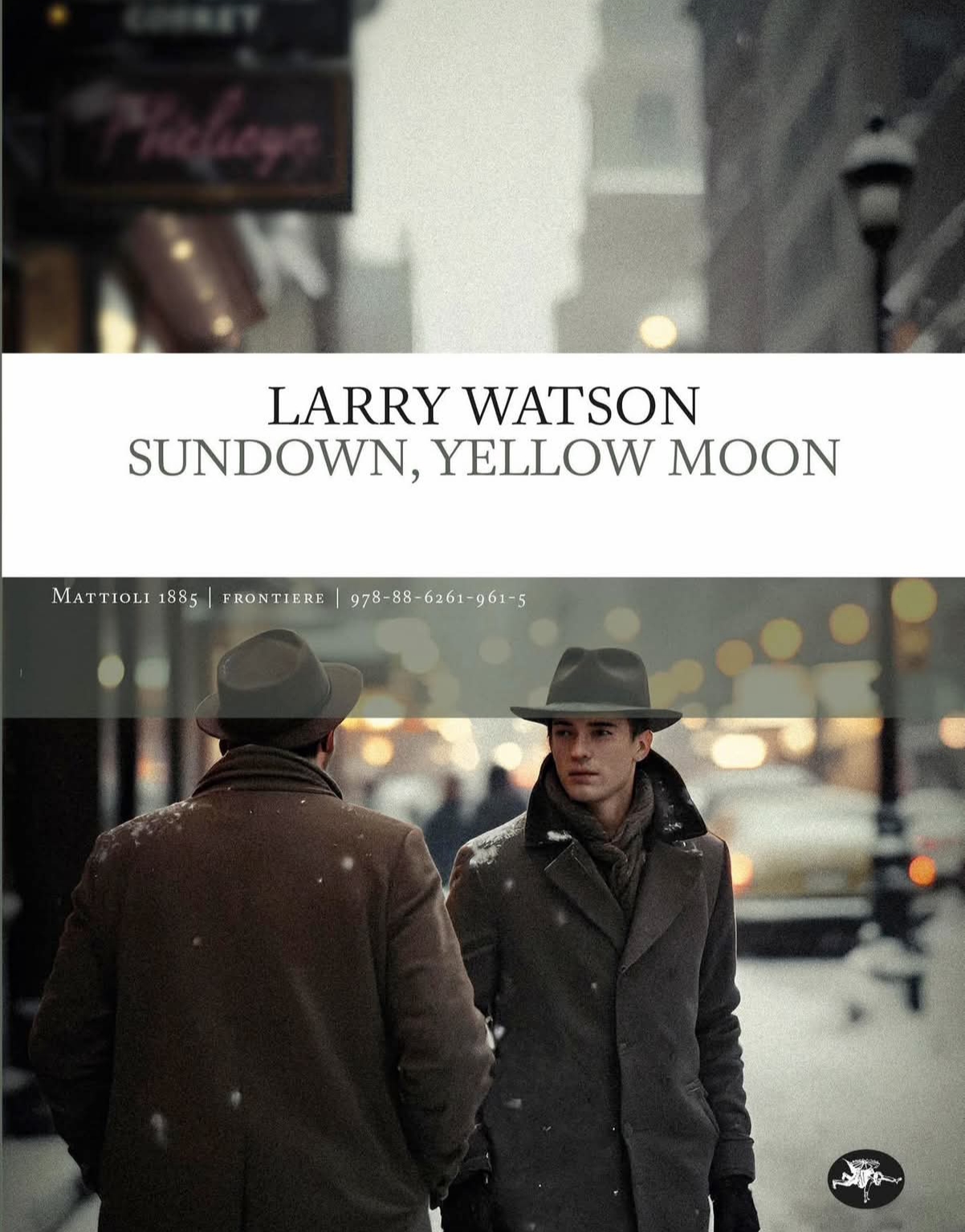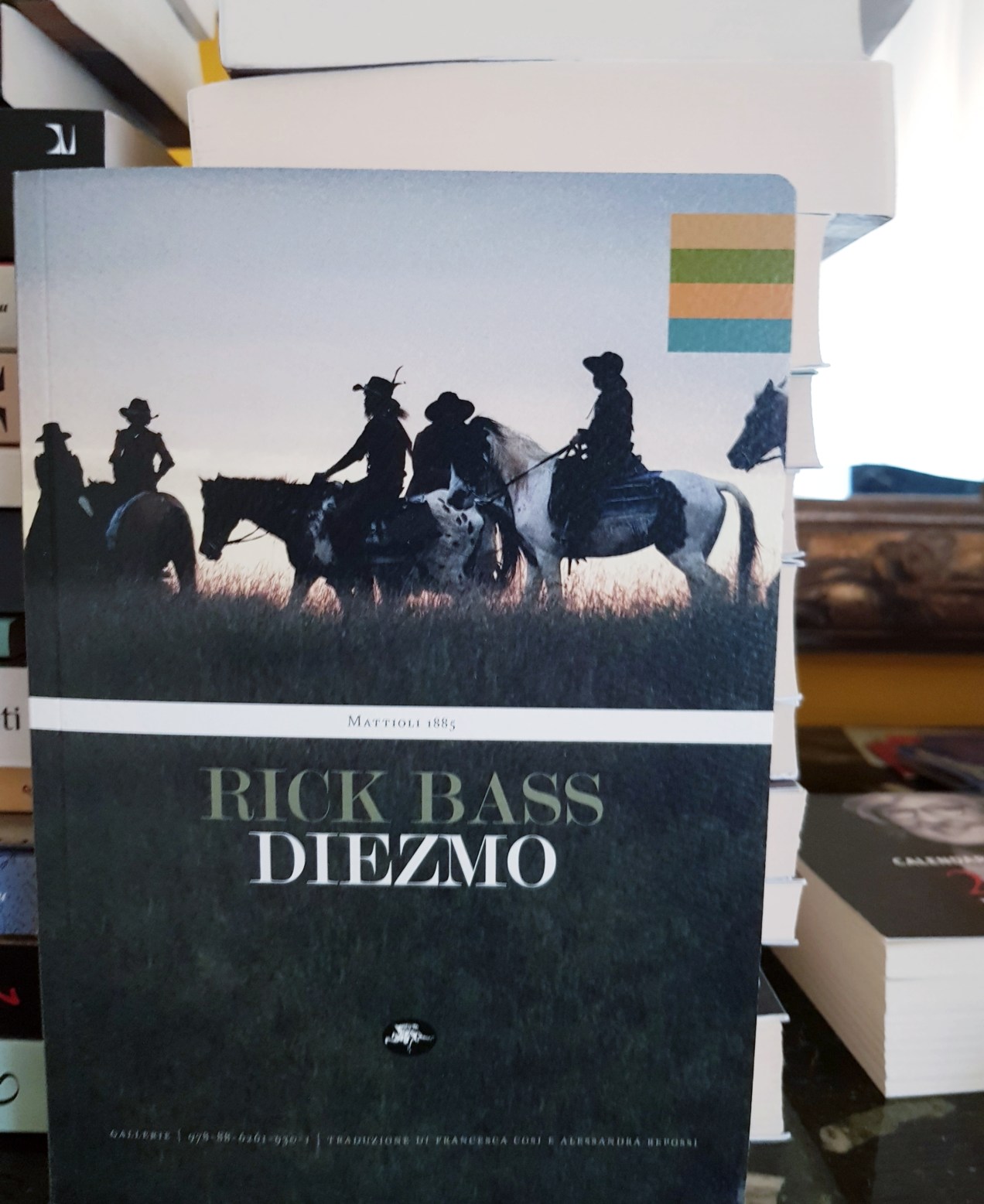Uscito negli Usa nel 1995 e pubblicato per la prima volta in Italia da Rizzoli nel 1998, Il colore dell’acqua torna in libreria in questi giorni con l’editore Fazi – che di McBride ha già pubblicato The Good Lord Bird (2021), Il diacono King Kong (2023), L’emporio del cielo e della terra (2024) – e la traduzione di Roberta Zuppet. Più che un romanzo è l’autobiografia dell’autore nonché il suo fortunato esordio nella narrativa. Tradotto in oltre venti paesi con milioni di copie vendute, il libro ha due voci narranti (quella di McBride e quella di sua madre, con paragrafi alternati in corsivo) e un bel po’ di ingredienti del Grande Romanzo Americano. Intanto è la storia di una migrazione e di una bizzarra mescolanza etnica: Rachel Deborah Shilsky, la madre di James e di altri undici figli, nasce nella Polonia invasa da Hitler, fugge ad Harlem, sposa un uomo di colore e viene ripudiata dai suoi familiari. Da questo momento Rachel diventa Ruth, Ruth McBride Jordan. In secondo luogo, è la storia di un sogno realizzato, forse sarebbe più corretto dire utopia: come si può immaginare che un ragazzino di colore cresciuto con una madre (bianca), un patrigno quasi assente e così tanti fratelli e sorelle arrivi a frequentare il college e a diventare uno scrittore di successo? Il romanzo è pieno di personaggi, alcuni importanti altri gregari, e nella sua parte in corsivo, quella in cui è Ruth a raccontare, incrocia un altro romanzo di McBride: L’emporio del cielo e della terra, le due storie si somigliano. Ma Il colore dell’acqua è soprattutto la storia di Ruth, di una donna stroardinaria, coraggiosa, spavalda, tenace, instancabile, a metà tra la Magnani di Mamma Roma e Ages Bain del romanzo di Douglas Stuart (Storia di Shuggie Bain). A cinquantuno anni, vedova del primo marito ma ancora “bella e sottile”, odiata da tutti, bianchi e neri, la vediamo andare in giro per Brooklyn su una vecchia bici azzurra, e governare la sua prole secondo gerarchie rigidissime “il sistema del re / regina”, mettendo al primo posto lo studio e la fede. Non era una materialista, pensava che senza la conoscenza la ricchezza non servisse a nulla, “che in America la cultura mescolata alla religione fosse il modo per uscire dalla povertà… Gli anni dimostrarono che aveva ragione”. La New York degli anni Sessanta è una metropoli tentacolare, scenario di mille vicende storiche, tra rivoluzioni, proteste, fermenti culturali: senza questo contorno neppure McBride sarebbe diventato James McBride. Ciononostante ne Il colore dell’acqua tutto si ripete secondo logiche artistiche nuove ed originali. Il romanzo di McBride, come la sua stessa vita, è un meraviglioso miscuglio di colori, di suoni e di storie americane.
Angelo Cennamo