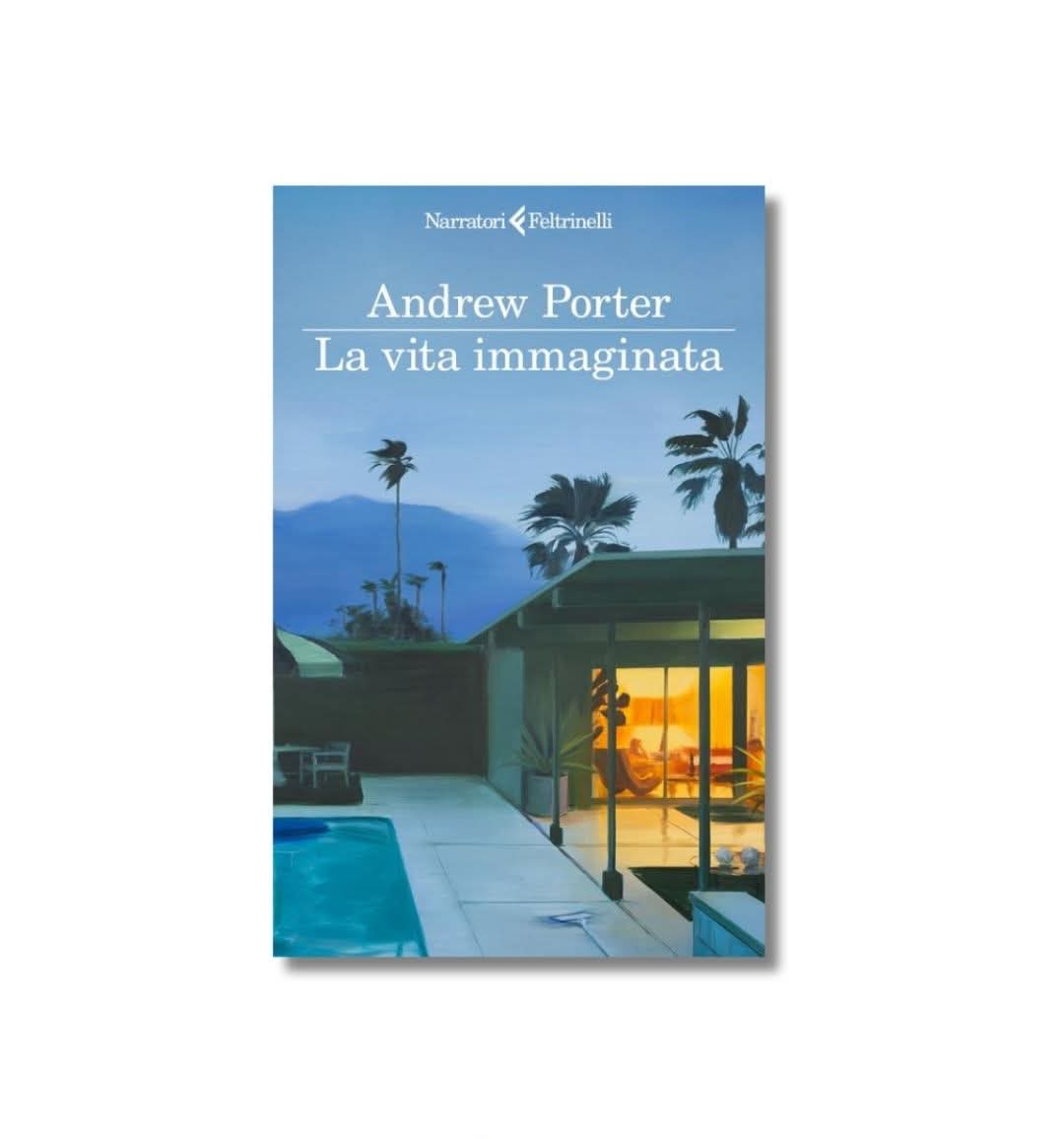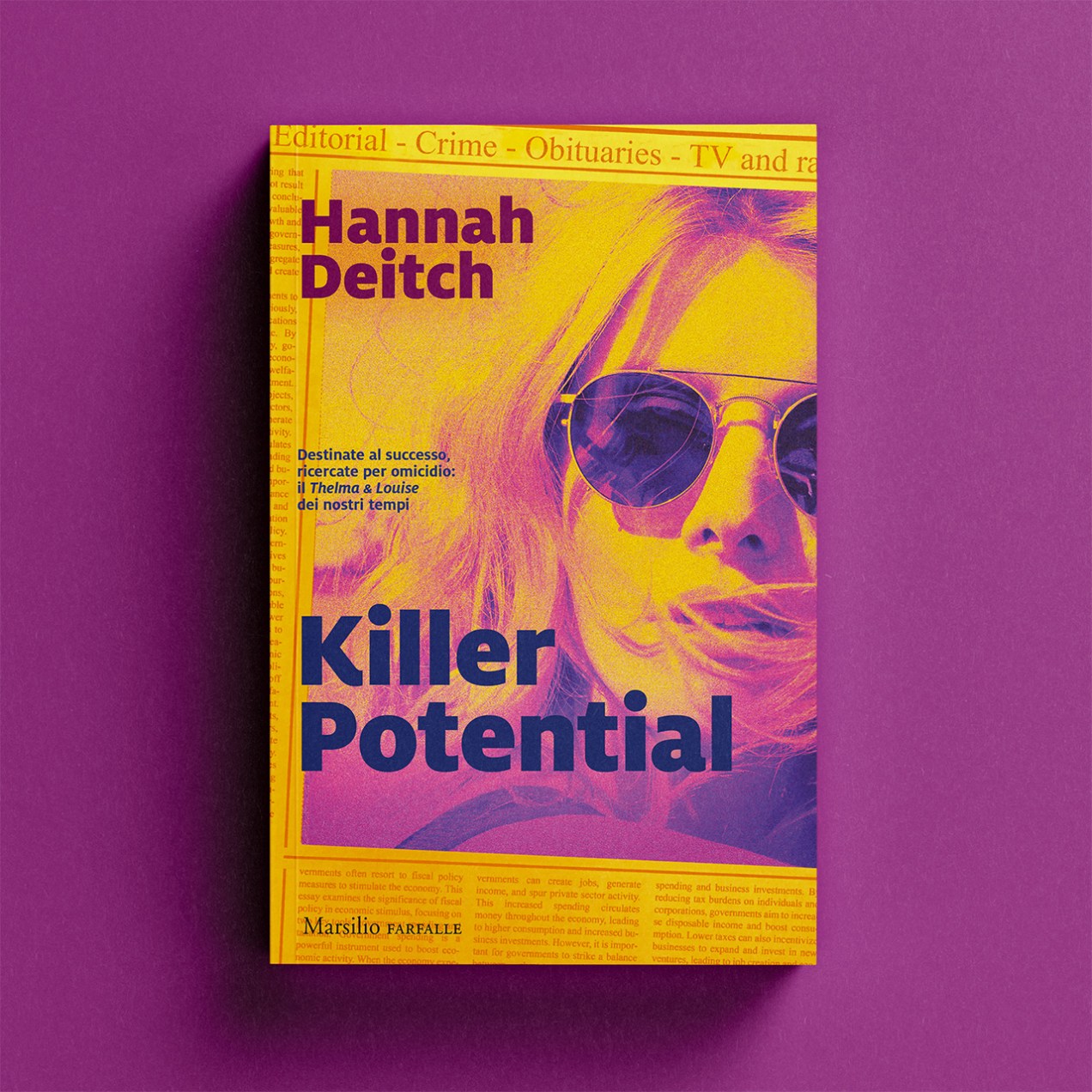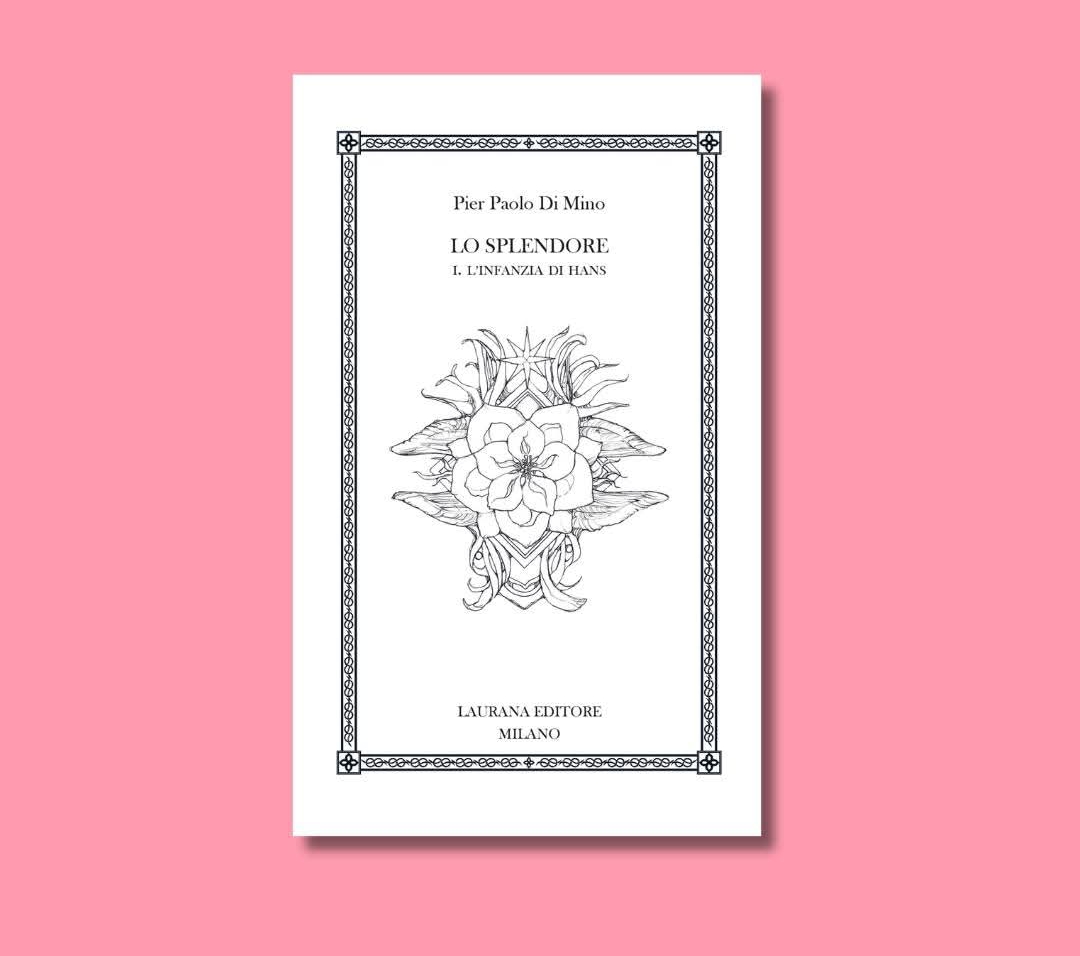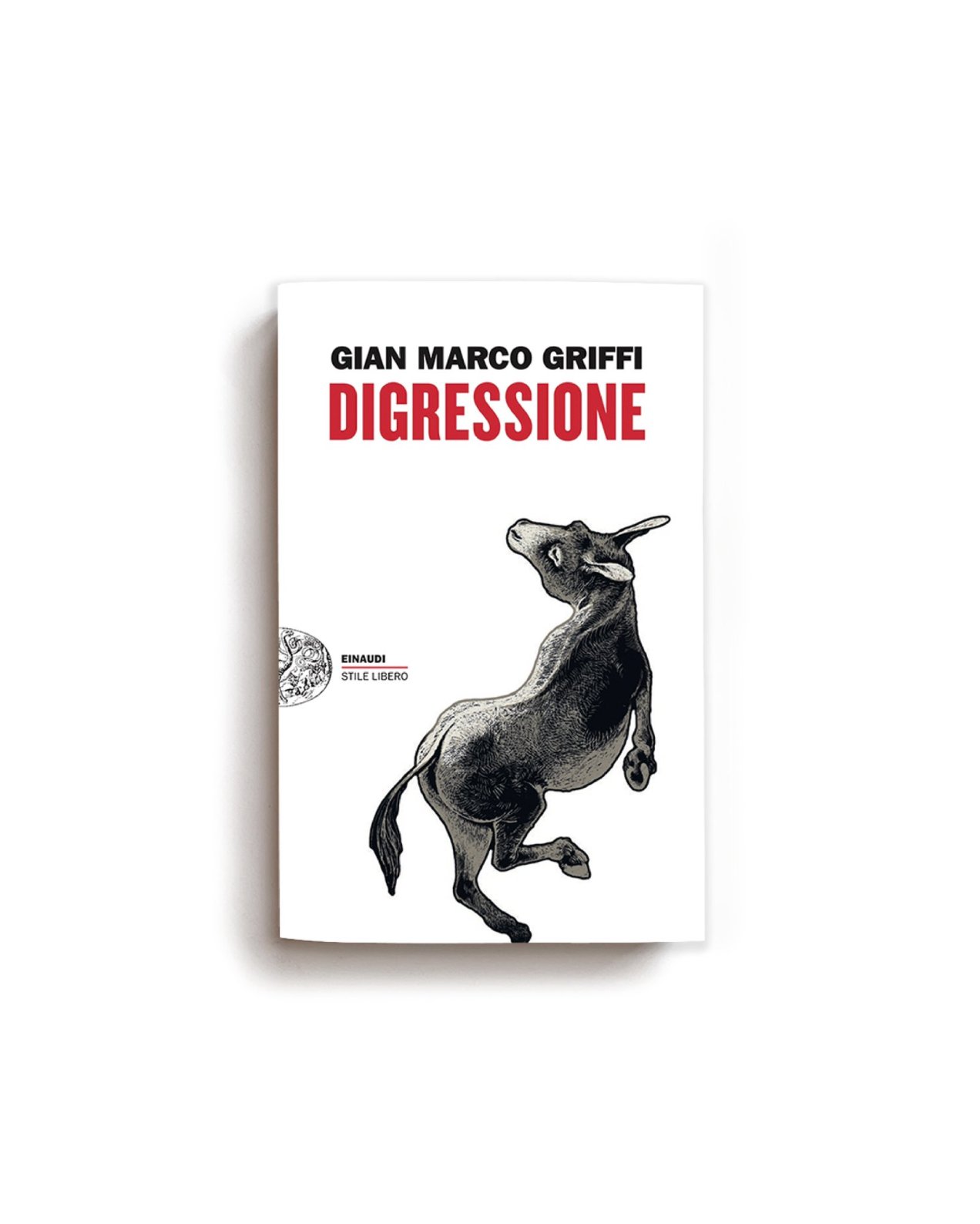Vent’anni dopo la mia prima lettura, ho ripreso Le correzioni di Jonathan Franzen durante l’ultima, incandescente settimana di luglio, rintanato in casa con l’aria condizionata a palla. L’intento iniziale era scrivere un pezzo intorno a una domanda solo in apparenza semplice: siamo finalmente riusciti a liberarci del clamore che accompagnò l’uscita del romanzo all’alba del XXI secolo? Man mano che avanzo nella rilettura, però, si è fatto strada un altro interrogativo, più urgente e sottilmente provocatorio: quale spazio/considerazione si è ritagliato il romanzo comico nella narrativa contemporanea? Un quesito che si impone con forza proprio nel caso de Le correzioni, romanzo tra i più osannati e divisivi della modernità recente, capace di affrontare il collasso affettivo e culturale di una famiglia americana con uno sguardo insieme tragico e irresistibilmente ironico. Uscito il 1° settembre del 2001, appena dieci giorni prima dell’attacco alle Torri Gemelle, il romanzo si è trovato a incarnare, quasi involontariamente, una cesura epocale. In un mondo che da lì a poco avrebbe riscritto le proprie narrazioni collettive, Le correzioni è parso fin da subito un libro-sismografo, capace di registrare le crepe già presenti nel tessuto sociale e psicologico dell’America post-Clinton: la disintegrazione del sogno borghese suburbano, la fragilità della famiglia nucleare, il tramonto dell’autorità maschile, la dissoluzione dei legami emotivi. Non sorprende che la stampa statunitense lo abbia accolto come “il Grande Romanzo Americano” dell’era postmoderna: non tanto per un’ambizione enciclopedica alla DeLillo o alla Pynchon, quanto per la capacità di restituire, con chirurgica precisione, il crollo di un ordine interiore più ancora che storico.
Al centro della storia – lo dico a beneficio dei pochi che non lo hanno (ancora) letto – troviamo i Lambert, famiglia del Midwest alle prese con una lenta e inesorabile disgregazione. Alfred, il patriarca, è un ingegnere ferroviario in pensione, simbolo vivente dell’ideologia del controllo e della razionalità, ormai divorato dal Parkinson e dalla demenza. Le sue allucinazioni — su tutte, la celebre scena del dialogo con feci animate — sono un vertice di grottesco psicologico: disturbanti e al tempo stesso toccanti, rivelano quanto fragile sia l’illusione del dominio di sé. La moglie Enid, ossessionata da una normalità borghese fatta di rituali vuoti e nevrosi domestiche, proietta nella cena di Natale un’impossibile restaurazione dell’armonia familiare. Ma i figli sono altrove, ognuno naufrago nel proprio fallimento: Gary, il primogenito, lotta con una depressione mascherata da efficienza e benessere; Denise, chef di talento, cerca di dare forma a un’identità sessuale ancora irrisolta; Chip, il più intellettuale, vede sfaldarsi ogni ambizione accademica, finendo in una farsesca, e profetica, vicenda di truffe finanziarie nell’Europa dell’Est. Eppure, nonostante l’impianto tragico, Le correzioni lo trovo un romanzo profondamente comico. Un aspetto troppo spesso trascurato, o relegato a mero “sollievo” narrativo, e che invece costituisce la chiave per comprendere l’unicità dell’opera. Il riso, in Franzen, non è mai evasione ma strumento di precisione morale: una lama sottile che incide le idiosincrasie linguistiche, i tic sociali, gli automatismi relazionali. La sua comicità, ereditata da autori come Saul Bellow e Philip Roth, è impastata di malinconia e di un’ironia corrosiva che scaturisce dall’osservazione spietata della borghesia americana, colta nel momento esatto in cui le sue finzioni iniziano a crollare. Quella di Franzen è una satira morale che non si compiace mai della distruzione. Non c’è cinismo nelle sue pagine, ma una compassione severa, un’attenzione umanissima per le contraddizioni dei suoi personaggi. In questo senso, Le correzioni rappresenta una scommessa riuscita: quella di fondere l’ambizione totalizzante del grande romanzo realistico con l’intimità psicologica del racconto domestico, trovando nel quotidiano una risonanza universale. È una delle ragioni per cui, nonostante l’evoluzione dei linguaggi letterari, tra autofiction, memoir e scritture ibride, il romanzo di Franzen conserva ancora oggi una sorprendente vitalità. Rileggere oggi Le correzioni significa confrontarsi con un’America diversa ma per certi versi ancora simile a quella rappresentata nel romanzo: le stesse fratture familiari, lo stesso senso di alienazione affettiva, la stessa precarietà identitaria. Temi che appaiono se possibile ancora più urgenti. Ed è forse proprio in questo che risiede l’attualità dell’opera: nella sua capacità di ridere del disastro senza mai banalizzarlo, di riconoscere nel dolore un fondo comune e condiviso, e nel riso una forma suprema di lucidità.
Angelo Cennamo