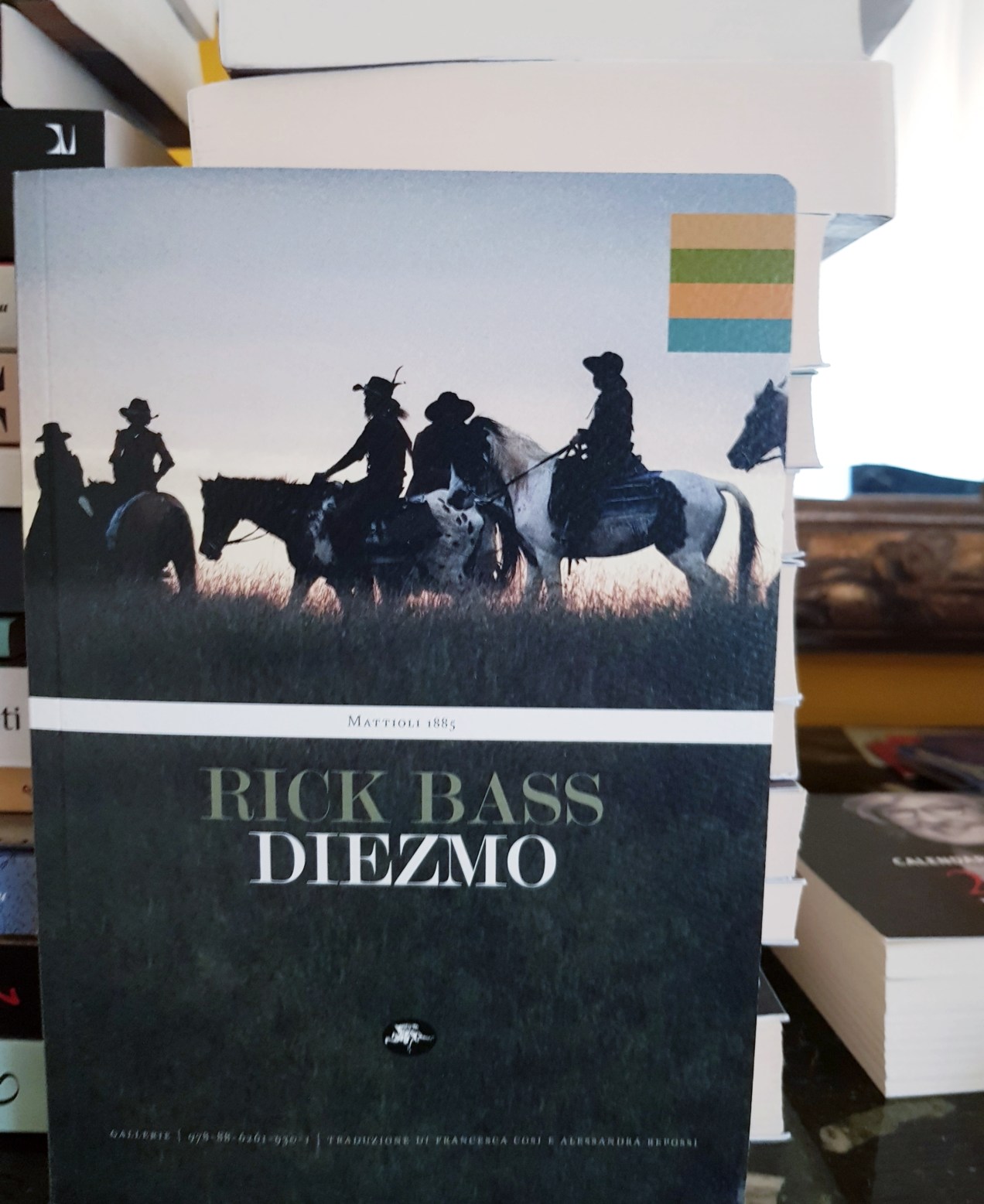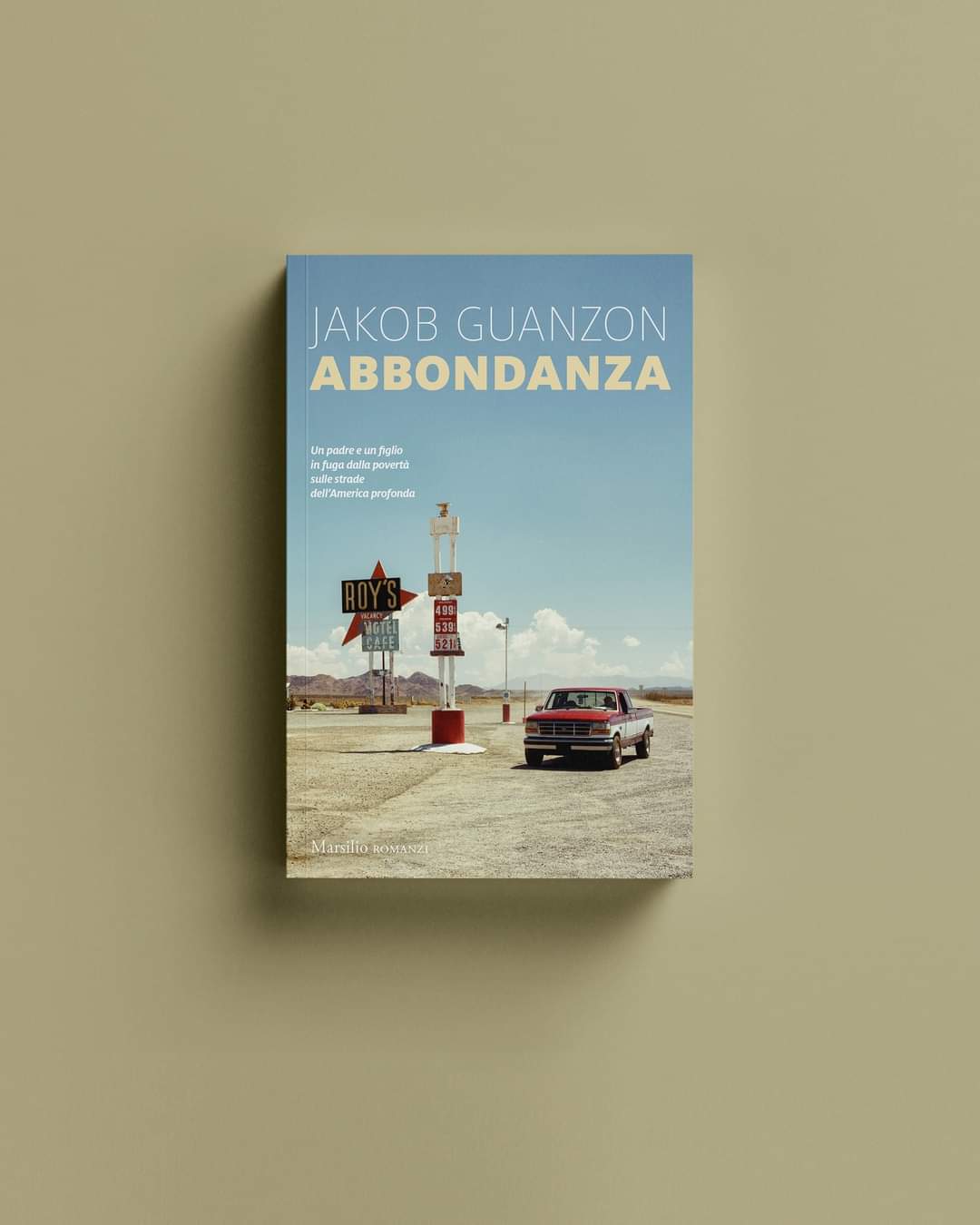Dramma in cinque atti. Un’opera teatrale dunque, scritta nella sua stagione più feconda, qualche anno dopo Meridiano di sangue e contemporaneamente alla Trilogia della frontiera. Teatro. Ma quale opera di Cormac McCarthy non ha a che fare col teatro, dagli abissi e le visioni di Stella Maris e de Il Passeggero ai tormenti di (Cornelius) Suttree? Il tagliapietre uscì negli Stati Uniti nel 1994 ma ebbe poca fortuna; oggi ne avrebbe avuta ancora meno, con l’autore processato di appropriazione culturale e minacciato ai reading o sotto casa da frotte di lettori woke: come si permette quello yankee di McCarthy di scrivere di quattro generazioni di neri? Il libro, in Italia in questi giorni con Einaudi e la traduzione di Maurizia Balmelli, racconta (molto brevemente, meno di 130 pagine) le vicende della famiglia Telfair, arrivata a Louisville, Kentucky, dalla Carolina del Sud. Il protagonista della pièce, ambientata perlopiù nella cucina di casa, è Ben, nipote dell’ultracentenario Papaw, un trentenne che ha riununciato agli studi universitari per fare il lavoro del nonno: lo scalpellino.
“Se non fosse stato per lui avrei fatto l’insegnante… Il mestiere non era nei libri. Ce lo tenevamo stretto al cuore. Ce lo tenevamo stretto al cuore ed era come un potere e sapevamo che non ci avrebbe tradito”.
Il testo è una specie di parabola biblica (“Un muro è fatto allo stesso modo in cui è fatto il mondo. Una casa. Un tempio”) nella quale Papaw assume il ruolo dell’Altissimo e Ben quello di Cristo. Big Ben, che al mestiere del padre e del figlio preferisce il cemento e che sguazza in affari loschi, è Giuda.
“All’origine di tutto… c’è il mestiere… La sua arte è la più antica che esiste”. L’uscita di scena del patriarca, saggio e silenzioso, innesca la spirale tragica del peccato e della morte. Non saprei dire se l’insuccesso de Il Tagliapietre sia derivato da una retorica un po’ forzata sulla condizione dei neri e in alcuni passaggi su quella delle donne: a pagina 46, sentiamo dire dalla sorella di Ben alla madre: “Tu pensi che gli uomini nascano con dei diritti che le donne non hanno. Che possano andare e venire come uccelli migratori e che sia perfettamente naturale… Certo che è naturale – risponde la madre – Tu cerchi di cambiare la natura”. Dettagli, forse. Nella profonda simbiosi tra Papaw e suo nipote Ben, ho rivisto lo stesso rapporto, ma capovolto, di Nick Molise col figlio Henry ne La confraternita dell’uva di John Fante, il più bel romanzo americano sulla paternità insieme a Patrimonio di Philip Roth. Come Papaw, Nick è uno scalpellino, ma Henry lo ha tradito scegliendo il mestiere dello scrittore. Pur di riavvicinarsi al padre, l’alter ego di Fante decide di seguire il vecchio in montagna con un furgone scassato, nel suo ultimo lavoro di muratore. “Un muro è fatto allo stesso modo in cui è fatto il mondo”, dice Ben sul palco di un teatro immaginario. Deve averlo pensato anche Henry, ne sono sicuro.
Angelo Cennamo