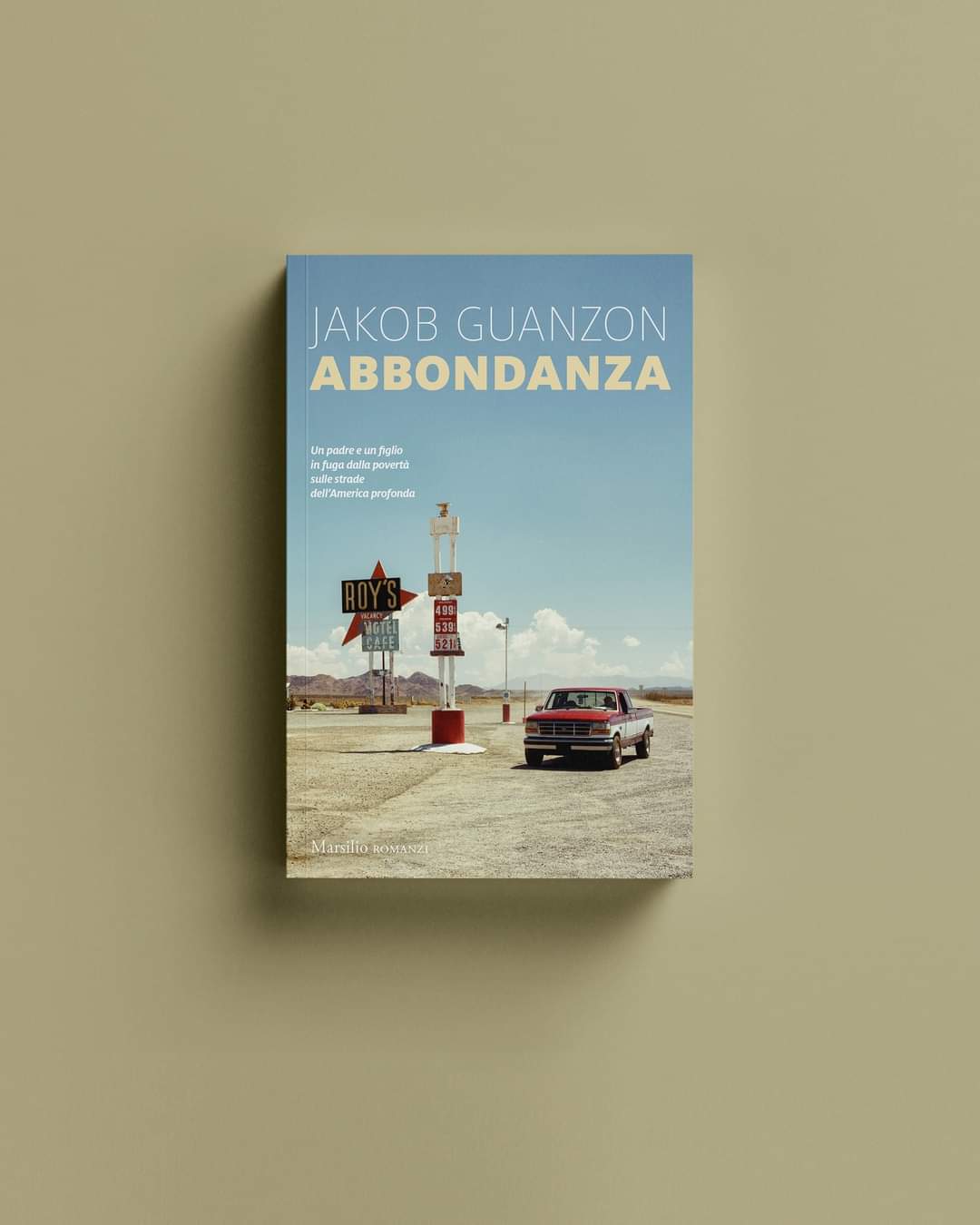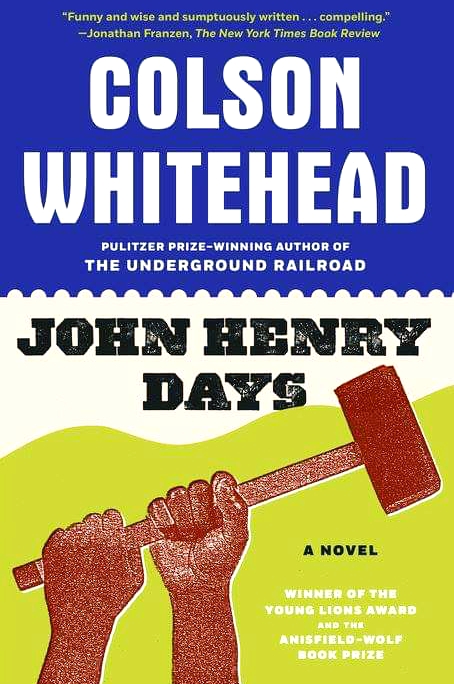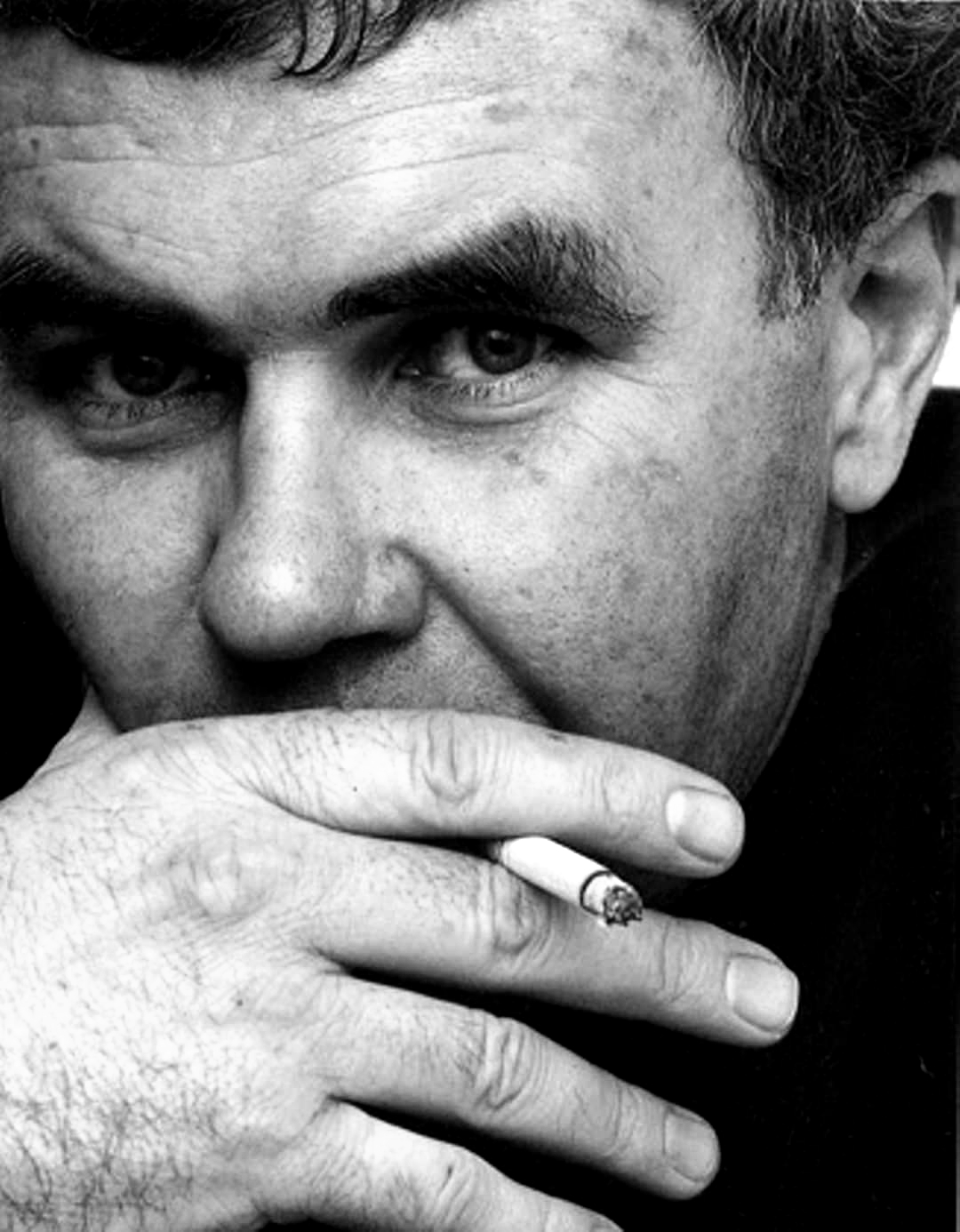“Io un lavoro ce l’avevo e Patti no. Lavoravo poche ore di notte in ospedale. Un lavoro da niente. Facevo qualcosa, timbravo il cartellino per otto ore e andavo a bere con le infermiere. Dopo un po’ Patti ha voluto mettersi a lavorare. Diceva che aveva bisogno di un lavoro per la propria dignità. E così si mise a vendere multivitaminici porta a porta”. Protagonista di Vitamine, uno dei racconti di Cattedrale, la raccolta uscita nel decennio più rivoluzionario della letteratura americana moderna (Leavitt, McInerney, Ellis, Foster Wallace, Franzen, Chabon), gli anni ’80, è una coppia fintamente felice. Di coppie infelici in queste storie, e nelle altre, ce ne sono diverse. L’incipit spiega bene il resto: poche parole senza enfasi scritte quasi contro voglia, con noia. Distacco. Le rileggo al tavolino di un bar di piazza Dante, nel centro di Napoli, mentre aspetto Valeria (Parrella) che su whatsapp mi avvisa che è saltata una corsa della cumana “Angelo, ci vorrà almeno un quarto d’ora”. Va bene. È una mattina grigia di ottobre, si è alzato un forte vento che sta facendo agitare gli ombrelloni ancora aperti e volare bicchieri di plastica. Ci saranno dieci gradi. Mi pento di essere uscito di casa con una misera t-shirt di cotone. Dal mio tavolo vedo la vetrina dell’ex libreria Pironti, leggendario talent scout napoletano che con pochi mezzi soffiò grossi autori americani alle corazzate dell’editoria nazionale. Tutto torna, penso: ecco perché Valeria ha voluto incontrarmi qui. Ah, dimenticavo, semmai non si fosse ancora capito: l’argomento della nostra conversazione è Raymond Carver. Si sono fatte le 10,00. Una monetina di sole fa capolino dai tetti dei palazzi di fronte. L’aria si è riscaldata. Meno male. Valeria mi raggiunge dall’altro lato della piazza: occhiali scuri, trench e una borsa di stoffa che a occhio conterrà qualche libro. Solo ora mi accorgo di aver ricevuto un altro suo whatsapp, le voci della piazza devono aver coperto il bip “Meglio del previsto, pochi minuti e sono lì”. Chissà come avrebbe scritto Carver su whatsapp e più in generale sui social. Carver ha inventato Twitter trent’anni prima di Twitter. Nessuno ha influenzato la letteratura contemporanea come lui, disse una volta Rick Moody. A chi lo definiva minimalista, quasi indispettito rispondeva “Precisionista, non minimalista”. Resta il fatto che quel faticoso lavoro di sottrazione eseguito sui testi era in netta controtendenza rispetto alla prolissità di altri autori, soprattutto europei, o al massimalismo argomentativo di chi prima di lui (Gaddis, Pynchon) e dopo di lui (Vollmann, Foster Wallace, Lerner, Cohen) ha proceduto per espansione invece di limitarsi all’essenziale. Quanto quest’opera di ripulitura possa attribuirsi allo stesso Carver o al suo editor Gordon Lish è difficile dirlo. Sui racconti di Carver Lish ha fatto di tutto: cambiato, sostituito, soprattutto accorciato, tanto che non sono pochi coloro che si interrogano sulla reale identità di Carver: era veramente lui o il suo editor? Per farvi un’idea di come Gordon “Mani di forbice” abbia manomesso le storie del suo pupillo vi basta confrontare due raccolte gemelle: Di cosa parliamo quando parliamo d’amore e Principianti, la versione integrale della prima, uscita qualche anno dopo senza i tagli dell’editor “Gli scrittori hanno bisogno dei loro editor quanto gli sportivi ne hanno dei loro allenatori, e a nessuno verrebbe da giudicare la prestazione di un nuotatore meno meritevole perché a bordo piscina qualcuno lo incita a mulinare le braccia più veloce” ha scritto Paolo Giordano nella prefazione del libro.
Come sai tutti i diritti sulle opere di Carver li controlla- è giusto controlla? Ne fa una supervisione, li esamina, li protegge, li custodisce…ec_ Tess Gallager. Quindi cosa succede, che se devi farne una nuova edizione per esempio italiana, l’editore prima cosa verifica che a Gallager piaccia il prefatore. Io dovevo scrivere su “Se hai bisogno chiama” e mandarono a Tess Gallager una mia raccolta di racconti tradotta in Usa da Europa Edition. Lei disse, ok, ma non deve scrivere che è minimalista. Ci ho pensato tantissimo su. Prima cosa perché l’ultima persona che mi ha detto nella vita cosa dovevo fare è stato mio padre quando avevo 16 anni, credo che dopo ho accettato solo consigli. Poi perché io ho solo la scrittura, quindi non la metto al servizio di ciò in cui non credo.Infine perché io avevo assunto su di me tantissime tantissime informazioni su Carver, di carattere biografico e critico, e ne ero stracolma. Dovevo dunque tornare a leggerlo, nuda, e chiedermi se potevo scrivere di Carver senza scrivere che è minimalista. È un esercizio difficilissimo destrutturarsi da lettore. Alla fine tutto questo paraustiello per dirti che sono sostanzialmente d’accordo. Precisionista non minimalista. Ho prefato, ed è finita così : Tess Gallagher is happy to approve this introduction. I wanted to share her message: I found Valeria Parraella’s essay very sincere and engaging as when someone shares a very personal but expansive encounter with a writer. I especially liked her connecting Ray to “To the Lighthouse”, one of my favorite books of all time. She hits her high note there at the end to realize that in Ray’s work the middle class actually can become a protagonist. Although she doesn’t go on to say so, this makes Ray’s work cast a much wider net across the planet than authors before him. Of course what we realize over here is that now Ray’s middle class has slipped its cogs and has become perhaps the lower middle-class. But this doesn’t diminish his reach, just re-calibrates it. Do thank them for providing the translation. I enjoyed it very much. So interesting her entrance into Carver via kind of the back door in these posthumous stories.
Come dicevo prima a proposito di Vitamine, nelle storie di Carver non accade niente di speciale oltre lo scorrere del tempo e un agire comune, apparentemente irrilevante, letterariamente parlando insignificante, come riparare un oggetto, ricevere una visita, ordinare una torta. In Attenti, altro racconto contenuto in Cattedrale, dopo aver litigato con la moglie, il protagonista va ad abitare in una mansarda. Il lettore non sa qual è la causa del litigio né se e come i due coniugi risolveranno la crisi. “Dobbiamo parlare”, dice lei, ma Carver concentra la sua attenzione su un fatto del tutto marginale: l’orecchio del marito è otturato, e la moglie, che un giorno decide di ribussare alla sua porta, glielo stappa.
Non è che non succede niente. Prima cosa c’è il grande problema base: di cosa sono fatti i libri? Di storia o di lingua? Nel migliore dei casi sono un sinolo aristotelico tra i due. Nel caso intermedio a me interessa la lingua. la trama… guarda la trama alla fine è una sceneggiatura. Non è così importante. Dunque Carver cosa fa? Mette solo le parole che servono, dentro le parole che servono c’è uno scrigno di informazioni che il lettore tira fuori dalla sua esperienza personale. Se io mi concentro sull’orecchio tappato do un sacco di notizie. So che c’è una consuetudine tra i due, so che si è in un momento intimo ma non romantico, di accudimento ma anche di fastidio, di necessità non grave. Chiunque di noi ha vissuto quello, e chiunque di noi così può essere precipitato in una storia che gli appartiene. Allora cosa vogliamo dire? Che nelle nostre vite non succede niente? Che sono irrilevanti per questo? Su un piano universale certo che lo sono, è rilevante solo che la terra abbia agganciato una nuova luna, ma sul piano della narrativa le nostre storie piccole quotidiane sono tutto: perché sono l’unico ambito in cui viviamo, dunque anche l’unico ambito di giudizio. A me questo mi fa volare. Restare in silenzio in una stanza presa in affitto mentre di là due coniugi anziani guardano la tv è la siepe di Leopardi: oltre c’è l’infinito.
In questi racconti c’è sempre un antefatto e un postfatto di cui non sappiamo nulla. Carver arriva al centro. È come se ci spalancasse una finestra per farci vedere cosa sta accadendo in quel preciso momento nella stanza. Carver fa con le parole quello che Edward Hopper fa con le immagini: ci mostra l’attimo in cui tutto è già accaduto.
Sì ma questa è la misura del racconto. Cosa fai in un racconto? Entri nella stanza con il letto già disfatto e decidi se l’ha buttato per aria un ladro o una coppia che ha scopato tutta la notte, poi esci. È il racconto che fa questo. A te non piacciono i racconti, ma secondo me puoi affinarla questa cosa, puoi venire anche tu nella terra dove ti consegnano un nucleo incandescente. Quello che tu chiami il centro è il nucleo incandescente. Hopper è più freddo, più elegante, più upperclass. Carver soffre come una bestia. Ti ricordi quando mettesti su X una foto on the road e io ti dissi che la piana di Battipaglia o la Route 66 hanno un sentire che si somiglia? Ecco, io a Carver riconosco quella fatica. Ma forse sono io. Se io non avessi letto Carver e non ci avessi visto dentro la piana di Battipaglia oggi farei un altro lavoro e io e te non staremmo prendendo questo caffè.
I protagonisti delle storie di Carver non sono né degli eroi né persone comuni, sono uomini e donne sull’orlo di un’infelicità che si sta cronicizzando. Ricordano molto i personaggi di un altro gigante del realismo minimalista: Richard Yates. Ma se i personaggi di Yates inseguono un sogno senza raggiungerlo, quelli di Carver il sogno manco lo inseguono, perché sarebbe tempo sprecato.
Voilà. perfetto. Lui è il cronista dell’infelicità. mica un ruolo semplice? lo psicopompo americano, un hermes traghettatore, con tinte molto evidenti, pensa per esempio alla torta di compleanno. A me viene mal di stomaco solo a pensarci, o alla stessa sequenza finale delle guglie della cattedrale disegnate a occhi chiusi…è molto significativo questo ossimoro che usi “giganti del minimalismo”, ci hai pensato?
Carver ha scritto solo racconti e poesie, non si è mai confrontato con la forma del romanzo. Apparentemente può trattarsi di una libera scelta dettata dal gusto personale, da un’attitudine; probabilmente un’esigenza più terra terra: la perenne corsa contro il tempo per consegnare in cambio di poco e subito. Carver scriveva con i figli piccoli che gli urlavano addosso e le bollette di luce e gas che si accumulavano sul frigo. È complicato concentrarsi per anni su un romanzo se rischi uno sfratto per morosità.
Gli americani amano raccontarla così, anche Alice Munro diceva sempre “scrivo racconti perchè ho 3 figli”, ma io sono italiana vengo da lo cunto de li cunti, da Boccaccio, da Pirandello, Verga, Banti, Ortese, non lo penso affatto. Scrivere un racconto è una cosa difficilissima, non puoi letteralmente sbagliare una parola, non un rigo, una parola. È un afflato. Ogni cosa che scrivi porta già in sé la sua misura, non c’entrano nulla le condizioni esterne. Rispetto al consegnare e pubblicare poi comprendi bene che c’è un abisso tra il mercato americano che ama i racconti e quello italiano che quasi li tiene in spregio. L’altro giorno Lorenzo Marone mi ha chiesto se avessi faticato a pubblicare racconti. No. Ma già che mi abbia fatto la domanda la dice lunga. (Dostoevskij aveva sempre lo sfratto, la vecchia si prende un’ascia in testa perché è una padrona di casa- eppure quante pagine sono delitto e castigo?)