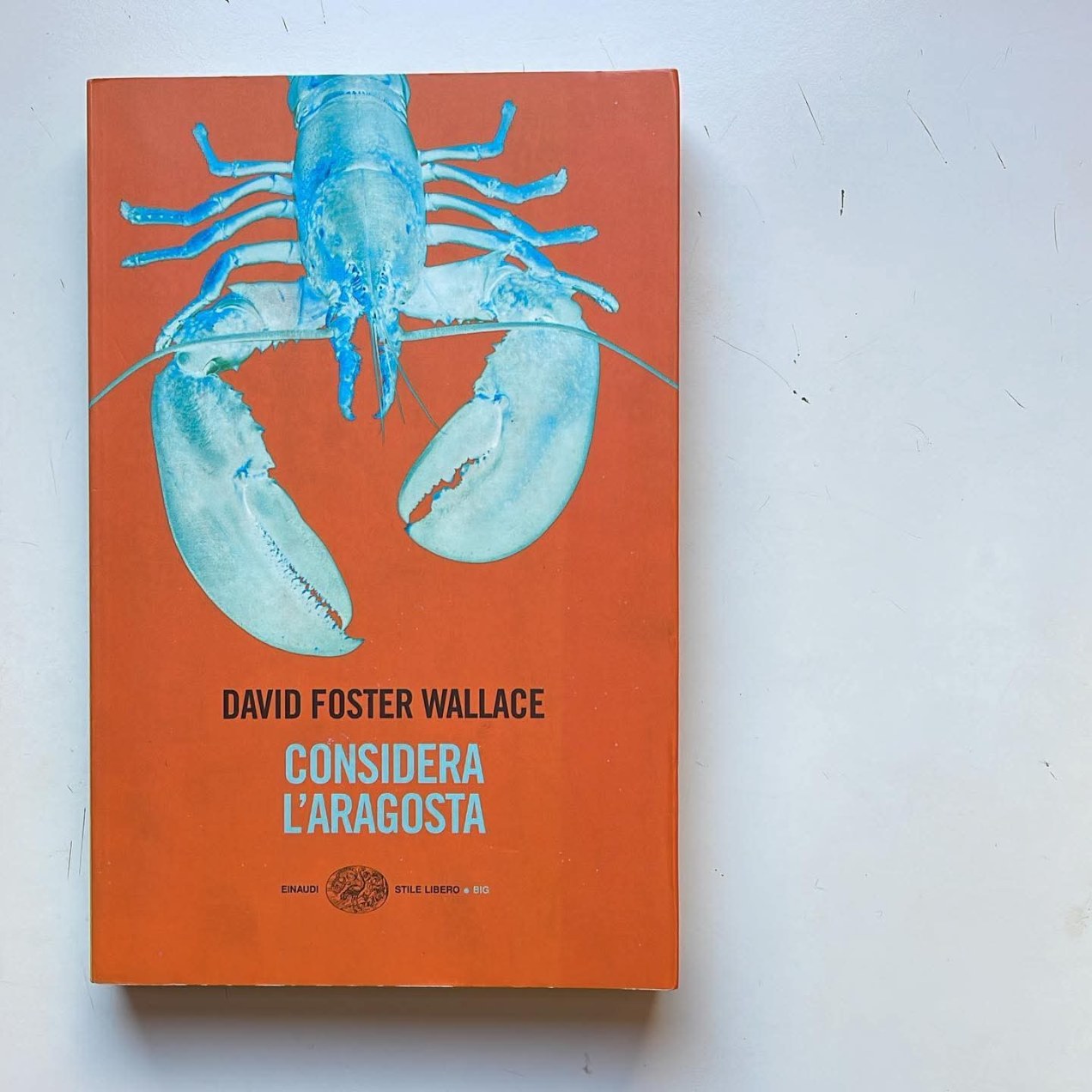Romanziere fallito, ex giornalista sportivo, ex marito, alla soglia della mezza età: nonostante tutto, Frank Bascombe è un ottimista. O forse, più precisamente, è un uomo che ha deciso di non concedersi più il lusso della lamentela. Protagonista de Il giorno dell’Indipendenza (Independence Day), secondo capitolo della pentalogia che Richard Ford dedica al suo personaggio più celebre, Bascombe incarna una delle figure più riuscite dell’everyman americano tra gli anni Ottanta del Novecento e i Venti del nuovo secolo: disilluso ma resistente, ironico ma ferito, capace di una filosofia pratica che non promette salvezza, bensì una forma di dignitosa sopravvivenza. Frank vive e lavora nel New Jersey come agente immobiliare, attraversando in auto sobborghi, strade congestionate e quartieri residenziali mentre mostra case in vendita a clienti ansiosi e indecisi, come i coniugi Markham del Vermont. Ma il suo mestiere è molto più che una professione: è una vera e propria metafora esistenziale «Non vendi una casa a qualcuno, vendi una vita». Le abitazioni che Frank propone sono spazi potenzialmente abitabili ma mai davvero abitati, gusci di promesse e aspettative che raramente trovano compimento. Allo stesso modo, la sua stessa vita è un continuo passaggio tra possibilità mancate e tentativi di stabilità destinati a rimanere provvisori. Nulla, nel mondo di Ford, è definitivo; tutto è reversibile, precario, esposto all’erosione del tempo. Dopo il divorzio dalla moglie Ann, Bascombe decide di entrare in quello che definisce il “Periodo di Esistenza”: una fase sospesa, quasi ascetica, in cui rinunciare alle grandi ambizioni, ai giudizi assoluti e persino all’illusione di comprendere pienamente se stessi. L’obiettivo non è la felicità, ma la tenuta. «Si può fare in modo che le cose vadano per il verso giusto solo fino a un certo punto»: questa dichiarazione di resa parziale costituisce il vero nucleo etico del romanzo. Ford rifiuta tanto la retorica della redenzione quanto quella del fallimento totale, proponendo invece un’idea di maturità fondata sull’accettazione del limite, sull’assunzione di una responsabilità imperfetta ma concreta. Il lungo weekend del 4 luglio, festa simbolica per eccellenza dell’identità americana, diventa la cornice narrativa entro cui far convergere i nodi irrisolti della vita di Frank. Accanto a lui ci sono Sally, la nuova compagna, e soprattutto Paul, il figlio quindicenne che vive nel Connecticut con la madre ed è seguito dai servizi sociali dopo essere stato arrestato per un episodio tanto grottesco quanto rivelatore: il furto di tre confezioni giganti di preservativi e l’aggressione a un commesso. Paul è un ragazzo fragile, inquieto, incapace di trovare un linguaggio per il proprio dolore, segnato non solo dal divorzio dei genitori ma, più profondamente, dalla morte prematura del fratello Ralph. È su di lui che il romanzo concentra il suo peso emotivo maggiore, trasformando il conflitto generazionale in una riflessione più ampia sulla trasmissione del trauma e sull’eredità del fallimento. Il viaggio in macchina di Frank e Paul assume la forma di un classico road novel americano, ma Ford ne svuota deliberatamente la componente mitica. Non c’è qui la promessa di libertà, né l’illusione di una fuga rigeneratrice. Al contrario, la strada diventa uno spazio claustrofobico, attraversato da ingorghi di turisti, motel anonimi, soste forzate e fuochi d’artificio che illuminano solo per un istante il buio circostante. È un percorso di avvicinamento doloroso, fatto di silenzi, incomprensioni, scarti improvvisi e flashback malinconici. Il finale, tragico e brusco, rifiuta ogni consolazione facile, ma lascia intravedere la possibilità di una consapevolezza più profonda: non una soluzione, bensì una maggiore lucidità di fronte alla perdita. A distanza di quasi trent’anni, Ford tornerà su quella stessa figura narrativa — il viaggio condiviso, l’abitacolo (del furgone) come spazio di confronto forzato — nell’ultimo romanzo della serie, Per sempre (Be Mine). Qui Paul ha ormai quasi cinquant’anni ed è gravemente malato; Frank, oltre i settanta, lo accompagna in un ultimo viaggio verso una clinica sperimentale. Come nel romanzo del 1995, Frank resta un padre incapace di salvare il figlio, ma ostinatamente deciso a non sottrarsi alla presenza. Se in Il giorno dell’Indipendenza il viaggio era segnato dall’incomunicabilità e dall’angoscia di un futuro opaco, in Per sempre è il tempo stesso a farsi nemico, e l’urgenza non è più quella di “raddrizzare” una vita, ma di accompagnarla fino al limite. Letti insieme, questi due viaggi incorniciano l’intera parabola morale di Bascombe: dall’illusione residuale di poter ancora incidere sul destino del figlio, alla consapevolezza finale che l’unica forma possibile di amore è la prossimità, anche quando non produce alcun risultato. Paul diventa così il luogo in cui si concentrano tutte le contraddizioni dell’etica bascombiana: la responsabilità senza onnipotenza, l’affetto senza redenzione, la fedeltà senza speranza.
Il giorno dell’Indipendenza si può leggere come un romanzo sulla disgregazione della famiglia e sulle difficoltà strutturali dei rapporti umani? Direi di sì. Tuttavia, a differenza di altri autori del realismo americano — si pensi per esempio a Malamud e ai suoi protagonisti schiacciati da un destino ostile — Ford evita tanto l’autocommiserazione quanto la retorica del colpevolismo. I fallimenti dei suoi personaggi non sono il frutto di una malasorte metafisica, ma di una rete di scelte, omissioni e negligenze quotidiane. È proprio questa responsabilità diffusa, mai del tutto esplicitata ma sempre percepibile, a rendere il dolore più autentico e meno melodrammatico. Anche nei momenti più cupi, il romanzo è attraversato da una vena di comicità sottile e da un ottimismo moderato. Non l’ottimismo ingenuo di chi crede che tutto si aggiusterà, ma quello più sobrio e resistente di chi accetta che non tutto è perduto. Frank Bascombe non è né un eroe né un vinto: è un uomo che resiste, che continua a muoversi nonostante la consapevolezza della propria fragilità.
Pubblicato nel 1995, Il giorno dell’Indipendenza ha consacrato definitivamente Richard Ford tra i giganti della letteratura americana contemporanea — l’anno successivo il romanzo ha vinto sia il Premio Pulitzer che il PEN/Faulkner. Come il suo personaggio, Ford ha abbandonato il giornalismo per un’altra professione e ha attraversato un divorzio, ma Bascombe non va letto come un semplice alter ego. È piuttosto un dispositivo letterario complesso, attraverso cui lo scrittore esplora soprattutto le contraddizioni dell’identità maschile americana nel tardo Novecento. Resta una nota dolente per il lettore italiano: la traduzione. In diversi passaggi, le scelte lessicali risultano non solo discutibili, ma apertamente fuorvianti, come se l’attenzione al senso letterale avesse prevalso sulla comprensione del contesto culturale e dell’immaginario fordiano. Quando nel 1964 Joe Markham non era “piccolo” ma “fagiolo”, il problema non è soltanto terminologico: è l’intonazione di un ricordo che si incrina. Ancora più emblematico è il caso del brano in cui Ford descrive un biker fermo sul ciglio della strada:
“I pass a lone and leathered biker, standing on the shoulder beside his broken-down chopper just watching, taking it all in across the panoramic estuary, trying, I suppose, to imagine how to get from here to there, where help might be”
in italiano diventa:
“Sorpasso un ciclista solitario e vestito di pelle, in piedi sul bordo della strada accanto al suo mezzo in avaria…”
Il biker si trasforma così in un ciclista, e la chopper in una bicicletta. Non si tratta di un dettaglio marginale o di un semplice refuso: Ford costruisce il suo mondo per accumulo di immagini culturalmente connotate, e la figura del motociclista non è certamente sovrapponibile a quella di un ciclista. Alterare un elemento così iconico significa compromettere il tono della scena e impoverire l’immaginario del romanzo. È un errore che non distrugge l’opera, ma la sfoca, e che lascia l’amaro in bocca proprio perché Il giorno dell’Indipendenza è un libro che vive di precisione, di differenze minime, di sfumature morali e visive.
Angelo Cennamo