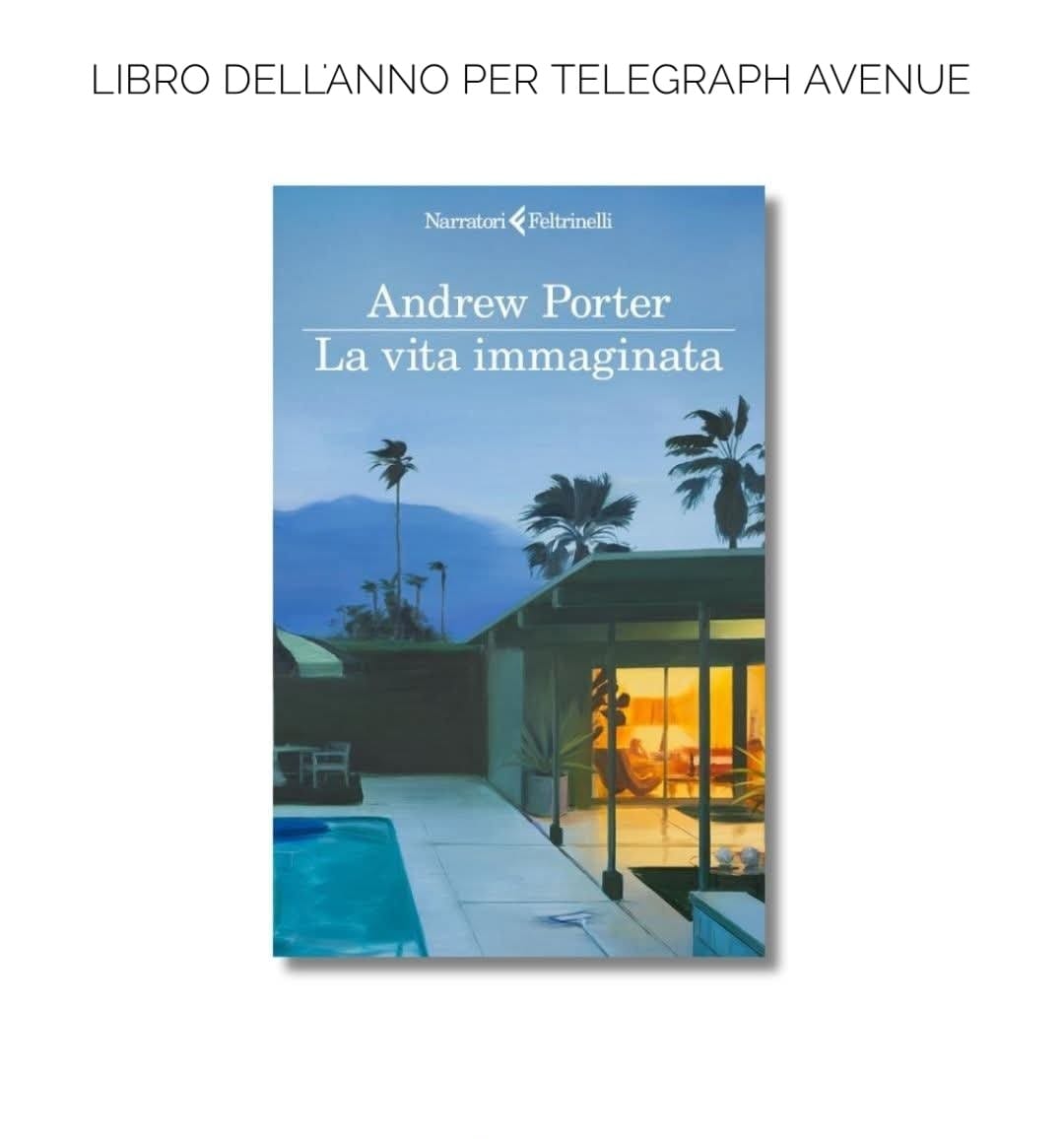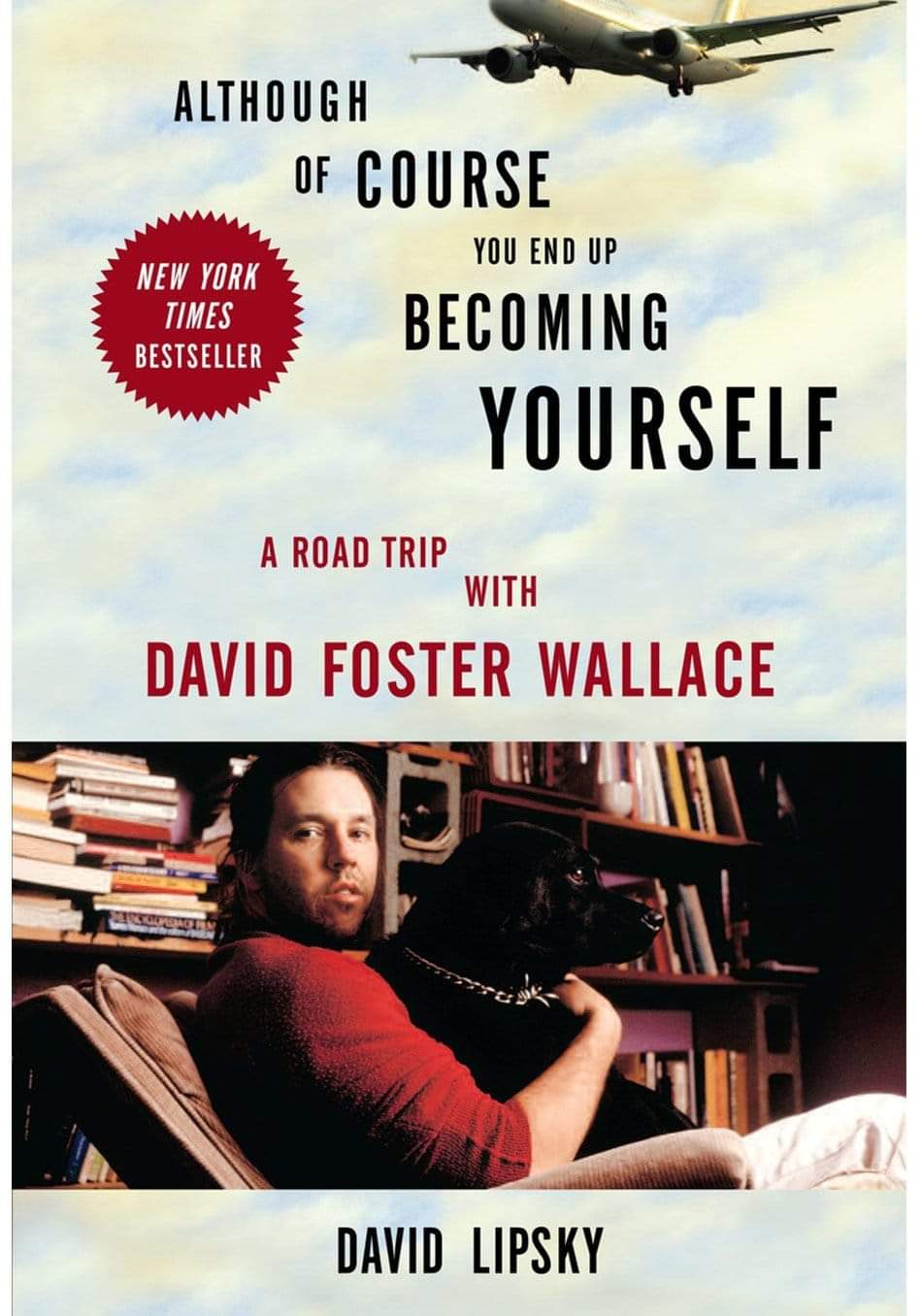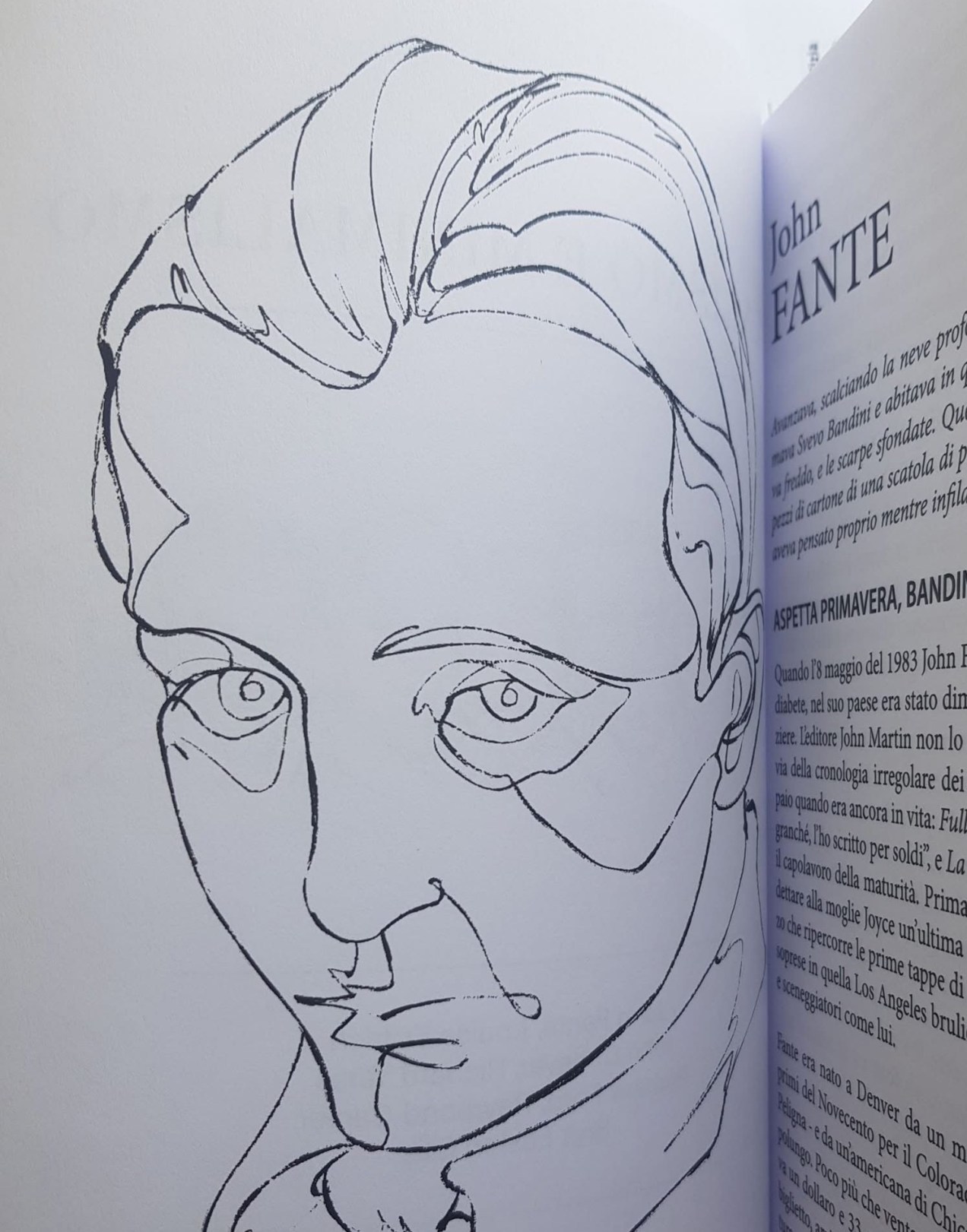Tutti vogliono possedere la fine del mondo, scrive DeLillo nell’incipit di Zero K. È un concetto che forse non appartiene al progetto estetico di Cormac McCarthy; eppure, come un’eco distante che rimbalza da un’estremità all’altra del panorama letterario americano contemporaneo, questo pensiero può funzionare come varco d’accesso alla sua ultima impresa narrativa. Non perché McCarthy condivida la prospettiva di DeLillo sulla tecnicizzazione dell’apocalisse, ma perché entrambe le poetiche sono attraversate dalla medesima ossessione: la soglia finale, la linea che separa ciò che è conoscibile da ciò che non lo è. Ma proviamo ora a oltrepassarla, questa soglia introduttiva, per entrare nello spazio più scabro, enigmatico e insondabile, del dittico Il passeggero – Stella Maris. Per comprendere appieno la funzione e l’ambizione di questi due romanzi gemelli, in America usciti in contemporanea, è necessario collocarli all’interno di un percorso di oltre quarant’anni, che ha progressivamente spostato il centro di gravità della narrativa mccarthiana dall’epica della violenza alla metafisica della conoscenza. Gli esordi dello scrittore, segnati dall’influenza di Faulkner, dall’ossessione per il peccato originale e dalla costruzione di paesaggi rurali popolati da creature abbandonate alla propria ferinità, definiscono una prima stagione in cui il male appare come fatto ontologico, inscritto nell’ordine stesso dell’esistenza. In romanzi come Suttree, il confine tra eros e distruzione, tra rivelazione e degrado, si fa labile: il protagonista, eremita urbano sospeso tra povertà e intuizioni improvvise, esplora una città e un mondo in cui la bellezza e la violenza coesistono senza soluzione di continuità, e dove il linguaggio alterna lirismo e brutalità con una maestria che trasforma la scrittura in esperienza fisica. Con la trilogia della frontiera, McCarthy porta questa visione oltre il perimetro geografico e psicologico del Sud gotico. La frontiera, più che essere un altrove da conquistare, diventa un confine in continua retrocessione, uno spazio in cui l’individuo scopre la sproporzione tra il proprio desiderio di senso e un mondo che gli oppone solo indifferenza. In questa tensione si annida il nucleo filosofico del narratore: l’uomo è sempre chiamato a misurarsi con forze che eccedono infinitamente la sua comprensione, e la frontiera stessa diventa metafora del limite conoscitivo dell’umano. Questa intonazione raggiunge la sua formulazione più radicale in Meridiano di sangue, opera che Harold Bloom colloca accanto ai massimi monumenti della letteratura americana. Il Giudice Holden, incarnazione lucida e terrificante del male, rappresenta l’ipotesi estrema della visione mccarthiana: la violenza come grammatica cosmica, il male come principio ordinatore della realtà. Nel paesaggio post-apocalittico ridotto a cenere de La strada, la lingua viene distillata fino all’essenziale: la narrazione ridotta all’osso diventa riflesso della devastazione ambientale, e il legame fragile tra padre e figlio si erge come ultimo residuo di senso. Se in Meridiano di sangue la verità ultima era il male cosmico, ne La strada la verità è il resto che resiste al nulla, la scintilla di umanità in un universo disumanizzato. Dopo La strada, il silenzio sedicennale non rappresenta un vuoto creativo ma un laboratorio invisibile in cui McCarthy riorienta il proprio sguardo. Con Il passeggero e Stella Maris, pubblicati ormai novantenne, non assistiamo a una sintesi dell’opera mccarthiana, ma a un mutamento di scala radicale: la violenza lascia il posto alla conoscenza, la frontiera fisica si trasforma in frontiera epistemica, e il conflitto non si svolge più nei paesaggi della prateria o del deserto, ma negli spazi intricati della mente. Tra i due romanzi, Stella Maris costituisce il nucleo teorico e il motore concettuale. Composto quasi interamente da dialoghi tra Alicia Western, ventenne genio matematico affetta da schizofrenia paranoide, e lo psichiatra Cohen, il libro esplora la tensione tra potenza cognitiva e fragilità mentale. Alicia non è la figura stereotipata del genio maledetto: rappresenta piuttosto una mente che percepisce strutture del reale incompatibili con la salute mentale. La sua relazione con la matematica, disciplina che McCarthy sceglie come strumento privilegiato per sondare l’ordine primordiale del mondo, è ontologica: la matematica non è mera tecnica né estetica, ma forma stessa del pensiero. Il linguaggio, in confronto, appare inadeguato e talvolta ridicolo di fronte alla vastità della percezione che la mente di Alicia intercetta. I riferimenti a Wittgenstein non sono semplici ornamenti colti: per Alicia, la filosofia del linguaggio rappresenta l’epicentro della crisi cognitiva. Se “i limiti del linguaggio sono i limiti del mondo”, il suo mondo si rivela troppo vasto per essere contenuto. Gli episodi allucinatori, trasposti in corsivo ne Il passeggero, non segnano un cedimento psicologico ma l’espressione estrema di un’intelligenza che ha oltrepassato il punto di saturazione. La presenza del padre, scienziato coinvolto nel Progetto Manhattan, conferisce a questa crisi una dimensione etica: la conoscenza avanzata produce colpa, e il peso della responsabilità morale diventa insopportabile. Il passeggero fa da contrappunto a questa riflessione teorica, assumendo sulla propria trama la colpa della conoscenza. La vicenda, il ritrovamento di un aereo affondato, intatto ma privo della scatola nera e di un passeggero, funziona solo apparentemente come mistero investigativo. In realtà, il vuoto, ciò che manca, diventa la materia del racconto. Bobby Western, fratello di Alicia, attraversa un’America sospesa, in cui la storia sembra aver perso ogni tensione verso il futuro. Le sequenze liriche della sua deriva, che richiamano i momenti migliori di Suttree, mostrano un uomo che non fugge da un potere, ma da un vuoto cognitivo, affettivo e ontologico. L’amore incestuoso e non consumato tra i due fratelli non è un espediente scandalistico, ma la rappresentazione simbolica del divario tra ciò che l’umano vorrebbe comprendere e ciò che inevitabilmente gli sfugge: Alicia implode nel pensiero, Bobby nel mondo.
Nel loro insieme, il dittico non è un romanzo filosofico in senso accademico, semmai un’opera che utilizza la filosofia e la matematica per tracciare i limiti della mente umana. In questo gesto, sorprendente per un autore che ha sempre privilegiato la corporeità e l’azione, McCarthy compie uno spostamento radicale: dalla fisicità della frontiera e della violenza, alla speculazione pura, alla frontiera dell’intelletto. Tuttavia, anche in questa nuova prospettiva, permane la costante ossessione della sua letteratura: l’uomo è gettato in un universo che non può comprendere, ma al quale non può smettere di porre domande. Il passeggero e Stella Maris non sono un testamento consolatorio di un grande vecchio della letteratura americana, ma un’ultima sfida posta al lettore: accettare che la conoscenza non redime, che il linguaggio non salva, che la mente può naufragare quanto nel deserto di Meridiano di sangue o nelle strade bruciate de La strada. Il loro contributo all’opera di McCarthy non consiste nella conclusione del percorso narrativo ma nella rivelazione della sua geometria nascosta: fin dagli esordi, dall’epica della violenza alle frontiere del West, la vera domanda dell’opera mccarthiana non era come l’uomo sopravvive al mondo, ma come sopravvive a ciò che sa o crede di sapere. In questo senso, il dittico finale non chiude un cerchio, ma apre uno spazio di riflessione ancora più radicale: la frontiera ultima è la mente umana stessa, e il mistero più grande non è il mondo, ma ciò che esso ci consente di comprendere di noi stessi.
Angelo Cennamo