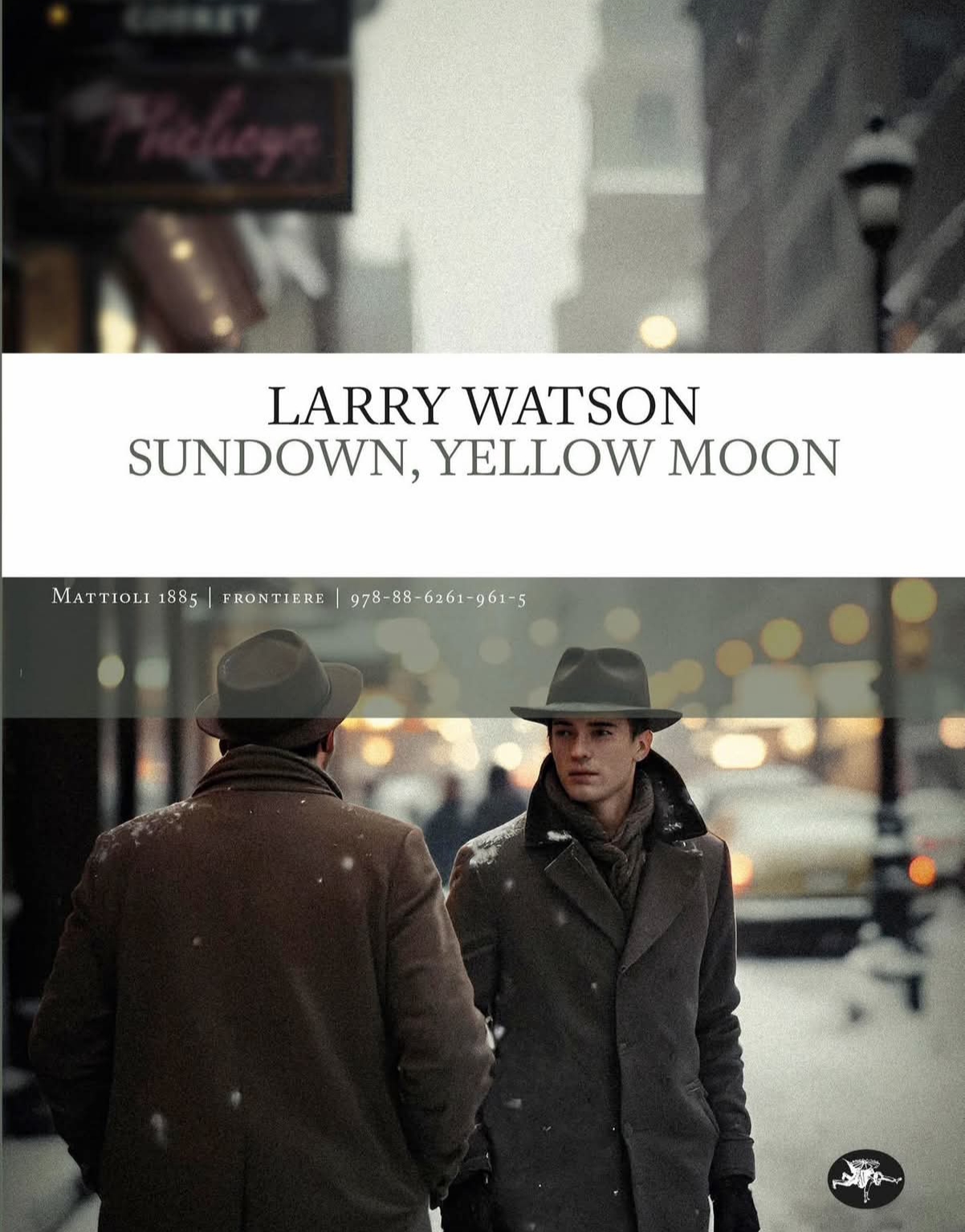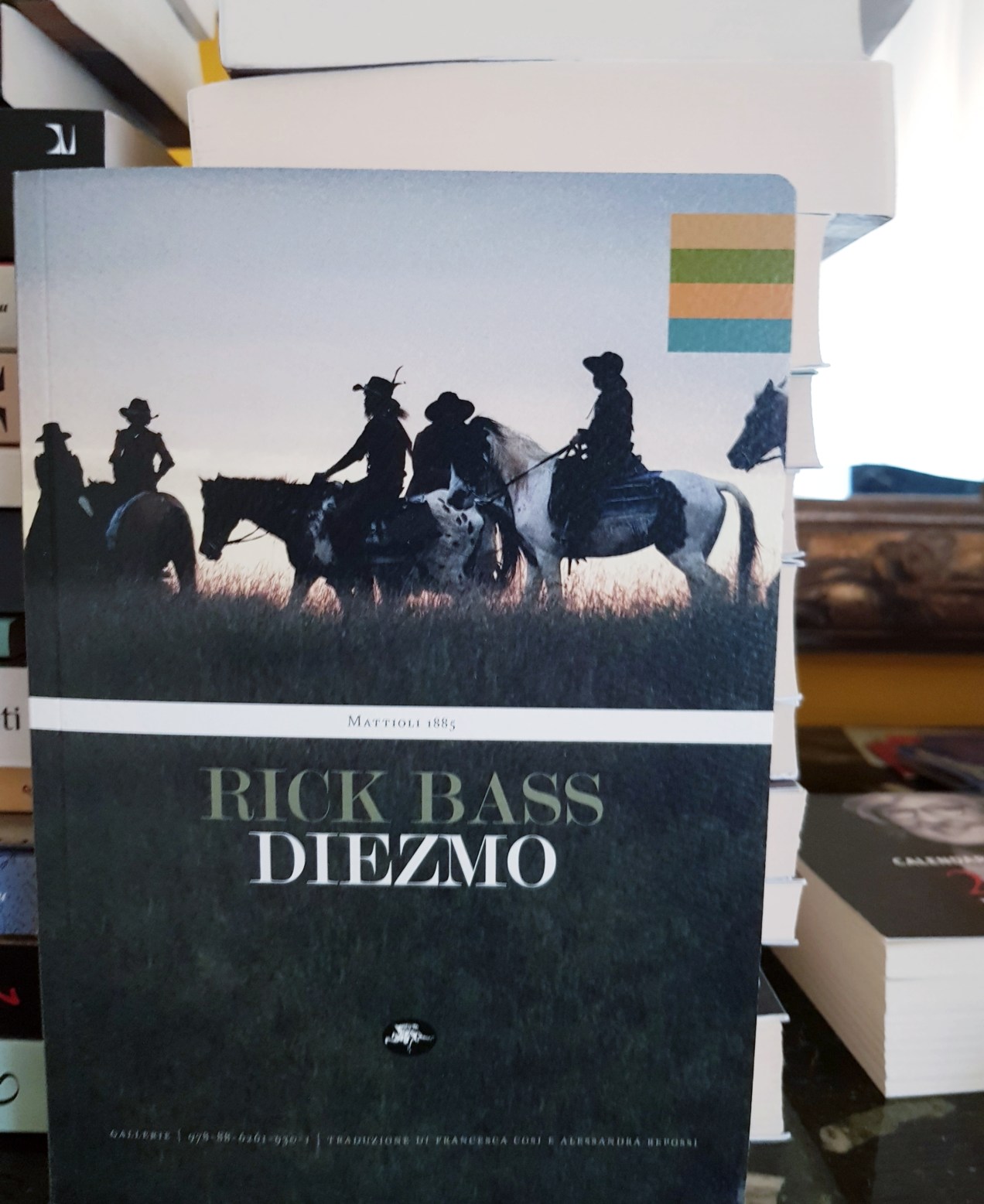Se da un lato il bilancio dell’anno libresco che sta per concludersi non pare esaltante, la bizzarra coincidenza che il 2024 finisca così come era cominciato, con il ritorno sugli scaffali, dopo molti anni, di una pietra miliare del postmodernismo, infinitamente lunga (1106 pagine) e complicata come l’altra (Le perizie di William Gaddis), è un segnale incoraggiante e in controtendenza rispetto ai soliti de profundis sulla narrativa d’avanguardia, più in generale sulla letteratura di qualità, destinata secondo certi analisti a soccombere contro l’IA, nell’indifferenza di lettori ormai disillusi o influenzati da giovani tiktoker. Il romanzo è morto, si legge ogni tanto su riviste, social, forum di vario genere. La verità è che a morire sono i romanzieri bravi, non il romanzo. Lo scorso 2 aprile è toccato a John Barth, l’uomo che insieme a William Gaddis il postmodernismo nordamericano lo ha inventato e insegnato a generazioni di altri autori, da Barthelme a DeLillo, da Foster Wallace a Vollmann. In quanti dalle opere di Barth hanno attinto, copiato, cut-uppato alla maniera di William Burroughs? Pynchon scrisse Mason & Dixon pensando a questo libro. E quando lo ultimò, mandò a Barth una copia con la dedica.
Il coltivatore del Maryland – Sot-Weed Factor – edito in questi giorni da minimum fax con la traduzione di Luciano Bianciardi e una dettagliata prefazione di Giordano Meacci, uscì la prima volta negli Stati Uniti nel 1960, e una seconda volta, riveduto e corretto, nel 1967. Barth non era nuovo a certe ripetizioni, fece lo stesso con L’opera galleggiante, il suo romanzo più noto.
La storia, ambientata tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti del diciassettesimo secolo, è una portentosa satira sull’umanità in generale e sulla vanità degli scrittori. Il bersaglio preferito da Barth è la letteratura picaresca di Sterne e Fielding; la poesia di Boccaccio, quella più metafisica di George Herbert e John Donne, autori come Smollett e Dickens. Raccontare la trama sarebbe impossibile e inutile, anche perché la sua magnificenza va colta negli anfratti incidentali dell’intera questione, soffermandosi sulle gag, i giochi linguistici e su come Barth si diverta nei mille siparietti a scardinare ogni convenzione letteraria prendendosi beffa perfino dei lettori. I tre protagonisti principali sono Ebenezer Cooke (personaggio realmente esistito, autore di “The Sotweed Factor, or A Voyage to Maryland, A Satyr”, da molti considerata la prima satira americana), la sorella gemella Anna e Henry Burlingame, un tempo precettore e corteggiatore di entrambi.
Ebenezer è uno studente svogliato e stralunato, fiero della propria verginità che difende dalle avances di uomini e donne “Per me la mia castità è più importante della stessa vita”, senza nessuna vocazione, ma stregato dalla poesia. Spedito dal padre a governare una piantagione di tabacco nel Maryland, sulle rive del fiume Choptank, Ebenezer si autoproclama “Poeta Laureato” e immagina di essere incaricato di scrivere una epica “Marylandiade”. Il viaggio a bordo del Poseidone è un’Odissea metaforica dai tanti significati, il passaggio dall’idealismo giovanile al disincanto dell’età adulta, dall’immagine edulcarata di un’America generosa e accogliente all’inganno di un paese ostile e spietato. Tra complotti politici, equivoci da commedia dell’arte, arzigogolati scambi di identità “Il mondo è un gomitolo intricato, e ci son più nodi di quel che tu credi”, il Poeta Laureato rimane coinvolto in mille avventure, rapito dai pirati e gettato in mare, catturato da nativi e minacciato di morte, scopre un diario segreto delle avventure di John Smith e Pocahontas, aiuta Henry Burlingame a ricercare la verità sulle sue origini. Barth alterna barocchismi a volgarità, analisi filosofiche a battute sul sesso e la diarrea, mescola la critica sociale con elementi di umorismo nero. L’incontro nelle prime pagine con la prostituta Joan Toast che si fa portare a letto mentre lui si rifiuta di pagarla perché si è innamorato, è esilarante. Tutta la storia lo è, ma è pervasa anche da un sentimento di innocenza misto di malinconia.
Il coltivatore del Maryland è un romanzo che esplora la dimensione tragica di un’innocenza in cui si riflettono tutte le ambiguità morali della società americana, dalla mitizzazione della nascita della nazione e delle sue figure eroiche, alle ipocrisie e agli inganni del colonialismo. È questa la finestra sul mondo che Barth apre ai suoi lettori, il dietro le quinte serio mascherato dai frizzi e dai lazzi di paradossi, anacoluti e versi spezzati. Quando ho chiuso il libro ho pensato che Il coltivatore del Maryland fosse la cosa più vicina a Don Chisciotte che avessi letto. Pur non essendo un simbolo della nobiltà perduta e della ricerca del suo significato, come l’antieroe di Cervantes Ebenezer riflette sull’illusione e sulla verità, si confronta con l’assurdo, con le contraddizioni della propria esistenza e delle proprie azioni. Don Chisciotte è un romanzo postmoderno? Non in senso stretto, ma ha aperto una strada.
Angelo Cennamo